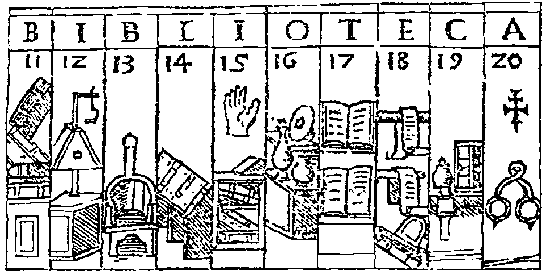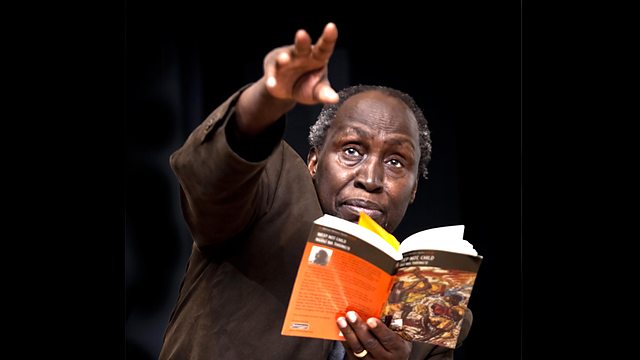Jeanne Hersch (1910-2000) – Perché ci sia senso, occorre che ci sia un’intenzione, un movimento di libertà, orientato su un valore, su qualcosa che non è, ma che merita di essere.

-
-
-
-
-
-
-
-
- L’uomo è una creatura incarnata e non può fare nulla di reale, né essere reale, se non incarnando. I suoi sogni reclamano dei gesti, le sue volontà degli atti.
-
-
-
-
-
-
-
«Ero sconcertata dal fatto di non poter abbracciare l’infinito. Mi dissi: se non posso comprendere il cielo, rappresentarlo, disegnarlo, bisogna almeno che lo immagini. Allora, di sera, nel mio letto, decisi di partire con l’immaginazione per un viaggio dentro le stelle e di vedere cosa succedeva. C’erano però sempre nuove stelle – ed ecco ciò che successe: sentii la mia scatola cranica. Fu un modo di essere riportata a me stessa, al mio essere limitato, e questa esperienza è stata probabilmente importante più tardi, quando scoprii e riconobbi in Jaspers la nozione del limite (Grenze), arrivando a fondare il mio senso della ondizione umana sulla finitezza».
Jeanne Hersch, Rischiarare l’oscuro, trad. it., Dalai Editore, Milano 2006, p. 46.
«Perché la libertà fa della condizione umana qualcosa di unico, che merita di essere amata più di ogni altra cosa. Noi non assomigliamo agli altri esseri della natura, che vengono semplicemente spinti dall’esterno, prigionieri del sistema delle cause e degli effetti. Tutto ciò che è causa ed effetto, in sé, è privo di senso. Perché ci sia senso, occorre che ci sia un’intenzione, un movimento di libertà, orientato su un valore, su qualcosa che non è, ma che merita di essere» (Ibidem, p. 78).
«Non vedo perché l’uomo, in quanto finito, non avrebbe a che fare con l’infi nito. Ciò che è inumano, sotto il pretesto di essere finiti, è di riportare tutto a qualche cosa di finito e di pretendere di esserne i padroni, come se fossimo Dio. O ancora, sotto il pretesto di raggiungere l’infinito, di volatilizzarsi nell’indeterminato, ciò che rappresenta allora il cattivo infinito, di uninfinito che equivale al nulla. Tra il nulla e l’essere dobbiamo divenire e far essere» (Ibidem, p. 84).
«L’anima senza corpo non è più l’anima, e il corpo senza anima non è più il corpo, poiché è l’incarnazione da compiere che dona a essi realtà. L’uomo è una creatura incarnata e non può fare nulla di reale, né essere reale, se non incarnando. I suoi sogni reclamano dei gesti, le sue volontà degli atti»
Jeanne Hersch, Essere e forma, trad. it., Bruno Mondadori, Milano 2008, p. 34