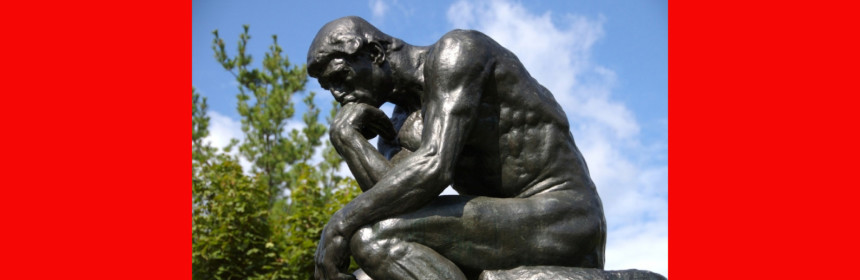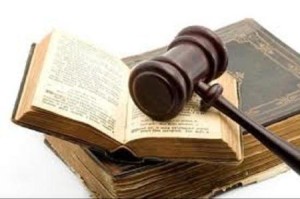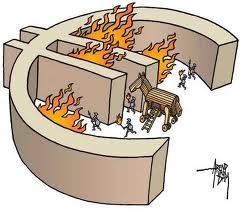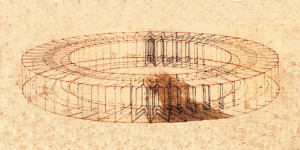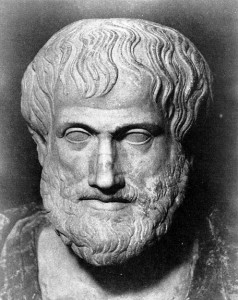Introduzione
Sia nei suoi scritti che nella vita reale, lo scrittore torinese Carlo Levi ha sempre messo in relazione la dimensione ‘teoretica’ con quella ‘pratica’. Non si è ad esempio limitato a scrivere contro il fascismo, ma si è anche concretamente impegnato contro la persistenza di tale regime in Italia invitando gli italiani a non avere paura della libertà (non a caso Paura della libertà è il titolo del primo libro da lui scritto).
Anche il rinomato pensatore bresciano Emanuele Severino vede una correlazione tra ‘teoria’ e ‘pratica’, tra fede nel divenire e «nichilismo dell’Occidente». La celebre affermazione severiniana1 dell’eternità di ogni essere «sembra comportare di diritto la più radicale riforma antropologica»2. Infatti, tra etica ed ontologia esiste un legame inscindibile nel senso che ad una determinata toeria sull’essere segue una precisa dimensione antropologica. Ed è lo stesso Severino a ritenere che il pensare determina l’azione. Egli ha in effetti evidenziato le implicazioni etiche della concezione nichilistica dell’essere.
In questo mio lavoro scandaglio gli aspetti centrali del pensiero severiniano e di quello leviano mettendoli a confronto con l’intento di elucidare i punti che li avvicinano e che valorizzano anche il pensiero di Carlo Levi, il rinomato romanziere italiano autore anche di opere teoretiche ingiustamente trascurate.
1. La fluidità del tutto
Il filosofo bresciano ritiene che non tenendosi fermo all’estrema contrapposizione dell’ente e del niente, il pensiero occidentale ha smarrito il senso dell’essere, l’ha alterato e dimenticato, e così è caduto nell’estrema contraddizione, ha ammesso l’assurdo: che il non-niente (l’ente) è niente. Questo è avvenuto perchè quell’opposizione non è stata fatta valere necessariamente, assolutamente, ma è stata limitata temporalmente. Il nichilismo consiste proprio nella nientificazione di ciò che è, nella persuasione che l’essere divenga (esca dal nulla e ritorni nel nulla), potendo pertanto non essere, e conseguentemente nella prassi (la volontà di pontenza) che scaturisce da questo convincimento.
Severino avvalora la sua tesi del nichilismo dell’Occidente rifacendosi ai filosofi greci. Infatti, una volta escluso che il senso della cosa sia metastorico, ossia che non «sia apparso ad un certo momento» della storia umana (SFP, p. 369), egli afferma che il senso (nichilistico) della cosa è stato portato alla luce dalla metafisica greca (marcatamente da Platone).
La civiltà occidentale ha obliato il senso dell’essere, perchè ha voltato le spalle all’eternità dell’essere, affermata da Parmenide. A questo proposito, il motto di Severino è‚ appunto, «ritornare a Parmenide».
La fatidica affermazione della temporalità dell’ente ha dei risvolti etici. Allora quando si è persuasi che l’ente è nel tempo, «la nascita del progetto di dominio e di sfruttamento dell’ente non solo è possibile, ma è inevitabile» (AT, p. 31). Consistendo la volontà di potenza nella volontà che l’ente sia nel tempo, la caratteristica essenziale della civiltà occidentale non può che essere proprio la volontà di potenza.
Severino approfondisce questa tematica ricorrendo significativamente alla metafora del mare proprio perché il divenire esprime «la fluidità del mondo» (LeC, p. 122). Come per navigare occorrono le imbarcazioni, e prima ancora il mare, e, anzi, prima di tutto, che si creda nell’esistenza del mare, così per dominare il mondo occorrono degli strumenti, e prima ancora la dominabilità del mondo, e, «anzi, prima di tutto, che si creda nell’esistenza della dominabilità e flessibilità del mondo; occorre la fede nell’esistenza del dominabile» (FF, p. 109). Ora, essendo il mondo dominabile in quanto fluidità o divenire (le cose escono dal nulla e ritornano nel nulla), gli abitatori del tempo manipolano, producono e distruggono la totalità delle cose, perchè hanno fede nel divenire (nella fluidità) dell’ente, perchè credono di vedere questo divenire. Sì che, se il divenire dovesse risultare impossibile e non evidente, tale dovrà risultare anche il dominio del mondo. Ma allora, credendo nell’impossibile e agendo in base a questa fede (che però non è considerata una fede dall’abitatore del tempo), non sarà azzardato affermare che sulla terra domina ormai la follia estrema, che «la storia della nostra civiltà è la storia della follia estrema» (T, p. 218). Ed è proprio a questa conclusione che Severino perviene evidenziando la tesi della fluidità del tutto propria, a suo parere, al pensiero occidentale (ma, da quanto scrive, anche a quello orientale).
2. La distruzione degli immutabili
La volontà di potenza è incarnata dalle due fondamentali espressioni del nichilismo metafisico: Dio e la tecnica (EN, p. 183). Questi due “tecnici supremi” sottopongono ad una dominazione illimitata tutte le cose. Ma oramai «Dio è morto» ed è la tecnica ad esercitare questa dominazione illimitata. Come si spiega la morte del «vecchio re»? Per rispondere a questa domanda bisogna tener conto dell’interpretazione che Severino dà della storia del pensiero occidentale e che può essere definita così: inevitabile evocazione e distruzione degli immutabili.
I pensatori greci3 hanno inteso il divenire come l’uscire dal niente e il ritornarvi, da parte delle cose del mondo. Ma la fede nel divenire delle cose implica l’imprevedibilità del divenire e questa imprevedibilità genera terrore. Tutto ciò che diviene irrompe nel mondo ed incomincia ad essere, è stato un niente. Ed «è proprio per questo suo essere stato un niente che ciò che irrompe nel mondo è assolutamente, infinitamente imprevedibile […]; e quindi è la minaccia estrema rivolta alle cose esistenti» (LC, p. 23). Per difendersi dall’angoscia del divenire gli abitatori del tempo, a partire da Eschilo, hanno predisposto come rimedio del dolore la verità, l’epistème, ossia «ciò che sta, imponendosi su ogni negazione che vorrebbe travolgerlo» (L, p. 164) e su ogni divenire (FF, p. 12). L’immutabile è quindi il rimedio del dolore. Ma, come ha visto Nietzsche, «il rimedio è stato peggiore del male» (FC, p. 11). La civiltà della tecnica ha così dovuto distruggere l’immutabile perchè rende impossibile il divenire. L’immutabile, infatti, «è il senso prestabilito al quale ogni sopraggiungente deve adeguarsi e nel quale ogni sopraggiungente è anticipato» (AT, p. 123). Ma, una volta anticipato, ciò che diviene non esce dal niente, bensì dalla propria anticipazione. Allora il niente non è più niente (viene cioè entificato) e il divenire diventa apparenza.
Morto Dio, il nuovo rimedio, cioè la scienza e la tecnica, quest’ultima essendo la scienza applicata all’industria, hanno preso il suo posto. Col suo carattere ipotetico, la previsione scientifica riesce a dominare realmente il divenire, riconoscendone l’imprevedibilità. Ma questo non vuol dire che, con l’eclissi dell’epistème, non sia rimasto alcun immutabile. L’unico immutabile che non è stato distrutto dal divenire è «la fede nell’evidenza del divenire», perchè, come ha visto l’attualista Giovanni Gentile, è «quell’unico immutabile che consente al divenire di mantenersi aperto come divenire» (AT, p. 123). Tuttavia, restando all’interno della fede nel divenire, nemmeno scienza e tecnica possono liberare dal dolore (FF, parte IV).
Per Severino si presentano in questo modo almeno due problemi cruciali. Da una parte l’uomo contemporaneo non può più trovare rimedio al dolore nell’Ente eterno, dall’altra si prospetta la mancanza di una vera via che permetta all’uomo di liberarsi dal dolore. Inevitabile porsi la domanda decisiva e darle una risposta fondata: cosa bisogna fare per poter esser felici?
Come vedremo, in Severino ogni sopraggiungente, quindi anche l’alienazione della verità, non è qualcosa che sarebbe potuto non apparire, ma qualcosa destinato ad apparire. Si pone allora il problema del tramonto dell’«isolamento della terra». Cosa si deve fare affinchè tramonti l’isolamento della terra (ossia il mondo del mortale separato dal destino della verità)? La soluzione del problema non può però emergere dalla risposta a questa domanda, anzitutto perchè la domanda: “Che fare?” sorge e trova risposta «soltanto all’interno della fede originaria in cui consiste l’isolamento della terra» (DN, p. 405). Non è restando all’interno dell’alienazione della verità che si può uscirne! La salvezza della verità, che è l’autentico significato del tramonto del nichilismo e dell’isolamento della terra, non è il risultato di una “mia” o “nostra” impresa.
«Nell’orizzonte della verità, “io”, “tu”, “noi” non dobbiamo far nulla» (DN, p. 407). Ma questo non vuol dire che, se «tutte le cose sono e divengono necessariamente», «non occorrerebbe più che noi prendessimo delle decisioni, nè che ci sforzassimo laboriosamente» (Aristotele, De interpr., 18b 31-33). Per Severino, neanche con questo modo di pensare si esce dal terreno del nichilismo. «Chi è convinto che non gli rimane altro che incrociare le braccia – chi cioè è convinto di poterle incrociare e di poter rinunciare ad agire –‚ se tutto accade necessariamente, costui è convinto di essere libero di incrociarle e di rinunciare ad agire, e isola dal Tutto la dimensione delle proprie decisioni» (DN, pp. 447-448). Se il tramonto del nichilismo e dell’isolamento della terra è destinato ad accadere, non solo non si deve far qualcosa, ma non si deve nemmeno rinunciare ad agire – e tanto meno ricorrere all’“attendismo”.
La verità non è qualcosa che deve essere messo in pratica; la liberazione dal dolore del mortale non è quindi la salvezza del mortale, ma ne è il tramonto. «All’essenza della verità non appartiene dunque la domanda: “Che cosa si deve fare?”, ma la domanda: “Che cosa è destinato ad accadere?”» (SFP, p. 32; cfr. anche G, pp. 73-78). Nel destino della verità, ogni cosa si inoltra nel cerchio dell’apparire necessariamente, con un ordine immodificabile e insostituibile. L’isolamento della terra e il nichilismo, che appaiono all’interno della verità dell’essere, non possono non accadere.
3. L’eternità dell’essere
Mi pare opportuno, a questo punto, esporre succintamente i tratti essenziali del pensiero severiniano dell’eternità dell’essere ovvero di quella che vorrei chiamare la metafisica futile di Severino. Ecco a quale conclusione conduce l’argomentazione severiniana ancorata al principio che l’essere è necessariamente se stesso: è immediatamente autocontraddittorio affermare che qualcosa non sia, che si dia un tempo in cui l’essere non sia (che l’essere non sia sé, ma il suo opposto); allora all’essere – e alle sue determinazioni – conviene immediatamente l’essere. «Risiede nel significato stesso dell’essere, che l’essere abbia ad essere» (SO, p. 317) e dunque non si può non dare «l’identità dell’essenza con sé medesima (o la sua differenza dalle altre essenze), ma l’identità dell’essenza con l’esistenza (o l’alterità dell’essenza dall’inesistenza)» (ibid.). L’essere non è dunque indifferente a che sia o non sia e la negazione di proposizioni del tipo «L’essere (l’intero) non diviene» («L’essere è immutabile») e «L’essere (l’intero) non si annulla, e non esce da una iniziale nullità» «è intrinsecamente contraddittoria» (SO, p. 519). La verità dell’essere, la struttura originaria della verità è appunto l’essere (l’eternità) dell’essere ed è l’apparire dell’autonegazione della negazione della verità. Propria alla metafisica futile è, dunque, la “confutazione” (l’élenchos) della negazione della verità dell’essere (del resto sia in ‘futile’ che in ‘confutare’ è presente la radice latina FU, ‘versare’). Autonegandosi, la negazione lascia stare ciò che nega. Se si tiene presente che il verbo latino destino, costruito sulla radice sta, esprime «il senso fondamentale dello “stare”» (DN, p. 131), in questo senso si può parlare di «destino della verità», per indicare che ciò che la verità dice non può essere rimosso, smentito, e che ogni ente, persino il più insignificante, è già da sempre e per sempre sollevato nell’essere (DN, pp. 124-125).
Tutto è eterno, tenendo presente che per Severino «l’eternità di ogni ente è l’eternità di ciò che esso è nel modo in cui lo è» (DN, p. 99). Tuttavia, tutto è eterno e ogni cosa appare e scompare. Ma quest’ultima affermazione non vuol significare che tutto diviene (appare e scompare). Vi possono essere divenire e percezione del divenire soltanto se “qualcosa” non diviene. Quel qualcosa di immoto è l’apparire trascendentale: ciò che sopraggiunge e esce dallo sfondo dell’apparire (ovvero dall’apparire trascendentale) non esce dal niente e non vi ritorna. Dunque, per Severino «il divenire che appare è sempre il divenire di una determinazione particolare, o “empirica”, del contenuto che appare» (EN, p. 98). Se l’apparire empirico (l’apparire di una determinazione particolare) entra ed esce dall’apparire, l’apparire inteso «come evento trascendentale, ossia come l’orizzonte della totalità di ciò che appare» (ibid.), non può apparire e scomparire. Gli enti possono apparire solo in quanto appare l’intramontabile cerchio, l’apparire trascendentale. Allora, divenendo, l’apparire empirico entra ed esce dall’apparire trascendentale, esce dall’ombra del non apparire ed entra nella luce dell’apparire (e viceversa). La totalità dell’ente (il Tutto) appare, quindi, processualmente, non si svela totalmente nell’apparire trascendentale (l’«eterno» severiniano non è pertanto atemporale). E in G Severino afferma poi che «il cerchio originario dell’apparire del destino esiste in una molteplicità di cerchi.» (G, p. 37)
5. Libertà e necessità
Una volta affermato che qualcosa si inoltra non nell’essere, ma nell’apparire, ossia che le variabili sopraggiungono ed escono dall’intramontabile cerchio dell’apparire, Severino deve risolvere un altro problema squisitamente filosofico: il problema della libertà. Esso può essere posto in questo modo: «le varianti seguono un destino necessario, nel processo del loro apparire e sparire, oppure appaiono, ma sarebbero potute non apparire e scompaiono ma sarebbero potute non scomparire? » (EN, p. 164). È con DN, che costituisce una notevole ‘svolta’ nel pensiero di Severino, che sopraggiunge nel cerchio dell’apparire il risolversi del problema della libertà.
In DN (e prima ancora in AT, pp. 108-111) viene testimoniata l’appartenenza della libertà all’essenza del nichilismo. Proprio con quest’affermazione inizia il cap. 1 di DN: «La libertà appartiene all’essenza del nichilismo, ossia all’alienazione che, completamente inavvertita, guida e domina lo sviluppo della civiltà occidentale» (DN, p. 19). Se la contingenza dell’ente deve essere esclusa, perchè, oltre ad ammettere la possibilità che l’essere non sia, riferisce un predicato a qualcosa che non appare, e quindi tale riferimento non può esprimere un contenuto fenomenologico, proprio per questo stesso motivo si deve escludere la contingenza dell’apparire. Severino afferma, quindi, categoricamente che «Non solo ogni decisione è eterna e tutto è già da sempre deciso, ma le decisioni che appaiono sono il destino necessario della storia e nulla accade che non sia l’accadimento del destino» (DN, p. 94). Tutto ciò che accade (anche la follia dell’Occidente) è inevitabile, necessario. «Non esiste alcuna cosa che possa sfuggire alla necessità : perchè lo sfuggirle è il negarla […] e il negarla è autonegazione» (DN, p. 124). A differenza della libertà (l’esser disponibili all’essere e al niente), la necessità non è l’essenza della servitù (non è una costrizione): «il cuore di ogni cosa è la necessità stessa della verità, che dunque non ostacola e non imprigiona le cose, ma è il luogo in cui esse sono tutto ciò che possono essere» (ibid.). Il discorso di Severino non è‚ quindi, assimilabile al fatalismo. Nel cuore della libertà – o della contingenza – dell’ente sta invece la nientità dell’ente (DN, p. 120). Tutte queste affermazioni hanno fatto dire a C. Fabro che quella di Severino è «la negazione più radicale della libertà» in cui egli si sia mai imbattuto4.
Severino ci tiene a precisare che la necessità di cui lui parla (la “necessità futile”; cfr. § 11) non ha però nulla a che vedere con la “necessità” evocata dalla cultura occidentale, perchè alla radice di quest’ultima vi è la volontà di potenza. «Nella storia dell’Occidente la “necessità” compare sin dall’inizio divisa in se stessa: come la “necessità“ degli immutabili che dominano la ribellione del divenire, e come la “necessità“ del divenire che continua a sopravvivere sotto il dominio degli immutabii dell’Occidente e prepara la loro distruzione. La volontà di potenza sta alla radice di questa divisione della “necessità“» (SO, p. 97). Entrambe le facce della medaglia della “necessità” tradizionale sono inaccetabili per il filosofo bresciano (si tratterà allora di vedere come deve essere intesa esattamente la “necessità futile” della metafisica futile di Severino).
Dato che tutti gli enti sono eterni, non è semplicemente un fatto che ognuno di essi stia insieme agli altri, ma è inevitabile che ogni ente stia insieme agli altri e che sia «un loro inevitabile compagno. È cioè impossibile che un qualsiasi ente sia, senza che un qualsiasi altro ente sia. Ad esempio, è impossibile che il cielo stellato sia e questo cantare dei grilli non sia; o che la verità dell’essere sia e la storia del nichilismo non sia» (DN, p. 113). Ogni ente è necessariamente unito ad ogni altro, ogni parte è unita al Tutto e ad ogni altra parte. Tutto ciò che appare non può non apparire. «L’apparire di tutto ciò che appare appartiene alla necessità, detta dal dire necessario […], nel senso che la negazione della necessità è autonegazione non solamente in quanto essa nega l’opposizione dell’ente al niente, ma anche in quanto essa nega l’apparire di ciò che appare» (DN, p. 129). La necessità non è soltanto che l’ente non è un niente, ma anche che l’ente appare come concreto determinarsi dell’esser ente, «è dunque l’unione tra l’opposizione dell’ente al niente e l’apparire di una molteplicità di enti determinati […]. E quell’unione è la struttura originaria della verità, ossia la struttura originaria del destino» (DN, p. 130).
6. La Gioia e la Gloria
Come visto, ciò che accade non è il prodotto di azioni, non è ciò che il mortale crede che accade; «ma ciò che accade è il destino […] che nessun dio e nessun uomo possono “tenere” e dominare» (DN, p. 489). Per Severino, le azioni non producono le “opere storiche”. «Le azioni sono astri eterni che chiamano, perchè si svelino, altri astri eterni. La “storia” è la risposta a questa chiamata. È l’intreccio del chiamare e del rispondere» (FF, p. 271). In quanto non ottiene ciò che essa vuole, la volontà fallisce nel suo intento di essere volontà, non riesce cioè ad essere volontà. Allora, avvalendosi di un verso di Eschilo (Prometheus, v. 314)5, Severino può rilevare che la téchne è molto più debole della necessità.
Ciò che manca alla volontà isolante per essere volontà – e al voluto per essere voluto – è il destino della verità. Esso è quindi eternamente ciò che la volontà non può mai riuscire ad essere. «Solo il destino è la volontà perfetta» (DN, p. 581). Nello sguardo del destino (eternamente apparente), la volontà è apparire e può volere soltanto il necessario e l’eterno: può volere soltanto ciò che è necessità che appaia, che è necessità che sia voluto. Nel cerchio dell’apparire, il destino della verità appare contrastato dall’isolamento della terra. Ma questo contrasto (questa contraddizione) appare come negato. È necessità che appaia come negato; «e questa negazione è essa stessa un tratto della necessità del destino. La volontà del destino è quindi volontà che vuole la negazione del contrasto tra il destino e l’isolamento, cioè vuole il completo tramonto dell’isolamento della terra» (DN, p. 583). Ed è necessità che (anche) questa volontà ossia che il destino appaia. La volontà del destino vuole il tramonto della volontà dell’isolamento della terra. L’apparire di questa volontà è l’apparire della necessità del tramonto dell’isolamento, che è il tramonto dell’alienazione del destino della verità. E «proprio perchè ciò che appare è il destino, la volontà che vuole il destino» «è la volontà che ha già da sempre ottenuto ciò che essa vuole» (DN, p. 582). Nel discorso non finalistico di Severino, l’isolamento della terra è quindi già da sempre tramontato, oltrepassato – ma esso, nel cerchio finito dell’apparire, contrasta il destino della verità (il dolore «è eternamente oltrepassato dalla Gioia» (PM, p. 105)).
Inoltre, non solo la contesa tra il destino e l’isolamento della terra è già da sempre tramontata, «ma ogni contraddizione è già da sempre oltrepassata»(DN, p. 588). Prima di vedere come viene precisata questa tematica nel volume La Gloria, va rilevato che ogni contraddizione appare (come negata e, insieme, come non oltrepassata) nel cerchio finito dell’apparire, che non può essere l’apparire del Tutto. Infatti, «l’apparire del Tutto è l’apparire dell’oltrepassamento di ogni contraddizione e, appunto per questo, apparire infinito» (DN, p. 589). L’apparire infinito del Tutto è il contenuto del cerchio finito dell’apparire nel suo aver già da sempre oltrepassato ogni contraddizione che avvolge tale contenuto in quanto finito. E questo contenuto è il destino, che, come contenuto finito, è la propria incapacità ad esser se stesso e che, nel suo aver già da sempre oltrepassato la totalità della contraddizione che lo avvolge in quanto contenuto finito, è se stesso. «II Tutto non è semplicemente altro dal contenuto del cerchio finito dell’apparire, ma è ciò che in verità questo contenuto è. In verità – cioè al di fuori del suo contraddirsi. II Tutto è l’esser se stesso del cerchio dell’apparire del destino» (DN, p. 590).
Ogni contraddizione è da sempre e per sempre un passato. Lo stesso mortale, in quanto contrasto tra il destino della verità e l’isolamento della terra, è già da sempre oltrepassato. E il mortale è appunto questo oltrepassamento: il Tutto è ciò che in verità il mortale è. Il Tutto è l’inconscio più profondo del mortale. Poichè ogni dolore, ogni pena è una contraddizione, il Tutto, come oltrepassamento di ogni contraddizione del finito, è la Gioia. E, quindi, la Gioia è l’inconscio più profondo del mortale.
In G, che costituisce la risoluzione di Destino della necessità, Severino arriva a dire che «la terra, inoltrandosi nel cerchio dell’apparire del destino, è destinata all’oltrepassamento della solitudine: il destino della verità è destinato a manifestarsi non contrastato dall’isolamento della terra. Questa destinazione appartiene al destino. Il disvelamento della Gioia, nel suo esser libera dal contrasto con la solitudine della terra, è la Gloria.» (G, p. 30) Ma la ‘buona novella’ (mi sia consentita l’espressione…) non finisce qui. Anzi, l’evoluzione (infinita?) del pensiero dell’eternità dell’essere fa entrare nel cerchio dell’apparire un ulteriore tassello dello stare della verità: «la Gloria è il dispiegamento infinito, nel cerchio finito dell’apparire del destino, del suo essere già da sempre totalmente dispiegata nell’apparire infinito della Totalità dell’essente. Il culmine della Gloria è dunque il dispiegamento infinito della terra oltre la solitudine della terra.» (G, p. 32)
La Gloria che compete al cerchio finito del destino «è la necessità che ogni luogo raggiunto dalla terra sia oltrepassato e che dunque sia oltrepassato anche il luogo in cui consiste la solitudine della terra.» (G, p. 92)
Dunque, con La Gloria viene palesato l’oltrepassamento infinito proprio all’apparire e allo scomparire degli eterni: «Poiché è necessario che ogni luogo incontrato dalla terra – ogni eterna configurazione o fase della terra – sia oltrepassato, il dispiegamento della terra nel cerchio del destino è infinito; e quindi, dopo l’apparire di una qualsiasi configurazione, un’infinità di configurazioni della terra attende ancora di entrare nel cerchio del destino. E l’infinità di configurazioni che la terra è destinata a manifestare è a sua volta una parte del Tutto, ossia dell’eterno oltrepassamento concreto della totalità delle contraddizioni, nel quale consiste l’apparire infinito.» (G, p. 153)
Mi pare poi opportuno notare anche che per Severino «La Gloria non è una beatitudine futura che ancora attenda di essere: il dispiegamento infinito della terra è già, eternamente; e tuttavia è destinato a inoltrarsi nel cerchio dell’apparire del destino (e nella costellazione infinita dei cerchi) lungo un percorso che non è mai compiuto. Essere la Gloria significa, per ogni cerchio dell’apparire, essere questo disvelamento infinito del dispiegamento eterno della terra – che peraltro appare già eternamente nell’apparire infinito del Tutto, sì che in quel disvelamento non incomincia ad essere nemmeno l’apparire del dispiegamento infinito […] nello sguardo del destino della verità la Gloria di ogni cerchio del destino è insieme la Gloria di ogni altro cerchio. Essere la Gloria significa essere la costellazione infinita dei gloriosi» (G, pp. 155-156)
7. Il non-nonessere
Che ne è della radicale riforma antropologica operata da Severino? Gli scritti severiniani non dicono all’uomo cosa debba fare, come agire, in quanto «è impossibile agire ‘conformemente’ al destino della verità, perché l’agire stesso, in quanto tale, è difformità dal destino, ossia è l’illusione che, all’interno della terra isolata, ha fede nel proprio essere un io che ha la capacità di far diventar altro le cose della terra.» (G, p. 77) Tutto accade necessariamente e «Già da sempre esiste dunque, ed appare, la totalità dei dolori e dei piaceri, dell’angoscia e della felicità che sono destinati a manifestarsi lungo il sentiero della solitudine della terra, e dei quali è per lo più portatore l’io dell’individuo. Ciò significa che all’Io finito del destino (ma anche all’io dell’individuo, e, poi, a ogni forma dell’io e ad ogni essente) non può accadere nulla che egli non sia già.» (G, p. 63) Carlo Levi direbbe che pertanto, non si tratta di dover agire, quanto di lasciar scorrere o fluire le cose. Vediamo come l’intellettuale torinese è arrivato ad un’argomentazione così radicale. È bene dire che l’ha fatto riferendosi al concetto di “futilità”.
I libri più prettamente filosofici di Levi sono il primo e l’ultimo da lui scritti: Paura della libertà e Quaderno a cancelli. Paura della libertà è stato pubblicato nel 1946, sebbene Carlo Levi l’abbia scritto «sette anni»6 prima, ossia in Francia, nel 1939. (Nel 1964 l’autore vi aggiunge un ulteriore capitolo: “Paura della pittura”, scritto nel 1942.) Questo libro, che Levi considera un «poema filosofico»7, è quindi stato scritto prima ma pubblicato dopo il più celebre Cristo si è fermato a Eboli8 (1945).
Da cosa ha origine l’individuo? Nel suo poema filosofico Levi risponde a questo quesito parlando della “massa”: «Più antica di ogni ricordo, più vaga di ogni speranza, più lontana della nascita, sta in tutti i cuori una oscurità illimitata […] zona nera di eterna passività, necessario nulla, dalla cui contraddizione hanno origine le cose, smisurata e senza termini» (PL, p. 105). Con un’arguta argomentazione che ricorda l’idealismo hegeliano e l’attualismo gentiliano, autori letti o riletti durante la sua detenzione nelle carceri torinesi9 perché legato all’area antifascista, Levi sviluppa questo discorso dicendo che ciò da cui l’uomo ha origine, la massa, è «un assoluto illimitato, e perciò inesistente, come il suo opposto, l’assoluta finitezza»; si tratta di «un concetto che contraddice se stesso», «è il nulla» (PL, pp. 105-106).
Da questo nulla, da questo «caos», nasce ogni individuo. L’uomo «viene dalla massa per differenziarsi» (PL, p. 23). La massa, dunque, è la condizione prima di ogni individualizzazione (o differenziazione, o rinascita). Levi la considera anche la « forma delle forme», «quella forma che sta sotto a tutte le forme e che le comprende tutte, che non ne ha nessuna in modo determinato, ma che ha la possibilità di tutte le forme»10.
In Quaderno a cancelli11 Levi denomina «la pura Probabilità, o Futilità» (QC, p. 110) il punto da cui si origina il processo di individuazione visto che il risultato specifico di tale processo (il punto di arrivo) è ‘aperto’: «tutto è realmente possibile» (Cristo, p. 98). L’indeterminato, il concetto che contraddice se stesso, sembra essere il non essere, il cui opposto è l’essere. In realtà la massa (o l’indistinto originario) è la sintesi di essere e non essere, cioè un’entità che «è e non è insieme, e il suo non essere non ha per opposto l’essere, ma tutt’al più un non-nonessere (di cui non vedo il significato) : essa insieme, non dialetticamente, non è e non-non è» (QC, p. 110). Infatti, come dice Hegel nella Scienza della logica, il puro essere ed il puro niente è lo stesso; l’inizio contiene dunque entrambi, l’essere e il niente: l’unità di essere e niente.
A quello di non-nonessere (alla massa) Levi associa il concetto junghiano di «indistinto originario»: «Esiste un indistinto originario, comune agli uomini tutti, fluente nell’eternità, natura di ogni aspetto del mondo, spirito di ogni essere del mondo, memoria di ogni tempo del mondo. Da questo indistinto partono gli individui, mossi da una oscura libertà a staccarsene per prender forma, per individuarsi – e continuamente riportati da una oscura necessità a riattaccarsi e fondersi in lui. Questo doppio sforzo sta fra due morti: la caotica prenatale, e il naturale spegnersi e finire. Ma morte vera è soltanto il distacco totale dal flusso dell’indifferenziato, vuota ragione egoistica, astratta libertà – e, all’opposto, l’incapacità totale a differenziarsi, mistica oscurità bestiale, servitù dell’inesprimibile» (PL, p. 23).
L’uomo può ritenersi ‘vivo’ quando prende le mosse dalla massa e le dà forma, senza però approdare nel suo opposto, l’astratta determinatezza : «i soli momenti vivi nei singoli uomini, i soli periodi di alta civiltà nella storia, sono quelli in cui i due opposti processi di differenziazione e di indifferenziazione trovano un punto di mediazione, e coesistono nell’atto creatore» (ibid.). Per Levi, l’animo umano oscilla tra l’indeterminatezza (la massa) e la determinatezza (l’individualità). E la dialettica massa-individualità ha una valenza storica e sociale, oltre che esistenziale: «Quello che è vero per l’individuo, è vero per la società e per lo stato» (PL, p. 55). Allora, il tendere come anche l’aver teso verso la categoria dell’indeterminatezza oppure della determinatezza concerne non soltanto la vita del singolo (la storia individuale), bensì altresì la storia del genere umano.
Un individuo – e un popolo, ed il genere umano – fruisce di autentica libertà nel preciso momento in cui riesce – creativamente – a mediare gli opposti differenziazione-indifferenziazione, a dare forma all’informe. La sintesi degli opposti (la ‘doppiezza nell’unità’), il processo di individuazione, funge da garanzia di libertà ed autonomia.
8. Opposizione tra arte e religione
Levi carica il processo di individuazione di valenze filosofiche e psicologiche. Ma non solo. Esso va infatti rapportato ai concetti di ‘sacro’ e di ‘religioso’: «non potremo intendere nulla di umano se non partiremo dal senso del sacro: il più ambiguo e profondo e doppio e vermaquilino dei sensi, l’oscura continua negazione della libertà e dell’arte, e, insieme, per contrasto, il generatore continuo della libertà e dell’arte. Né potremo intendere nulla di sociale se non partiremo dal senso del religioso, questo figlio poco rispettoso del sacro.» (PL, p. 21)
Il sacro e la religione non coincidono. Anzi, essi costituiscono un’altra coppia di opposti: mentre la prima dimensione connota l’informe e l’indistinto, la seconda ha una valenza negativa in quanto determinazione astratta e mutazione del «sacro in sacrificio» (ibid.). Tanto il sacro quanto la religione sono dei mezzi del processo di individualizzazione, ma ognuno in un diverso e opposto modo. «Il senso, e il terrore, della trascendenza dell’indistinto, lo spavento dell’indeterminato in chi è nello sforzo di autocrearsi e di separarsi, questo è il sacro.» (PL, p. 24) Significativo il riferimento leviano allo sforzo di autocrearsi e di separarsi, ossia alla creazione. Per scoprire se stesso e il mondo, per autocrearsi, l’uomo deve partire dal caos (dal disordine, dall’informe) per generare il cosmos (l’ordine). L’uomo ha da essere ‘creatore’, ossia – platonicamente – Demiurgo, cioè Artista (Artigiano). Nei suoi scritti Levi ricorre, come Alain, a termini come ‘produttore’ o Contadino per designare la sua visione dell’individuo ‘sano’ che, in quanto tale, non ha reciso – e tanto meno ha intenzione di recidere – il cordone ombelicale che lo lega all’indistinto originario.
Al processo creativo fa da ostacolo la religione. «Religione è la sostituzione all’inesprimibile indifferenziato di simboli, di immagini reali e concrete, in modo da relegare il sacro fuori della coscienza, porgendo ad essa degli oggetti finiti e liberatori.» (PL, p. 24) La religione non mira a favorire l’invenzione della verità e la libertà dell’uomo. Al contrario, essa è «un mezzo che tende, per liberare lo spirito dal senso terrificante della trascendenza, a sostituirla con simboli visibili, idoli.» (ibid.) Dal punto di vista storico, con questa operazione si è dato concretamente il via libera alla tirannide, alla divinizzazione (deificazione) dello Stato, alla hegeliana superiorità dello Stato sull’individuo. La religione protende essenzialmente a far obliare l’indistinto originario, l’autentico punto di partenza di ogni creazione, della libertà creatrice.
La libertà umana non può né consistere «nella sostituzione all’uomo del suo simbolo, del suo idolo» (PL, p. 25) – ossia nella deificazione dello Stato –, né tanto meno nell’individualismo astratto in cui non si dà alcun senso di comunità o Stato. La libertà dell’uomo implica il continuo (o ciclico) ritorno ad un indistinto originario il cui oblio implica lo staticizzarne il fluire eterno. Queste prerogative vengono salvaguardate dall’arte, che è allora autentica espressione della libertà creatrice dell’uomo.
Dunque, l’affermazione e la determinazione dell’uomo possono avvenire – e di fatto sono avvenute nel corso della storia – in due modi radicalmente diversi: sotto la spinta della religione oppure della poiesis. «La storia non è che la vicenda eterna del faticoso determinarsi della massa umana, e del suo risolversi in stato, poesia, libertà, o del suo celarsi in religione, rito, costume; e del ricrearsi continuo della massa dall’inaridire degli stati, dal cristallizzarsi delle religioni.» (PL, p. 106) Le due possibilità di concretizzazione del processo di individualizzazione di cui parla Levi, con evidenti riferimenti al pensiero vichiano, non possono realizzarsi allo stesso tempo, pena la contraddizione. Infatti, mentre la religione «è la limitazione simbolica dell’universale», «è la manifestazione certa di una servitù liberatoria e divina», «è rituale fisso», l’arte non può che essere «l’espressione concreta» dell’universale, «la voce stessa della libertà umana», «mitologia». Date queste premesse, Levi non può che trarre la seguente conclusione: «L’espressione religiosa è dunque l’opposto della espressione poetica» (PL, p. 69). Ricorrendo al religioso, l’uomo si appiglia alla «certezza», ad una realtà «trascendente e permanente», caratterizzata dall’immutabilità (PL, p. 71).
Tuttavia proprio l’immutabilità risulta essere espressione di inautenticità non consentendo all’uomo di essere ‘umano’, di essere cioè se stesso e perciò è fonte di alienazione. Invece l’espressione artistica è indice di «creazione»(PL, p. 73) e libertà, ossia propriamente di mutevolezza e divenire. La religione limita la creazione e la libertà umana (impone loro dei limiti determinati, fissi); l’idolo, la divinità immutabile, impone la sua legge alla libertà e alla creatività, riducendole così in schiavitù, non facendole più essere autonome. «Figurazione religiosa ed espressione artistica sono antitetiche: questa, creazione tutta umana, non conosce altra legge che la propria e implicita ed eternamente mutevole, anche quando raffiguri gli oggetti della religiosità: quella ha per suo compito di relegare l’arte sull’altare della certezza e della durata, di legarla nei suoi stessi schemi, perché essa continui; di sacrificarla, acciocchè essa possa diventare un legame simbolico, e quindi una pratica comunicazione tra gli uomini. L’opposizione è quella di creazione e di limite» (PL, pp. 72-73) (perciò, precisa Levi, non esiste, «a rigore, un’arte religiosa: contraddizione in termini» (PL, p. 70)).
9. La morte degli dei (il Naufragio del Piloro)
Come detto, per Levi l’espressione artistica «non conosce altra legge che la propria»: l’arte non è soggetta a nessuna legge estrinseca, non è soggetta ad altra legge che la propria, ed ubbidisce unicamente ad essa. Levi precisa che questa legge consiste nella libertà creatrice che prende le mosse dall’eterno fluire e dalla mutevolezza e che conserva queste peculiarità dell’umano. In altri termini, arte è sinonimo di divenire. In quanto tale, per usare una felice espressione di Gustavo Bontadini, «il divenire come legge nega ogni legge del divenire, ogni legge che determini il contenuto del divenire.»12 Se l’arte si rifacesse ad una legge diversa dalla propria, se venisse inquadrata in schemi fissi, essa cesserebbe di essere libera (creazione). La sua legge (o autonomia) non le può consentire di accettare nessun’altra legge all’infuori della propria, ma, anzi, le impone di liberarsi da ogni altra imposizione, di distruggere ogni altra legge. Altrimenti l’arte non sarebbe arte, l’umano non sarebbe umano, ossia libertà creatrice e divenire. Il rifiuto della religione, la nietzscheana distruzione degli dei («Dio è morto») ovvero, per utilizzare la terminologia di Emanuele Severino, la distruzione degli immutabili è dunque necessaria perché essi – come visto – rendono impossibile o illusorio il divenire, la libertà. Soltanto con la distruzione degli immutabili (degli dei) sono possibili l’arte e l’individuo, è possibile forgiare (determinare) in modo originale e ‘concretamente’ l’indeterminato. Con la morte degli dei è possibile creare od inventare la verità13. È questa la conclusione a cui perviene Carlo Levi fin da Paura della libertà. (Questa profonda tesi racchiude la chiave di lettura delle scelte e delle opere del Levi scrittore, pittore e politico.)
L’arte, di cui Croce proclama l’autonomia, non può quindi essere asservita e assoggettata. E ciò vale per qualsivoglia disciplina e dimensione umana. Il ‘detto’ che sintetizza alla perfezione il pensiero leviano è: «muoiono gli dei, si crea la persona umana» (PL, p. 134).
Per liberare l’uomo dalla paura della libertà, per salvare la libertà (filosoficamente, per ‘salvare i fenomeni’), Carlo Levi afferma coerentemente la necessità di negare gli dei immutabili. Difatti il divenire come legge nega ogni legge del divenire, cioè ogni legge che determini il contenuto del divenire, perché altrimenti il divenire sottosta ad una legge a lui estrinseca che gli impedisce di essere espressione di creatività, libertà e novità: «perché l’idolo viva, ogni azione autonoma è sacrilega e mortale: solo è necessaria la obbedienza» (PL, p. 113). Dunque, l’idolo (la religione, lo Stato, ecc.) dice a ciò che è ancora informe come deve essere formato, a ciò che è come deve essere oppure non essere, impedendo ogni possibilità di libertà creatrice. Nel caso del dio Stato, «la sua lingua è legge, e ogni legge è religiosa: poiché non è la norma interna di un’azione singola; ma la norma esterna e arbitraria di ogni possibile azione […]. Ogni autonomia, ogni atto creatore, è per sua natura, fuori di questa legge, nemico dello Stato, sacrilegio.» (PL, p. 112) La filosofia dello scrittore piemontese non potrebbe essere meno esplicita e limpida su questo punto!
La conclusione che si prospetta? Se ci si affida agli dei «finisce la libertà della legge morale interna alle cose, per iniziarsi la servitù della legge esterna, della legge religiosa» (PL, p. 121).
In uno scritto14 successivo a Paura della libertà Levi ritorna sul tema della morte degli dei descrivendo minuziosamente i vari elementi raffigurati in quadri e disegni concernenti il “Naufragio del Piloro”: «Un oceano artico, con balene, iceberg, gabbiani, pesci, foche, e poi onde nascenti, fino alla tempesta; e una nave [il Piloro], prima dolcemente navigante nella calma del mare, con tutte le sue vele gonfie; e poi il vento, il fulmine, l’albero maestro spezzato, le barche di salvataggio inutili, gli uomini vanamente cercanti scampo nel mare terribile, la poppa che si solleva mentre la nave precipita nell’abisso.» (corsivo mio)
Tuttavia il Naufragio del Piloro non si limita semplicemente a rievocare l’inabissamento di una grande nave. Oltre al senso letterale, affiora quello simbolico. Ciò che viene inghiottito dalle onde del «mare terribile» è sì una nave, che Ercole Levi, padre di Carlo, denominò il Piloro; ma Carlo Levi puntualizza che «il piloro era essere Padre» (questa la dimensione psicologica della tematica in questione). Non solo. Egli rileva inoltre che quel disegno simboleggia l’«infinita possibilità di creazione del reale» e gli fa vedere, «con estasi e rapimento, la realtà farsi, sotto le mani, forma e figura»; e insieme gli fa accorgere «con dolore, repulsione, angoscia, dell’errore, della contraddizione, della volgarità inespressiva che sta dentro la realtà, e nega la poesia.»15
Nel Naufragio del Piloro Levi rappresenta , quindi, in modo simbolico oltre che figurativo, la morte degli dei, la nietzscheiana ‘morte di Dio’. Il divenire è ovviamente rappresentato dal mare. Inizialmente, sotto la dominazione degli dei immutabili, è la calma del mare a regnare; è cioè l’immutabile a dominare le onde del mare. Ma il mare non può essere continuamente calmo, la sua forza ed il suo flusso non possono essere arrestati assolutamente. Ecco emergere pertanto le onde nascenti, indicanti l’affievolirsi della paura della libertà. La ribellione del divenire agli immutabili che intendevano farlo scomparire (negarlo) è a quasto punto inarrestabile: inevitabile la tempesta, lo spezzarsi dell’albero maestro, l’inabissamento della nave. Gli dei sono troppo più deboli del divenire.
Ritengo pertanto che Carlo Levi vada forzatamente annoverato tra i pensatori moderni che, come vuole Severino, hanno espresso la necessità della distruzione degli immutabili. Oltre a Nietzsche, Leopardi e Gentile, autori ai quali si riferisce il filosofo bresciano, va aggiunto Carlo Levi.
10. Avvenimento versus azione
Per Severino, credendo nel divenire delle cose il mortale, avendo preteso recidere il cordone ombelicale che lo lega necessariamente al destino della verità, crede anche di manipolarle e di distruggerle. Vive conseguentemente nell’alienazione costituitata dal nichilismo (ossia il “Venerdì Santo” che precede la “Pasqua”).
Per Levi, l’uomo che si libera dagli dei non si separa da sé, non si aliena. Al contrario, riconquista l’immortalità ed il paradiso perduti vivendo «in un tempo ritrovato, dove non vi è prima e poi, giorno e notte, ma dove ogni attimo è eterno»(PL, p. 125). Avendo ritrovato il tempo originario (o perduto), proprio alla massa (all’indistinto originario) e pertanto da identificare con «l’eternità» o forse con «il nulla» (Or., p. 15), l’uomo è libero di creare. Ne L’Orologio16, Levi qualifica con l’appellativo di Contadini gli individui « che fanno le cose, che le creano, che le amano »(Or., p. 166). Il Contadino ovvero l’Artigiano / Demiurgo di Platone dà ordine al disordine percependo (vivendo e pensando) il tempo vero, immagine dell’eternità, «immagine pura di un fluire eterno» (Or., p. 10) ed unica garanzia della vita(lità) dell’individuo. Al Contadino si oppone il Luigino, il parassita che, obliando «l’oscuro fondo vitale di ciascuno di noi» (Or., p. 165) e non creando, per vivere si nutre di chi produce. L’etica dei Luigini si distingue nettamente da quella dei Contadini. E questa opposizione si basa su una diversa percezione del tempo. I Luigini sciolgono il legame che lega ogni essere all’indistinto originario e in questa maniera frazionano l’unità originaria e, dunque, il tempo immagine pura di un fluire eterno. Di conseguenza si affidano al ritmo matematico dell’orologio senza comprendere di vivere nell’alienazione della verità, di intraprendere il sentiero dell’alienazione. I «due tempi» seguono «un altro ritmo» ed obbediscono «ad altre leggi». Essi sono, «fra loro, incomunicabili» e già in Cristo si è fermato a Eboli, Levi rileva che essi danno luogo a due opposte civiltà (Cristo, p. 72).
Ma la distinzione tra due atteggiamenti esistenziali opposti figura già in Paura della libertà, proprio dopo che Levi ha trattato dell’indistinto originario. Lo scrittore torinese distingue l’«azione» dall’«avvenimento»: l’azione è «frutto della differenziazione completa: l’individuo, staccato dal tutto, si muove per darsi forma, e il suo movimento è incomprensibile se non a lui.» (PL, p. 23 (corsivo mio)) L’azione concerne quindi i Luigini (o, nel caso di Severino, gli abitatori del tempo). «L’avvenimento è invece il prodotto dell’attività umana in quanto creatrice, ricca cioè nello stesso momento di differenziazione e di indifferenziazione, di individualità e di universalità[…], libera insieme e necessaria» (PL, pp. 23-24). L’avvenimento è pertanto proprio al Contadino, all’individuo vero.
Pur non anticipando la concezione severiniana dell’eternità dell’essere, le considerazioni leviane sulla dimensione temporale individuano l’importanza del concetto di eternità e della conseguente necessità di distinguere due opposte concezioni del tempo fondanti, ciascuna, un’etica diversa. In effetti, il tempo dell’orologio è l’opposto del tempo vero, della contemporaneità dei tempi: se nella dimensione meccanica del tempo si può distinguere il ‘prima’ dal ‘poi’, nella dimensione durativa del tempo – simile alla crociana contemporaneità ed alla bergsoniana durée réelle – i tre tempi (passato, presente e futuro) esistono contemporaneamente (sviluppando le considerazioni sul tempo fatte da Sant’Agostino sulla base della teoria platonica del tempo immagine dell’eternità17, Levi avrebbe potuto dire che essi sono presenti, allo stesso tempo). Il tempo meccanico «non fluisce, ma scatta in una serie di atti successivi, sempre uguali e monotoni»(Or., p. 11). Indubbio, allora, che il Luigino non può assolutamente essere un creatore.
11. La «necessità futile»
Le riflessioni contenute in Paura della libertà ritornano, come ha ammesso lo stesso autore, nei suoi successivi libri. Il cerchi si chiude con Quaderno a cancelli, l’ultimo libro scritto da Levi. In questa sorta di zibaldone, scritto in stato di cecità, Levi passa in rassegna varie tappe della sua vita, riespone ed ‘aggiorna’ molti aspetti e temi centrali del suo pensiero, della sua posizione filosofica.
Anche in Quaderno a cancelli egli parla dell’ «infinito ritorno a un indistinto anteriore prima del tempo […] fatto di archetipi prima di ogni possibile trasgressione» (QC, p. 222; chiaro il riferimento alla teoria junghiana degli archetipi) come anche della massa da cui ha origine la persona umana. Ora, come visto, questo punto di partenza viene denominato « la Futilità » o anche la «pura Probabilità» che «è e non è insieme, e il suo non essere non ha per opposto l’essere, ma tutt’al più un non-nonessere» (QC, p. 110). Ma nella realtà dominano la divisione e la separazione del contemporaneo che hanno dato inizio al tempo degli dei. In Paura della libertà Levi fa riferimento al Paradiso perduto ed in Quaderno a cancelli si riferisce particolarmente alla rottura della «naturale unità della sfera materno-filiale» (QC, p. 29), alla Morte della Madre. In entrambi i casi si tratta del distacco dal tempo prima dei tempi e della conseguente perdita dell’immortalità da parte dell’uomo. La vera differenza tra i due libri (il primo e l’ultimo di Carlo Levi) consiste nel fatto che mentre il primo «non è solo un lamento funebre sulla civiltà che scompare, ma anche un volume folto di idee sulla rinascita e la riscoperta della civiltà»18, ossia indica all’uomo il sentiero del Giorno, il secondo libro non ritiene più recuperabile – quanto meno per l’autore – l’immortalità perduta. Inevitabile, quindi, l’attardarsi sul sentiero della Notte19.
Le affinità con il pensiero severiniano non devono sorprendere più di tanto. Infatti, la loro riflessione trova il suo fulcro da una parte nell’eternità e nell’unità del tutto, dall’altra nella critica della civiltà che ha voluto dividere l’indivisibile. Entrambi i pensatori si oppongono alla concezione classica del tempo implicante il “prima” ed il “poi” poichè questa interpretazione ‘malata’ della dimensione temporale implica uno stile di vita alienato, in quanto in tal modo l’uomo recide (o crede di recidere) il cordone ombelicale che lo lega all’eterno, dimentica cioè che l’inconscio dell’inconscio è costituito dall’eternità dell’essere. Al di là (o al di sotto) del tempo meccanico esiste il tempo vero, immagine pura di un fluire eterno (per Levi) o apparire e scomparire dell’eterno (per Severino). La dimensione psicologica affiora esplicitamente sia in Levi che in Severino ed entrambi propongono una concezione della felicità analoga a quella plotiniana, secondo cui l’uomo o, meglio, la parte superiore dell’anima umana, risiede stabilmente nell’intellegibile (nell’eterno), fonte di felicità: per Severino, l’uomo è da sempre e per sempre ancorato all’eterno (è eterno), alla gioia, perfino nell’oblio della verità dell’essere; per Levi, la felicità «è vano cercarla: perché non è raggiungibile che da chi ce l’ha»(QC, p. 203). Ed in Cristo si è fermato a Eboli parla in questi termini della sua consapevolezza dell’essere ancorato all’indistinto originario e della felicità che ne deriva: «Mi pareva di essere staccato da ogni cosa, da ogni luogo, remotissimo da ogni determinazione, perduto fuori del tempo, in un infinito altrove. Mi sentivo celato, ignoto agli uomini, nascosto come un germoglio sotto la scorza dell’albero: tendevo l’orecchio alla notte e mi pareva di essere entrato, d’un tratto, nel cuore stesso del mondo. Una felicità immensa, non mai provata, era in me, e mi riempiva intero, e il senso fluente di una infinita pienezza.» (Cristo, pp. 198-199)
Non è casuale che i due pensatori italiani considerino «invidiosi» (AT, p. 22) e «gelosi» gli dei dell’Occidente (QC, p. 208) che negano l’eternità agli altri esseri per farne una prerogativa esclusivamente loro. Essi si scagliano contro gli dei del Possesso, contro i Padroni che considerano tutti gli altri esseri dei servi. Non per niente, i due filosofi ‘antitradizionalisti’, seppure su una base in parte diversa, sono concordi nel ritenere che non ci si possa impossessare delle cose, parlarne come di qualcosa di ‘mio’ o di ‘tuo’. Levi si rifà sintomaticamente ad una realtà concreta, alla lingua Ronga : «Nella lingua Ronga / non puoi dire mio / così nessuno può offenderti nelle cose / nè privarti di quello che non hai. / Non un uomo, molto meno un dio / parola svanita di inchiostro / dove il pane non è nostro / e nostro non può essere il Padre» (QC, p. 22).
Alla logica del possesso e dell’utile, tanto Severino quanto Carlo Levi antepone la logica del futile: «ma la Futilità / non è utile nè inutile / non appartiene e non possiede / non serve (non è serva) / non è tenuta e non tiene / a nessuna di queste cose pertiene.» (QC, p. 25) Ogni ente è se stesso, è eterno. Nessuna gerarchia ontologica è pertanto ammissibile. E nessuno (nessun eterno) può appropriarsi dell’eterno. Pertanto, Emanuele Severino non può che essere considerato, insieme a Carlo Levi20, un assertore del pensiero futile: per entrambi si tratta di “lasciar scorrere le cose” (etimologicamente, “futile” significa “che lascia scorrere”: basti pensare al vaso Futile delle Vestali). Sebbene sia soltanto lo scrittore piemontese a parlare di futilità – in relazione al punto di partenza di ogni determinazione umana –, per il filosofo bresciano non si tratta di suggerire all’uomo una norma di vita. Allora, anche per Severino centrale è la nozione di futilità. La differenza tra i due pensieri futili consiste in questo: se per Levi la futilità è il punto di partenza di un processo che sfocia nella creazione, nell’«avvenimento», nell’impegno concreto, per Severino essa costituisce vuoi il punto di partenza, vuoi il punto di arrivo del suo pensiero: tutto accade (entra ed esce dall’apparire trascendentale) secondo “necessità”.
Allora uno dei principi fondamentali del pensiero severiniano è, propriamente, quello di futilità: la futilità del tutto, ossia il necessario apparire e scomparire dell’eterno. Si prospetta quindi quello che solo in apparenza può essere considerato un paradosso (‘etico’): l’uomo guidato dal principio di futilità. Ritengo pertanto che piuttosto che parlare di neoparmenidismo – o di spinozismo –, come confermato anche dalle pagine di G prese in considerazione nel caso del pensiero di Severino sia più appropriato parlare di metafisica o pensiero futile. Inoltre, se per etimologia ed assonanza il termine ‘fluidità’ deriva proprio da “futilità”21, non resta che opporre, al senso greco del divenire e della fluidità esplicato da Severino, il senso severiniano del divenire e della fluidità: il necessario apparire e scomparire dell’infinità degli eterni (che si oppone alla ‘modernità liquida’). Visto poi che il filosofo bresciano distingue la “necessità” di cui parla la tradizione occidentale dalla sua nozione di “necessità”, reputo che quest’ultima possa essere considerata, sulla scorta di quanto sostiene Levi in merito al non-nonessere, la «necessità futile» (QC, p. 50): propria del pensiero severiniano è da un lato la necessità della confutazione della negazione della verità, dall’altro la necessità dell’ apparire e dello scomparire degli enti come base dell’essere dell’uomo (nel caso di Levi, proprio dell’“indistinto originario” è il necessario fluire eterno da cui deve emergere la creatività umana). Quella severiniana è quindi una necessità doppiamente “futile”.
Severino ha avuto modo di dire che «Certo, non si può rendere pietra ciò che è fluido. Questo è l’errore della tradizione dell’Occidente, che al di sopra della fluidità del mondo (e dunque riconoscendola) pone la pietra di Dio. Ma quando si riconosce che il senso greco della fluidità, cioè del divenire, è il contenuto di un sogno […], allora ciò che è impietrito è solo il sogno del divenire, è solo un divenire dipinto, e quindi, affermando l’eternità di tutte le cose, non si impietra più una fluidità reale, ma ci si trova in ac-cordo col cuore delle cose, che ‘non trema’ e che via via va mostrandosi.» (LeC, pp. 122-123) Bisogna però aggiungere che affermando l’eternità del tutto, si arriva ad affermare – conseguentemente – la futilità / fluidità del tutto (prima valenza della “necessità futile”) come anche l’inconfutabilità della verità (seconda valenza della “necessità futile”).
Pertanto, a quella che chiamo la metafisica futile di Severino fa da controparte, parallelamente, un’antropologia futile. L’uomo è necessariamente un essere “futile”, ovverosia “inaffidabile”. Infatti, in opposizione a Martin Heidegger, che parla di “Gelassenheit”, l’uomo severiniano lascia fluire l’essere (per Heidegger si tratta invece di lasciar essere gli enti). Di conseguenza, per Severino l’uomo non può né agire né prendere decisioni in quanto espressioni del nichilismo dell’Occidente. L’uomo, eterna apparizione dell’essere, sa che la verità non può essere messa in pratica. A tale uomo sono poi estranee tanto la fede nel divenire quanto la fede nella verità. La futilità del tutto non è quindi una fede, bensì la verità inconfutabile.
Carlo Levi, invece, pensa ad uomo che, dopo essersi immerso nel mare della “futilità”, agisce, crea ed “inventa” la verità: l’uomo vero è un Contadino, un Demiurgo.
(Mythenstrasse 31, CH-6020 Emmenbrücke – Svizzera; sperd-to@gmx.ch)
Note
1 Cito gli scritti di Emanuele Severino utilizzando le seguenti abbreviazioni (come viene indicato, solo per gli scritti che hanno conosciuto una nuova edizione ampliata le citazioni non si riferiscono alla prima edizione, ma alla nuova edizione): AT = Gli abitatori del tempo, 2a ed., Armando, Roma 1981; DN = Destino della necessità, Adelphi, Milano 1980; EN = Essenza del nichilismo, 2a ed., Adelphi, Milano 1982 ; FC = La filosofia contemporanea, Rizzoli, Milano 1986; FF = La filosofia futura, Rizzoli, Milano 1989; FM = La filosofia moderna, Rizzoli, Milano 1984; G = La Gloria, Adelphi, Milano 2001; L = Oltre il linguaggio, Adelphi, Milano 1992; LC = Legge e caso, Adelphi, Milano 1979; LeC = La legna e la cenere, Rizzoli, Milano 2000; PM = II parricidio mancato, Adelphi, Milano 1985; SFP = Studi di filosofia della prassi, 2a ed., Adelphi, Milano 1984; SO = La struttura originaria, 2a ed., Adelphi, Milano 1981; T = Téchne, Rusconi, Milano 1979.
2 C. ARATA, L’aporetica dell’intero e il problema della metafisica, Marzorati, Milano 1971, p. 169.
3 Sull’umanesimo della metafisica greca, cfr. la trilogia di L. GRECCHI, L’umanesimo della antica filosofia greca, Petite Plaisance, Pistoia 2007; L’umanesimo di Platone, Petite Plaisance, Pistoia 2007 e L’umanesimo di Aristotele, Petite Plaisance, Pistoia 2008.
4 C. FABRO, L’alienazione dell’Occidente, Quadrivium, Genova 1981, p. 151. Su E. Severino, cfr. inoltre L. MESSINESE, Essere e divenire nel pensiero di E. Severino, Città Nuova, Roma 1985; A. ANTONELLI, Verità, nichilismo, prassi, Armando, Roma 2003; L. GRECCHI, Nel pensiero filosofico di Emanuele Severino, Petite Plaisance, Pistoia 2005; AA.VV., Le parole dell’Essere. Per Emanuele Severino, Bruno Mondadori, Milano 2005; D. SPERDUTO, Vedere senza vedere ovvero Il crepuscolo della morte, Schena editore, Fasano di Brindisi 2007.
5 Su Eschilo, cfr. D. SPERDUTO, Eschilo in G. D’Annunzio, E. Severino e L. Grecchi, in AA.VV., Filosofia ed estetica, Petite Plaisance, Pistoia 2007, (Koiné, XIV), pp. 79-89.
6 C. LEVI, Paura della libertà [PL], Einaudi, Torino 1980 (1a ed. 1946), p. 12.
7 «Questo è veramente il più importante dei miei libri, nel senso che non è un racconto, e d’altra parte per me è assurda questa definizione di generi, oggi. Io stesso non saprei come definirlo; ma se vogliamo usare empiricamente un titolo, potrebbe essere un poema filosofico» (“Scuola viva: incontri con gli autori”, 1971, p. 13).
8 C. LEVI, Cristo si è fermato a Eboli [Cristo], Einaudi, Torino, 1975 (1a ed. 1945).
9 È questo il ’carcer tetro’? Lettere dal carcere 1934-1935, a cura di Daniela Ferraro, Il Melangolo, Genova 1991.
10 G. PELLEGRINI, Nel sole di Villa Strohl-Fern (Carlo Levi), Corbo e Fiore, Venezia 1985, p. 119.
11 C. LEVI, Quaderno a cancelli [QC], Einaudi, Torino 1979. A questo proposito, cfr. Carlo Levi inedito: con 40 disegni della cecità, a cura di D. Sperduto, Edizioni Spes, Milazzo 2002.
12 G. BONTADINI, Saggio di una metafisica dell’esperienza, Vita e Pensiero, Milano 1938, p. 52. Sull’attualità di Bontadini, cfr. D. SPERDUTO, Tra Gustavo Bontadini ed Emanuele Severino, “Aquinas”, XLIX (2006), nn. 2-3, pp. 671-679.
13 Cfr. D. SPERDUTO, Carlo Levi e l’invenzione della verità, “Critica letteraria”, XXXII (2004), pp. 789-796.
14 C. LEVI, Le tracce della memoria, a cura di M. Pagliara, Donzelli, Roma 2002, pp. 37-41.
15 Ivi., p. 38.
16 C. LEVI, L’Orologio [Or.], Einaudi, Torino 1989 (1a ed. 1950).
17 Cfr. D. SPERDUTO, L’imitazione dell’eterno. Implicazioni etiche della concezione del tempo immagine dell’eternità da Platone a Campanella con un saggio sulla nozione di tempo in Carlo Levi, Schena, Fasano di Brindisi 1998, pp. 41-44 e 85-109.
18 G. FALASCHI, Carlo Levi, La Nuova Italia, Firenze 1978 (1a ed. 1971), pp. 13-14.
19 Sulla ‘morte’ e sulla ‘rinascita’ in Levi, cfr. G. LUPO, Tra inferno contadino e paradiso americano: Carlo Levi, Dante e la Bibbia, “Otto/Novecento”, XXVIII (2004), n. 1, pp. 69-85 e D. SPERDUTO, La rosa bianca e la rosa nera: Il Notturno di Gabriele d’Annunzio e il Quaderno a cancelli di Carlo Levi, “Critica letteraria”, XXXIII (2005), pp. 699-714.
20 Sul pensiero futile di Carlo Levi sviluppato in Paura della libertà (1946) ed in Quaderno a cancelli (1979), cfr. anche D. SPERDUTO, La futilità del tutto. Emanuele Severino e Carlo Levi, “Sapienza”, LVII (2004), pp. 485-489.
21 Sulla “futilità” in Levi, cfr. R. GALVAGNO, Carlo Levi, Narciso e la costruzione della realtà, Olschki, Firenze 2004.