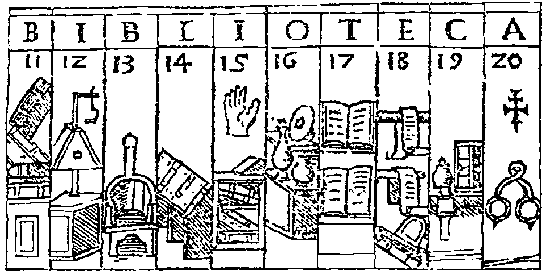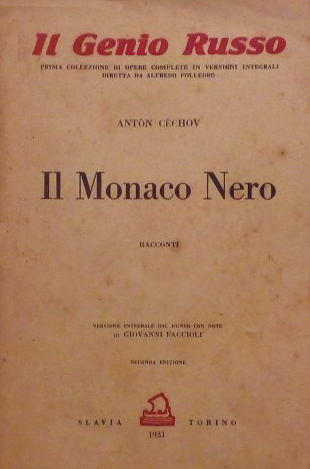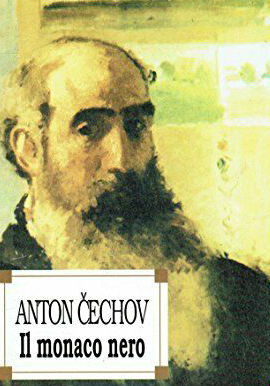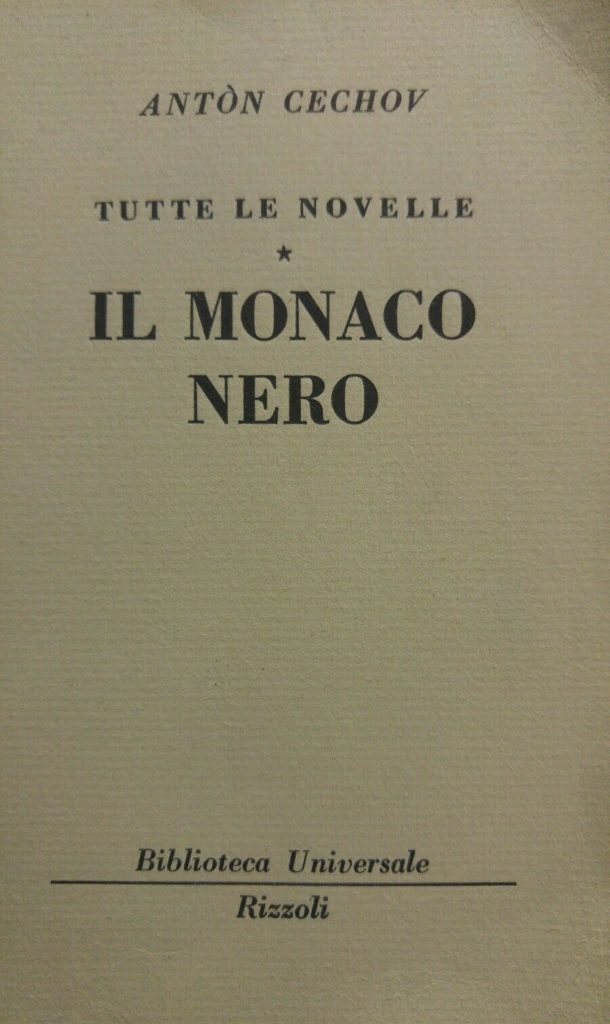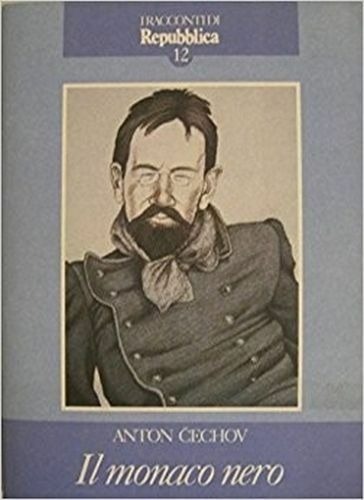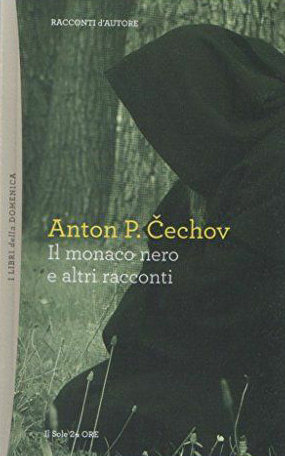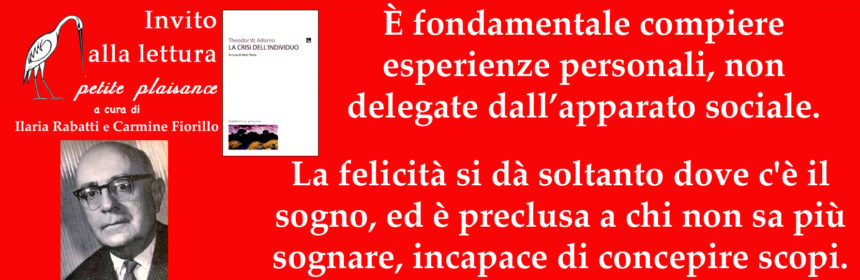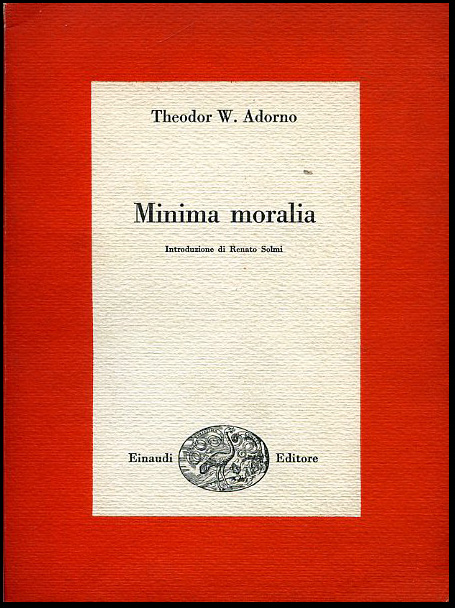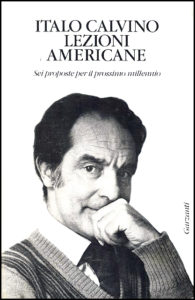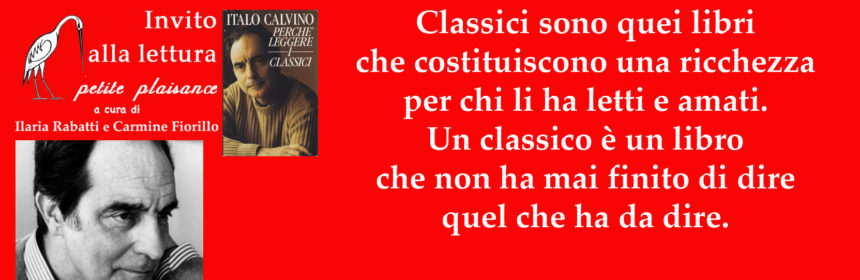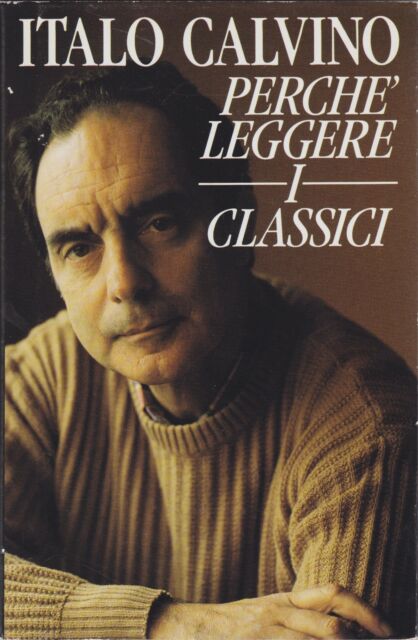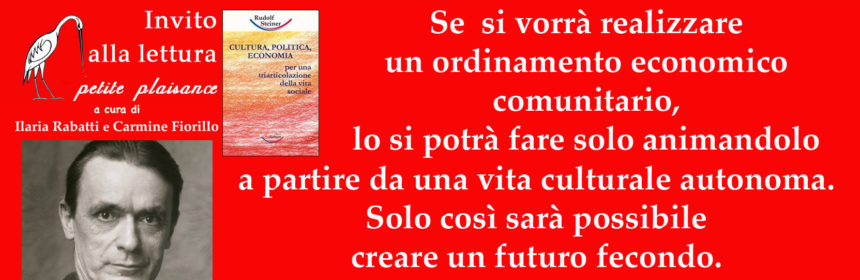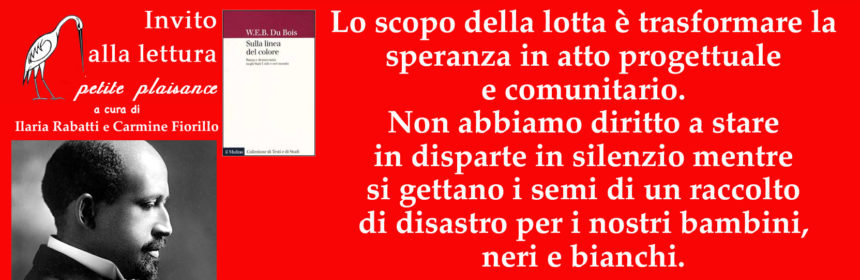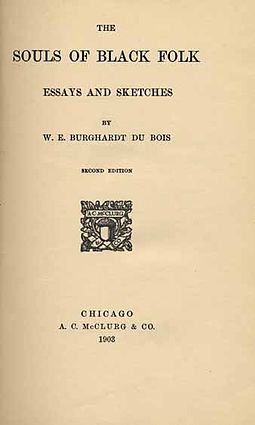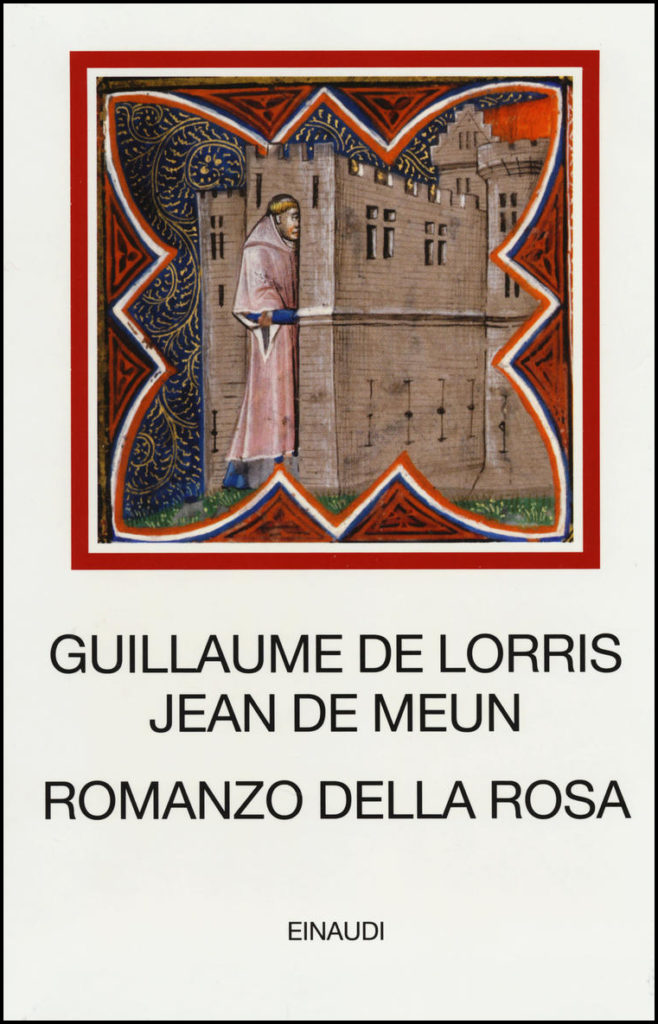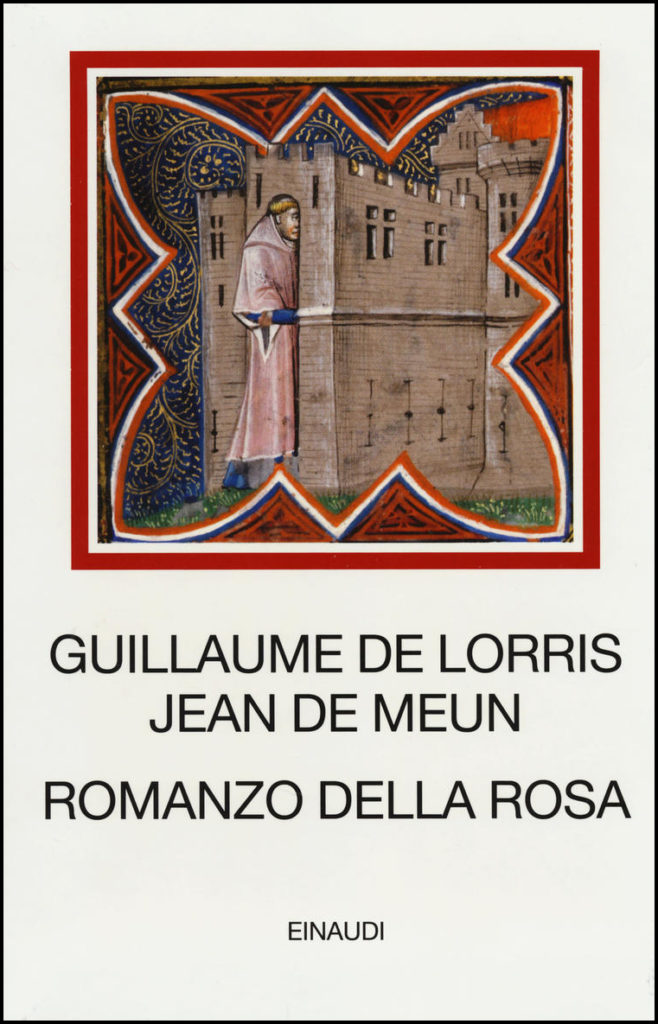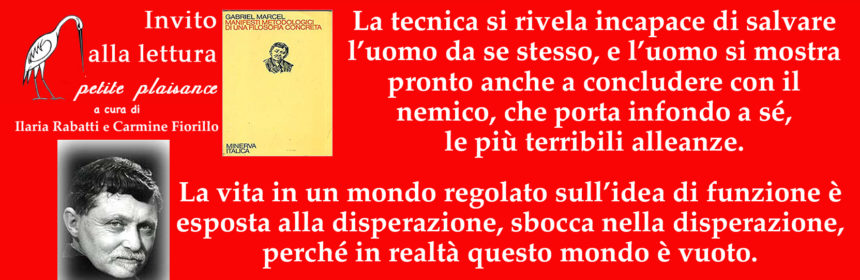Leggendo «Il Monaco nero» di A. P. Čechov. La vera gioia è nell’ascolto della creatività. La creatività massimamente espressa è l’atto di sentire e cogliere la profonda forza germinatrice della vita che lega l’essere umano all’unità dell’universo.

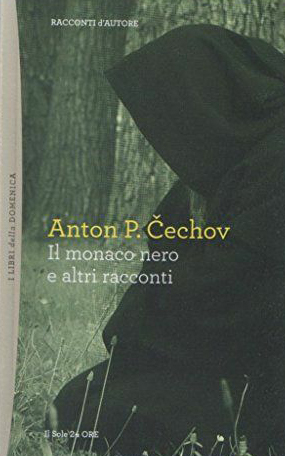
Salvatore Bravo
La vera gioia è nell’ascolto della creatività
Il capitalismo assoluto è sistema senza alterità, quest’ultima è possibile dove vige la creatività. La pluralità implica un lavoro di traduzione, ovvero di avvicinamento senza possibilità di sovrapposizione all’altro. L’attività creativa umana pone ponti, ma non sono mai percorribili in toto, le identità restano inafferabili, perché creatrici e germinatrici di vita. Senza tale processo la comunità è solo “luogo computazionale”, in cui regna l’intelletto unico, prospettiva eguale, che rende le attività automatiche e sincrone. Il grande sogno del capitalismo assoluto è la realizzazione di questo immenso intelletto comune mediante il quale ridurre l’alterità, il pericolo della creatività a semplice “attività organica al sistema”. Si tratta di realizzare compiutamente l’atomismo per impedire lo scambio creativo e politico.
La divisione facilita l’installarsi dell’intelletto computazionale comune, l’anomia diventa la legge del capitale. Se ognuno è come gli altri il sistema è protetto da critiche e prassi e può in tal modo eternizzarsi e diventare globale. Si tratta di utilizzare il senso comunitario nel suo negativo, ovvero da “essenza della relazione per creare” a sterile contatto trasmissivo di informazioni, a uso del capitale umano ai soli fini produttivi. Alla vita, che con i suoi processi semina altra vita, si sostituisce la violenza della sola produzione, dell’accumulo divenuto mezzo e fine del sistema. È il nuovo imperativo categorico che i popoli debbono prima omaggiare e poi trasformare nell’unico modello da realizzare. È il regno dell’ultimo uomo descritto da Nietzsche, la mediocrità sterile che diviene legge della vita.
Il regno dell’ultimo uomo è stato profetizzato anche nella letteratura russa. La mediocrità divenuta legge è descritta come parametro medico, a cui ci si deve conformare. La medicalizzazione dell’alterità, di coloro che vivono lo spirito dionisiaco e dunque creativo, è ben descritto da A. Čechov in un breve racconto Il monaco nero, con il quale descrive la medicalizzazione del diverso, dello spirito creativo. Nel racconto vi è il montare di una scienza minacciosa che tutto vuole assimilare a paradigmi ritenuti “oggettivi”. Scienza medica incapace di metalettura, e dunque al servizio dei poteri di normalizzazione. Nel racconto dello scrittore russo emerge dunque, il problema della creatività e specialmente la domanda su che cosa sia la creatività e quale sia la sua genealogia. Anton Pavlovič Čechov (Taganrog, 29 gennaio 1860 – Badenweiler, 15 luglio 1904) per poter denunciare la minaccia del potere di normalizzazione che avanza chiarisce che la creatività massimamente espressa nel genio è l’atto di sentire e cogliere la profonda forza germinatrice della vita che lega l’essere umano all’unità dell’universo. La creatività è un dentro ed è contemporaneamente un fuori, è dunque relazione nella profondità di sé che apre varchi verso il mondo, verso la comunità, è attività che forma ed informa le relazioni. Il monaco che il protagonista scambia per allucinazione, in realtà è l’io profondo nel quale ciascuno intuisce la presenza della vita non sclerotizzata in forme precostituite, ma che necessita di essere tradotta in forme sempre vive:
«”Devi essere un miraggio”, disse Kovrin. “Perché poi te ne stai qui fermo seduto? La leggenda e diversa.” “E lo stesso” rispose il monaco non subito, piano, girando la faccia verso di lui. “La leggenda, il miraggio e io, tutto questo e un prodotto della tua immaginazione eccitata. Sono un fantasma.” “Quindi, non esisti?” chiese Kovrin. “Pensala come ti pare” rispose il monaco e fece un lieve sorriso. “Esisto nella tua immaginazione, e la tua immaginazione fa parte della natura, quindi esisto anche in natura.” “Hai una faccia molto vecchia, intelligente e moltissimo espressiva, proprio come se vivessi davvero da più di mille anni” disse Kovrin. “Non sapevo che la mia immaginazione fosse in grado di creare fenomeni del genere. Ma perchè mi guardi con tanto entusiasmo? Ti piaccio?” “Sì. Sei uno dei pochi che si possono giustamente chiamare eletti da Dio. Sei al servizio della verità eterna. I tuoi pensieri, le tue intenzioni, i tuoi studi sorprendenti e tutta la tua vita portano un’impronta divina, celeste, poiché sono dedicati al razionale e al bello, ossia a ciò che e eterno.≫ ≪Hai detto: verità eterna… Ma e accessibile e necessaria, agli uomini, la verità eterna, se la vita eterna non esiste?” “La vita eterna esiste≫ disse il monaco. ≪Tu credi nell’immortalità degli uomini?” “Sì, certo. Un grandioso, brillante futuro aspetta voi uomini. E più sulla terra ci sono uomini come te, prima si realizzerà questo futuro. Senza associazione culturale Larici di voi, al servizio del principio supremo, che vivete con coscienza e liberta, l’umanità sarebbe insignificante; sviluppandosi in modo naturale, aspetterebbe ancora a lungo la fine della propria storia terrestre. Voi invece la fate entrare con qualche migliaio d’anni di anticipo nel regno della verità eterna – e in questo sta il vostro grande merito. Voi incarnate la benedizione divina che riposa negli uomini.” “E qual e il fine della vita eterna?” chiese Kovrin. “Come di tutte le vite: il piacere. Il piacere autentico sta nella conoscenza, e la vita eterna offre innumerevoli e inesauribili fonti di conoscenza, in questo senso e scritto: nella casa del Padre mio vi sono molti posti.” “Se tu sapessi com’e piacevole starti a sentire!” disse Kovrin sfregandosi le mani dalla soddisfazione. “Sono molto contento.” “Ma lo so: quando te ne andrai, la questione della tua essenza non mi dara pace. Sei un fantasma, un’allucinazione. Quindi sono malato di mente, anormale?”». [1]
Vera gioia è nell’ascolto della creatività
La vera gioia è nell’ascolto della creatività fine a se stessa che rompe i limiti dello spazio e del tempo per armonizzare il soggetto con il cosmo, il quale è un organismo sempre vivo, l’anima mundi è la legge che “passa” e “vive” nell’atto creativo donando gioie non estemporanee, ma che si radicano in emozioni e formano strutture caratteriali positive. Il creativo non è invidioso, perché ha in sé più vita. La creatività insegna che per “essere diversi” non c’è bisogno di essere fenomeni da baraccone da vendere nel mercato dell’immagine. La diversità è l’ascolto del proprio “demone” come Socrate ci ha già insegnato. Se non si ascolta la propria voce interiore, la creatività è solo un volgare succedaneo di se stessi, pertanto diviene esibizionismo egocentrico, visivo e logorroico. La creatività autentica è nell’atto di coltivare il proprio sé profondo nel quale reincontrare se stessi e l’umanità intera. La mediocrità da sistema vuole avvelenare la fonte della libertà per imporre la normalità statistica come legge scientifica, e dunque si arroga il diritto di normalizzare e sanare chiunque rompa il protocollo del sistema gregge:
«”E se fosse. Non c’è da essere imbarazzati. Sei malato perché hai lavorato al di là delle tue forze e ti sei esaurito, e quindi hai sacrificato la tua salute all’idea ed e vicino il tempo in cui le darai la vita stessa. Cosa c’è di meglio? E l’aspirazione di tutte le nature nobili che hanno doti celesti.” “Se so di essere malato di mente, posso credere in me stesso?” “Ma come fai a sapere che le persone geniali a cui crede tutto il mondo non abbiano visto fantasmi anche loro? Ora gli scienziati dicono che il genio sia affine alla follia. Amico mio, sani e normali sono solo i mediocri, che stanno in mezzo al branco. Le riflessioni sull’epoca delle malattie nervose, del sovraffaticamento, della degenerazione e cosi via possono mettere in seria agitazione solo chi vede lo scopo della vita nel presente, cioè quelli che stanno nel branco.” “I romani dicevano: mens sana in corpore sano.” “Non tutto quello che dicevano i romani o i greci e vero. L’animazione, l’eccitazione, l’estasi: tutto quello che distingue i profeti, i poeti, chi soffre per un’idea, dagli uomini normali e l’opposto dell’aspetto animalesco dell’uomo, cioè della sua salute fisica. Ripeto: se vuoi essere sano e normale, entra nel branco.” “E strano, ripeti quello che spesso viene in mente a me≫ disse Kovrin. “Sembra che abbia spiato, origliato i miei pensieri reconditi. Ma non parliamo di me. Cosa intendi per verità eterna?”». [2]
Nel regno del dicitur
L’attività creatrice è oggi osannata solo se funzionale al sistema produttivo, ma la creazione per sua natura risponde solo a se stessa, la creatività è anarchica. Il creativo oggi è perennemente minacciato, la pletora di messaggi che gli giungono, le pressioni istituzionali e la logica dell’utile inquinano il contatto con “il monaco nero”. Ognuno gioca la sua partita esistenziale nel coraggio di dire “sì” a se stesso, in un mondo che osanna i “dicitur”. Solitudine del genio e solitudine dell’umanità intera suddita di valori che necrotizzano la gioia e la fiducia nel proprio io profondo. Il potere si installa fin nelle viscere della persona, svuotandola e riducendola a semplice copia perfettamente sostituibile. La violenza diventa, così, legge, perché colui che è stato defraudato di sé diventa portatore di rabbia ed aggressività. Dobbiamo imparare dagli uomini che vissero la gioia:
«”Nell’antichità un uomo felice fini per aver paura della propria felicita tanto era grande! – e, per propiziarsi gli dei, porto loro in sacrificio il suo anello preferito. Lo sai, anche me, come Policrate, comincia un po’ a inquietare la mia felicita. Mi sembra strano di provare dal mattino alla notte solo gioia, mi riempie tutto e ottunde tutti gli altri sentimenti. Non so cosa sia la malinconia, la tristezza o l’angoscia. Come ora che non dormo, ho l’insonnia, ma non mi angoscio. Dico sul serio: comincio a non capacitarmene.” “Ma perché?” si stupì il monaco. “La gioia e forse un sentimento sovrannaturale? Non deve essere la condizione normale dell’uomo? Più è elevato lo sviluppo intellettuale e morale di un uomo, più è libero, più piacere gli dà la vita. Socrate, Diogene e Marco Aurelio provavano gioia, non tristezza. Anche l’apostolo dice: Rallegratevi sempre. Quindi rallegrati e sii felice”».[3]
Il protagonista muore, perché è stato oggetto di un’operazione di normalizzazione, la morte fisica è il completamento della sua morte psichica avvenuta con la sua normalizzazione, con la scissione da se stesso con la quale ritrovare la acclamata normalità che il sistema vuole:
«Un’ altra colonna nera simile a un vortice o a una tromba d’acqua apparve sull’ altra riva della baia. Attraversava la baia a velocita spaventosa in direzione dell’ albergo, diventando sempre più piccola e scura, e Kovrin fece appena in tempo a scansarsi per lasciarla passare… Un monaco con la testa canuta scoperta e le sopracciglia nere, a piedi nudi, le braccia incrociate sul petto, gli sfreccio accanto e si fermo in mezzo alla stanza. “Perché non mi hai creduto?” domando con aria di rimprovero, guardando tenero Kovrin. “Se allora avessi creduto che sei un genio, questi due anni non li avresti passati in modo cosi triste e misero.” Kovrin credeva già di essere un eletto da Dio e un genio, gli vennero in mente nitide tutte le conversazioni precedenti col monaco nero e voleva parlare, ma il sangue gli usci dalla gola dritto sul petto e lui, non sapendo che fare, si passava le mani sul petto e i polsini gli si intrisero di sangue. Voleva chiamare Varvara Nikolaevna che dormiva dietro il paravento, fece uno sforzo e disse: “Tanja!” Cadde a terra e, sollevandosi sulle braccia, chiamo di nuovo: “Tanja!”».[4]
La morte del genio è la morte dell’occidente culturale che in nome dell’utile e della sicurezza ha rinunciato all’essenziale per il superfluo, in questo scambio vi è la verità del capitalismo assoluto che abbaglia per favorire “la cecità di massa”.
Salvatore Bravo
[1] Anton Pavlovič Čechov, Il monaco nero, associazione culturale Larici http://www.larici.it pagg. 12-13.
[2] Ibidem, pag. 13.
[3] Ibidem, pag. 17.
[4] Ibidem, pag. 24.