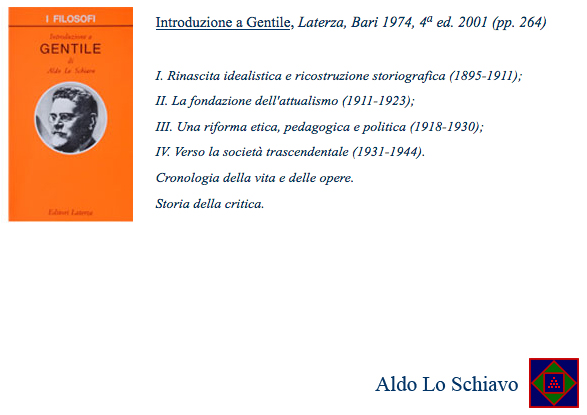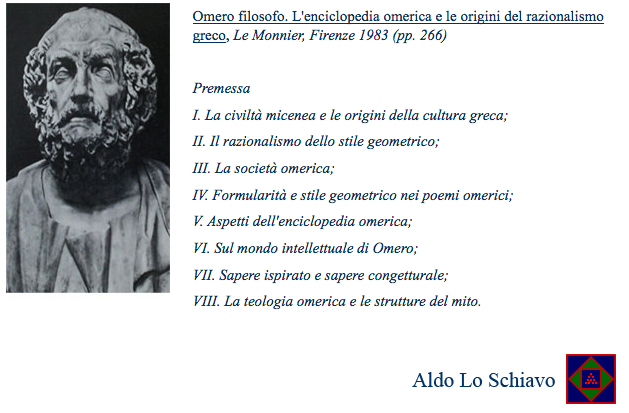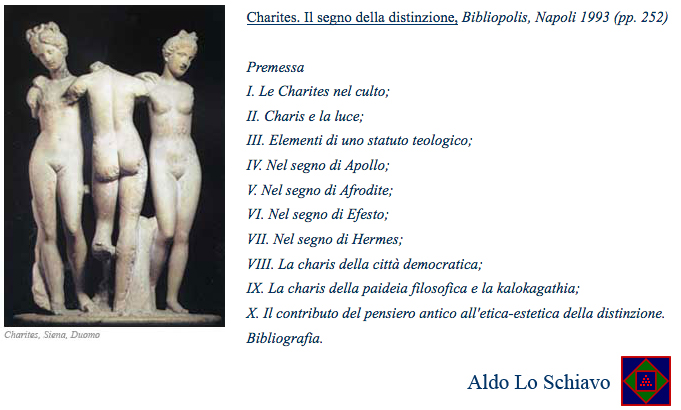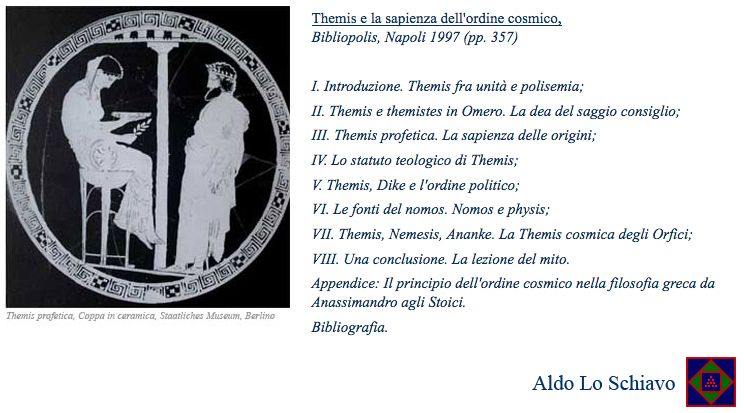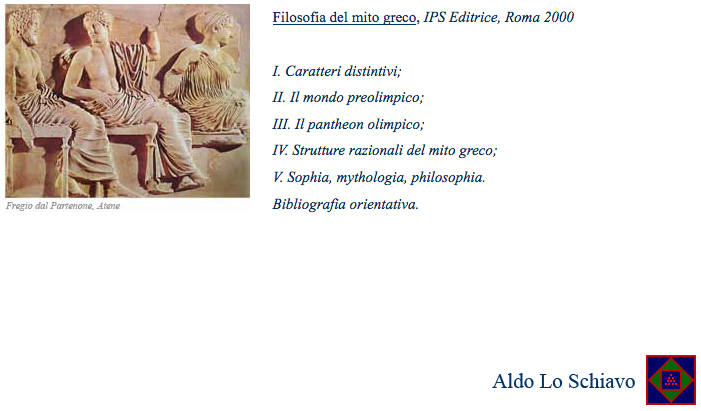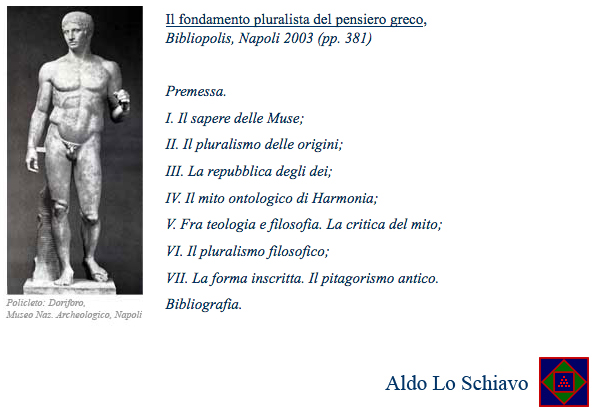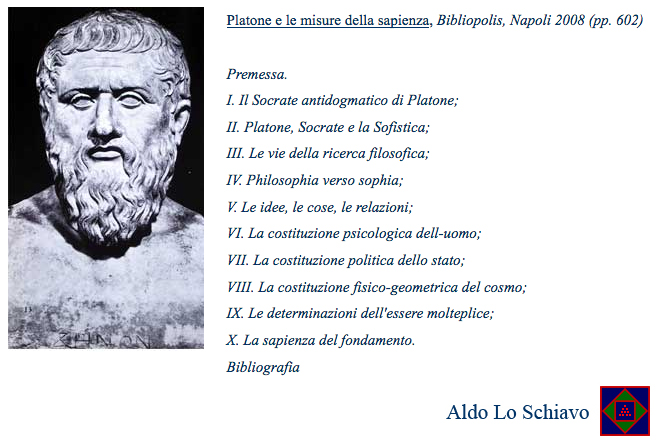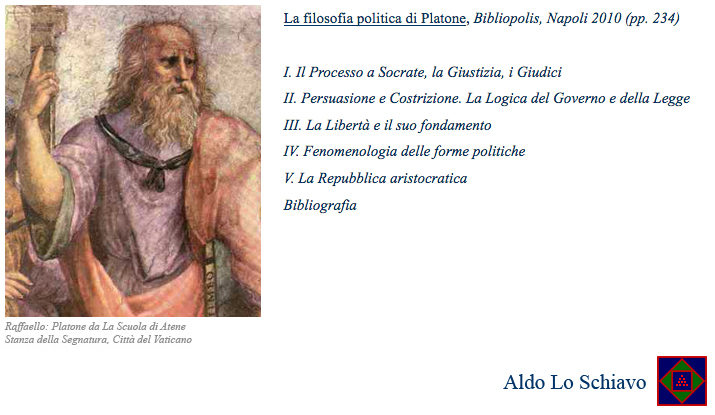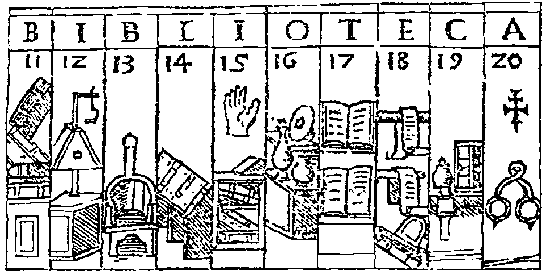Aldo Lo Schiavo – La condanna platonica della tirannide è radicale. Per Platone la città perfetta è un prodotto della ragione filosofica. La politeia ideale è il coerente progetto di trasformazione etico-politica della società temperato dal concetto di unità nella diversità. Il manifesto del filosofo laico.


La condanna platonica della tirannide è radicale
La condanna platonica della tirannide è la più radicale che la storia del pensiero politico abbia mai pronunziato. Anche se tanta parte della cultura e della politica greche aveva già manifestato forte avversione a ogni forma di tirannide, quella di Platone può essere considerata a ragione la più coerentemente argomentata e fondata, e anche perciò rimane una condanna senza appello, definitiva. Platone infatti collega, come sappiamo, la fenomenologia politica al fondamento ontologico della costituzione psichica dell’uomo. Su tale base, la tirannide si pone necessariamente all’estremo limite della scala degenerativa del potere, così come l’uomo tirannico costituisce l’ultimo anello della degradazione morale dell’individuo. Alla radice di tutto ciò sta l’eros tyrannos (Repubblica, 573 b). L’indigenza (penia), l’insaziabilità (aplestia), lo spavento (phobos) caratterizzano certamente la personalità del tiranno (577 e – 578 a). Ma più di ogni altra cosa, è la condizione di schiavitù a contrassegnare sia la città dominata dal tiranno sia l’uomo dominato dall’animo tirannico: in entrambi i casi viene ridotta al minimo la possibilità di agire secondo libera determinazione (577 c-e). La tirannide si pone all’ultimo gradino delle forme politiche degenerate proprio perché si trova all’estremo opposto della città ideale, così come l’individuo tirannico si trova all’estremo opposto dell’uomo regale aristocratico (576 d, 580 b-c). In effetti, «non c’è città più sventurata di quella sottoposta a tirannide, né più felice di quella governata dalla regalità» (576 e); correlativamente, «l’uomo più virtuoso e più giusto è il più felice, […] il più malvagio e più ingiusto è il più sventurato» (580 c). Si ha così anche la dimostrazione conclusiva del punto che Socrate aveva posto all’inizio della Repubblica (354 a): «il giusto è felice, l’ingiusto sventurato» (pp. 351-352).
Per Platone la città perfetta è un prodotto della ragione filosofica
[…] Per Platone la città perfetta, indipendentemente dal fatto che sia mai esistita o che possa esistere da qualche parte, prima di ogni altra cosa è un prodotto della ragione filosofica. Essa «è posta in cielo come un modello (paradeigma) offerto a chi voglia vederlo, e tenendolo d’occhio possa insediarvi se stesso» (Resp. 592 b; trad. di M. Vegetti). Più esattamente, fuor di metafora, essa si configura come un imperativo laico, il dover essere di ogni persona filosoficamente formata. Questi può vederla idealmente in cielo, in quanto può realizzarla in se stesso come una «costituzione interiore» (591 e 1; 590 e 4), in quanto cioè si fa governare da ciò che in lui «è divino e dotato d’intelligenza» (590 d), dalla ragione appunto. La città ideale di Platone non cerca una legittimazione teologica, né un fondamento trascendente. Essa trova fondamento e legittimità nella natura razionale dell’uomo, alla cui responsabilità intellettuale e morale in ultima analisi risale. Tale valore normativo, però, non si esaurisce nell’interiorità del soggetto, ma obbliga il filosofo a intervenire nella realtà politica, a impegnarsi per la trasformazione della città storica nella città del modello, scoperto dentro se stesso come fosse in cielo. Il suo compito è di istituire quaggiù, e di difenderle se già istituite, le misure delle cose belle giuste e buone che egli vede lassù (484 d 1-3), ovvero che egli scopre con la ragione. Vedendo quelle essenze, «tutte disposte secondo un ordine razionale», egli non può limitarsi a plasmare se stesso, ma deve essere pronto a trasporre nella dimensione della realtà politica quell’ordine superiore noetico che trova disegnato nella città interiore-celeste (500 c-e). […]
La politeia ideale della Repubblica si presenta quale coerente progetto
di trasformazione etico-politica della società
La politeia ideale della Repubblica, quindi, da un lato costituisce […] il criterio di giudizio e di valutazione critica delle forme costituzionali registrate nella realtà storica, e, dall’altro lato, si presenta quale coerente modello normativo, quale progetto di trasformazione etico-politica della società, progetto sorretto da una rigorosa strategia educativa coinvolgente in modo diretto o indiretto l’intera comunità. Il disegno platonico, perciò, non può definirsi una semplice “metafora dell’anima”, quasi si esaurisse in quella “costituzione interiore” pur auspicata dal filosofo. Né d’altra parte esso assume le sembianze di un mito o di una visione puramente utopica della società. Quel disegno, invece, intende essere un paradigma ideale diretto a orientare l’azione, a guidare i comportamenti morali, sociali e politici dei singoli e dell’intera comunità. La realizzabilità storica di tale modello non è esclusa in linea di principio, sebbene questa possibilità rimane un evento del tutto eccezionale, e anche in questo caso, per i limiti insiti nella natura umana, non potrebbe trattarsi che di una realizzazione imperfetta, di una approssimazione al modello (472 b -473 b; 501 b-c). Della kallipolis (527 c 2) Platone non individua specifiche istituzioni politiche. Stabilisce però quale è la funzione o l’obiettivo dello stato perfetto, quale la sua struttura sociale, quali i fattori o le condizioni che devono contrassegnarlo.
Il progetto di Platone intende risolvere alla radice il problema della stasis
Il progetto di Platone intende risolvere alla radice il problema della stasis, della discordia intestina (444 b), che era propria delle città greche in generale e di Atene in particolare, come lo è stato in seguito di tutte le comunità pervase da forte spirito individualistico. L’unità dello stato diventa dunque l’obiettivo primo e fondamentale del suo disegno insieme etico e politico. Mentre una città mal governata non è “una” città ma una “pluralità” di città, una città invece ben governata nel segno della “saggezza” è una città unita (polin mia) (422 e – 423 a). E la ragione di ciò sta nell’attuazione di un «principio», quello della “giustizia” (nel senso platonico del termine), ossia nel principio secondo il quale ogni parte di un tutto (sia esso l’individuo o la città) deve svolgere la propria funzione senza invadere quella delle altre, e fare in modo che tutte si armonizzino fra di loro, in base a quella sapienza (sophia) che presiede a queste cose (443 b – 444 a). In tal modo si ha l’uomo giusto e la città giusta. […] Tale principio riflette ancora il motivo socratico del primato della competenza. Si giunge così a vedere che il massimo bene (megiston agathon) per l’assetto dello stato, quello al quale il legislatore deve mirare nel porre le leggi, consiste nel coordinare insieme le differenti parti (gruppi sociali) della città, in modo da farne di molte una, mentre il massimo male (megiston kakon) consiste nel separare quelle parti, sì da fare di una città sola molte città (462 a 2 – b 2). Alla promozione dell’unità dello stato nella diversità delle sue componenti interne, Platone collega un secondo, non meno importante, obiettivo, che consiste nella promozione e salvaguardia del benessere generale. La felicità (eudaimonia) non può mancare nello stato ideale: bisogna, anzi, che l’intera città, e non un solo gruppo, sia per quanto più possibile felice (420 b-c). […]
Il richiamo all’unità fondativa dello stato
è fortemente temperato dal concetto di unità nella diversità
Queste tesi rivelano una concezione fortemente unitaria dello stato, ma tutt’altro che sorda e cupa, e anzi alquanto avanzata, attenta al fatto che non vi siano privilegi per alcun gruppo sociale e interessata all’esigenza che tutti i cittadini partecipino del benessere comune. Il problema è che, di fronte al valore assoluto dello stato, il singolo individuo non compare come soggetto portatore di valori autonomi, non conta come tale; compare soltanto come cittadino e come membro di una classe sociale. Questo limite è tipico, peraltro, della concezione tradizionale della polis greca. Semmai bisogna riconoscere che Platone approfondisce, come nessun altro pensatore greco, gli elementi costitutivi che sono al fondo della personalità umana e della sua autonoma responsabilità, elementi in mancanza dei quali non avrebbe neppure senso parlare dell’individuo come soggetto autonomo. Il richiamo all’unità fondativa dello stato, d’altra parte, è fortemente temperato dal concetto di unità nella diversità, diversità di ruoli e di funzioni relativi purtroppo ai gruppi sociali più che agli individui nella loro singolare autonomia (pp. 355-358).
Il manifesto del filosofo laico
La digressione sul filosofo contenuta nel Teeteto (172 c – 177 c) per un verso richiama motivi socratici presenti nella giovanile Apologia, ma per altro e più importante verso si colloca nella prospettiva di pensiero della maturità di Platone. Conviene ora esaminare queste pagine nella loro interezza, individuando i punti salienti del discorso di Socrate, prima di formulare un giudizio d’insieme sulla digressione stessa.
La schiavitù dei retori e la libertà del filosofo
Il filo conduttore del ragionamento di quelle pagine è rappresentato dalla contrapposizione fra due condizioni di vita antitetici: la schiavitù del retore e la libertà del filosofo. Fin dalle prime righe del discorso di Socrate (172 c) viene sottolineata la differenza che corre fra quanti sono abituati a frequentare tribunali e luoghi simili e quanti invece sono stati allevati allo studio della filosofia. I primi appaiono come schiavi di fronte a uomini liberi. La circostanza che discrimina le due condizioni sta nel modo di utilizzare il proprio tempo. Nella ricerca filosofica, la libertà (eleutheria) si sposa alla padronanza del proprio tempo; nella ricerca del successo, la schiavitù (douleia) è una conseguenza dei condizionamenti del tempo a disposizione nell’agone giudiziario o politico. Quelli che hanno trascorso «molto tempo» nello studio della filosofia, apprezzano il loro tempo libero, conducono i loro discorsi con agio, possono tranquillamente passare da un discorso all’altro se questo serve al loro unico obiettivo: arrivare a cogliere «ciò che è», l’essere (172 d 9). Gli altri, al contrario, si sentono incalzati dal tempo che scorre secondo la misura della clessidra, non possono svolgere i discorsi come desiderano, devono anzi sottostare ai limiti loro imposti da un padrone-giudice che, seduto sopra uno scanno, ha nelle sue mani «una certa giustizia» (172 e 6). Pur di prevalere nei tribunali o nelle assemblee, retori e simili non esitano ad agire per vie oblique, a ricorrere a menzogne e ingiurie, fino a perdere la dignità di un uomo libero. Soprattutto imparano presto a lusingare il loro padrone-giudice con le parole e a ingraziarselo con i fatti (173 a). In questa pagina, la condanna dei giudici e della giustizia amministrata dalla città non nasce, come nell’Apologia, dal caso singolo della sentenza ingiusta pronunciata contro Socrate, bensì è una condanna assai più forte, vuole essere una condanna generale dei tribunali e dei singoli giudici di ogni città e di ogni tempo, giudici ai quali sembrano inevitabilmente connaturati arroganza, arbitrio, corruzione. Il termine despotes qui usato per designare i giudici, appunto giudici-padroni, non lascia adito a dubbi sulla portata della loro condanna, una condanna senza appello. Il giudice non è uomo di giustizia, di cui illegittimamente si ammanta, perché, al pari dei retori, non fa parte degli uomini allevati nella filosofia, e quindi ignora cosa sia la vera giustizia, la giustizia in sé. A distanza di oltre tre secoli, Platone rinnova e rafforza filosoficamente la condanna espressa da Esiodo negli Erga nei confronti dei giudici-re del suo tempo, che ripetutamente definisce mangiatori di doni (dorophagoi).
Il sapere cui tende il filosofo
Chi si occupa di filosofia non ha giudici che presiedano alla sua attività, non è interessato a ciò che si discute nei tribunali o in altre adunanze pubbliche, né sa di tutte quelle cose e pettegolezzi di cui gli altri si servono per acquistare onori e reputazione. Soltanto il suo corpo risiede nella città, mentre il suo pensiero vola altrove, verso «le profondità della terra», come diceva Pindaro, o piuttosto verso l’indagine scientifica, la geometria, l’astronomia, la natura stessa degli esseri nella loro universalità. Esprime bene questo orientamento del filosofo la storiella di Talete deriso dalla servetta tracia perché, tutto preso a osservare le cose del cielo, non si accorgeva degli ostacoli che aveva davanti ai suoi piedi (173 c – 174 a). Qui siamo di fronte a un Platone molto lontano dall’agnosticismo del maestro. Quel Socrate che nell’Apologia dichiara di non sapere, e che anzi controbatte le accuse di Aristofane (19 b-d) asserendo che delle cose di sotterra e di quelle celesti egli non se ne intende né molto né poco e neppure si cura di fame ricerca, ebbene quel Socrate è stato sostituito nel Teeteto da un altro Socrate, il quale, al contrario del precedente, è proprio impegnato nella ricerca di come stanno le cose di sotterra e del cielo, è anzi tutto proteso ad abbracciare col pensiero «la terra tutta intera» e a fissare sempre lo sguardo su «il tutto (to pan)» (174 e 4 – 175 a 1). L’indagine sulla totalità del reale avvicina il filosofo alla sophia, che è il sapere appunto della totalità, del fondamento di ogni cosa. Nel perseguire questo obiettivo, peraltro, il filosofo non trascura di indagare ancora su cosa sia la giustizia e l’ingiustizia, in cosa consistano la felicità e l’infelicità umane (175 c). Tale è appunto il modo di essere del filosofo, di colui che è stato «allevato realmente nella libertà e nella padronanza del proprio tempo» (175 e 1 s.).
Assimilarsi a dio, ovvero diventare giusti
La conoscenza teorica, sia quella scientifica sia quella dialettica, non è sufficiente a realizzare il bene. Anzitutto occorre essere consapevoli che, nella natura umana, il bene si trova spesso commisto al suo contrario. Di conseguenza, bisogna cercare di fuggire dalle cose di quaggiù e tentare per quanto possibile di «assimilarsi a dio». L’impegno teorico deve tradursi nell’impegno pratico. L’assimilarsi al dio vuol dire «diventare con intelligenza giusti e santi», «fuggire la malvagità e perseguire la virtù» (176 b). Se è vero che la divinità in nessuna circostanza è ingiusta, bensì è sempre al massimo grado giustissima, non c’è nulla che più gli assomigli di colui che fra gli uomini sia diventato a sua volta dikaiotatos, il più giusto possibile. Conoscere ciò e comportarsi di conseguenza significa possedere vera sapienza (sophia) e virtù (arete), mentre non conoscerlo e non esserlo è manifesta ignoranza (amathia) e malvagità (kakia) (176 b-c). Il richiamo congiunto a sapienza e virtù indica che, nella prospettiva platonica, conoscenza e azione devono essere inseparabili, devono procedere in sintonia. Nella realtà, infatti, esistono due modelli di vita (paradeigmata): uno divino, felicissimo; l’altro non divino, infelicissimo. Scegliere fra questi due modelli, seguire l’uno o l’altro, con le conseguenze che ne derivano, è frutto di conoscenza e sapienza nel primo caso, di stupidità e follia nel secondo (176 e – 177 a). E allora assimilarsi a dio non vuol dire abbracciare un modo di vita ascetico, distaccato dal mondo. Né vuol dire seguire un particolare credo religioso. Al contrario, vuole semplicemente dire che è necessario ispirarsi a quel sommo criterio di giustizia che riteniamo appartenga nella sua purezza alla divinità, non essendo una qualità sempre e sicuramente presente fra gli uomini, i quali invece spesso la negano per ignoranza o per malvagità.
I temi ora riassunti consentono di vedere nella digressione del Teeteto un manifesto della libertà e laicità del filosofo. Il laicismo filosofico del Teeteto va molto oltre il laicismo agnostico dell’Apologia. Dalla giovanile adesione alla critica confutatoria di Socrate, Platone è passato alla rivendicazione dell’autonomia e piena libertà della ricerca filosofica. La stessa critica dell’uomo pubblico (oratore, sofista o mestierante politico) e la connessa condanna del foro giudiziario e dei giudici-padroni sono diventate assai più radicali e senza attenuanti. Ma il punto di maggior distacco sta nel fatto che ora la ricerca filosofica ha un obiettivo preciso: pervenire alla comprensione dell’essere, indagare la natura e l’uomo nella loro essenza costitutiva, scoprire attraverso queste indagini la ragione del tutto. La riflessione filosofica sull’essere, da un lato, la tensione morale verso la massima giustizia, dall’altro lato, danno fondamento a quell’ideale unitario di pensiero e di vita che identifica la sophia, la vera sapienza, per mezzo della quale l’uomo si sente vicino alla divinità, ovvero prossimo al grado più elevato di perfezione. Si comprende soltanto in questa chiave il senso della ricreata atmosfera socratica del Teeteto. Nel momento in cui si sta avvicinando alla sophia, ai più rigorosi criteri del sapere insieme scientifico-dialettico ed etico-politico, Platone rivive in una luce del tutto nuova l’insegnamento del maestro, al quale rivolge un ultimo omaggio, che è, in un certo senso, anche un commiato. Rende questo omaggio-commiato proprio perché è consapevole di essere entrato in un orizzonte di pensiero che ha superato o sta superando lo stallo aporetico del metodo socratico. Di tale nuovo orientamento, il Teeteto è documento significativo, almeno relativamente al pluralismo, insieme epistemologico e ontologico, che affiora sia nell’ abbozzo di teoria dei koina sia nella discussione intorno al tutto-intero e ai prota stoicheia […] (pp. 444-448).
Aldo Lo Schiavo, Platone e le misure della sapienza, Bibliopolis, Napoli, 2008.
Quarta di copertina
Nel corso della sua lunga esperienza intellettuale, Platone non ha certo dimenticato la grande lezione socratica. La sua opera, però, è andata ben oltre quella lezione. Se l’obiettivo primario è stato quello di trovare una soluzione positiva del problema morale e politico, egli ha tuttavia allargato progressivamente l’orizzonte della filosofia. Non solo ha indagato come nessun altro prima di lui le vie della ricerca, ma si è interessato in profondità ai temi dell’ordine della natura, della struttura del cosmo, dei principi stessi dell’essere e delle sue determinazioni molteplici. Egli ha inverato in una costruzione molto più avanzata e coerente ipotesi e idee della cultura prefilosofica e filosofica precedente. Al centro di tale costruzione trova posto un’attiva intelligenza ordinatrice, la quale, aldilà di tensioni e contrasti pure esistenti, promuove in ogni aspetto della realtà misure di ordine e di equilibrio che costituiscono la ragione d’essere delle singole cose e del tutto. L’itinerario filosofico di Platone appare contrassegnato da una ricerca, continua e sempre aperta, in fondo alla quale la philosophia riesce quanto meno a intravedere una superiore sophia, un’immanente sapienza ordinatrice operante in ogni sfera del cosmo e dell’esperienza umana.
Aldo Lo Schiavo (n. 1934) è stato ispettore centrale nel Ministero della pubblica istruzione per l’insegnamento della filosofia. È stato redattore capo e poi direttore della rivista «Annali della Pubblica Istruzione». Ha presentato un’interpretazione critica del pensiero gentiliano nel saggio La religione nel pensiero di G. Gentile («La Cultura», 1968, pp. 333-378) e nei due volumi La filosofia politica di G. Gentile (Roma 1971) e Introduzione a Gentile (Roma-Bari 1974, collana «I Filosofi»). Si è poi dedicato allo studio del pensiero greco, ed ha pubblicato a riguardo: Il contributo della tragedia attica al razionalismo antico (Roma 1979) e Omero filosofo. L‘enciclopedia omerica e le origini del razionalismo greco (Firenze 1983).
Aldo Lo Schiavo – Il sapere filosofico, quando non si isola in un formalismo tecnico fine a se stesso, trae sostanziale giovamento dall’analisi delle origini e del radicamento delle rappresentazioni mentali nel fitto tessuto di esigenze, sentimenti, reazioni individuali e collettive espresse nelle concrete situazioni in cui gli uomini operano e costruiscono la loro civiltà.
Aldo Lo Schiavo – Themis sa guardare all’avvenire del mondo, per il quale auspica un ordinamento al tempo stesso stabile e giusto, senza prevaricazioni e violenze. Themis pertanto esprime una normatività non costrittiva, non cieca, perché portatrice di una specifica sapienza cosmica.
Un tuffo …

… tra alcuni dei libri di Aldo Lo Schiavo…