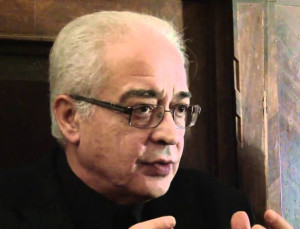Pierangelo Sequeri – Agorà / Oltre il dialogo. Sfida congiunta alle passioni tristi: seguirei la stella, non il satellite

Dialogare è bene, ma lavorare è meglio. Parlare e ragionare delle cose in cui ne va di noi e dei nostri affetti più sacri e più cari, grazie a Dio, sono cose possibili – e rimangono necessarie – anche al di fuori degli schemi previsti dalle funzioni strumentali di determinati rituali dialogici: giuridici, psicologici, diplomatici, accademici, e via discorrendo.
Le raccomandazioni e le istruzioni a riguardo del dialogo non lo sostituiscono, del resto, se non c’è. Il dialogo è un valore naturalmente: tutto, pur di scongiurare la guerra. Quando sono ridotte al dialogo, però, la cultura e la politica finiscono per mandare in scena due spettacolini ripetitivi, seppur con diversa ambizione: il dibattito metodologico (interdisciplinare, multidisciplinare, o come si vuole) e il dibattito televisivo (con tutti i suoi omologhi politicamente ed ecclesiasticamente corretti). Troppo spesso, in entrambi i casi, solo chiacchiere e distintivo.
La retorica del dialogo, che finisce per sostituire interamente il lavoro del pensiero, e si nutre di svagata indifferenza per la verità nelle cose, soffoca anche il dialogo fra credenti e non credenti (o diversamente credenti, o pensanti, o come volete voi). Nel dialogo fra ragione e fede, infatti, qualunque cosa significhi, tutti gli esseri umani sono semplicemente implicati in qualcosa in cui è in gioco – e a rischio – semplicemente l’umano. Per quanto diversamente – e oppositivamente – si posizionino, in tutta coscienza e libertà (e nemmeno questo è scontato), gli umani hanno sempre a che fare con entrambe. È lì che viviamo, moriamo, e siamo. Questa è la storia dell’uomo. E così continua ad essere. Non c’è nulla di più interessante. Al di fuori di questo nesso – così intricato, così eccitante – nessun argomento ha sapore e attrazione all’altezza dell’umano. Nemmeno il cibo, nemmeno il sesso. Neppure oggi. Lo stesso esperimento della secolarizzazione a-teistica, non riesce ad affondare la società degli umani soltanto fino a che tiene alta la sua dialettica con le parole e i gesti della religione: della cui potenza simbolica, magari surrettiziamente, si nutre inequivocabilmente. Persino dibattiti altrimenti futili – o disperati – intorno alla qualità della vita, sono nobilitati dal fatto di essere innervati da quella dialettica. Diversamente, saremmo già ridotti all’ossessione predatoria per il dominio, alla lotta per le pozze d’acqua, all’eliminazione del più debole (lo so: c’è chi ci sta lavorando, ma non disperiamo di neutralizzarlo). Dell’umanesimo, scomparirebbe la passione e persino il linguaggio.
La mia idea sarebbe quella di fare un appello all’oltrepassamento del dialogo, per passare alla cooperazione. E chi c’è, c’è. Incominciamo dagli intellettuali, che ci hanno decostruito abbastanza. Siamo a pezzi. La vacanza del pensiero è finita e l’occidentale politicamente corretto è un po’ inebetito. Le nuove generazioni incominciano a domandarsi dov’era il trucco, e intanto si agitano alla rinfusa. Dove capita, decostruiscono anche loro, a loro modo. La colpa è nostra.
C’è del lavoro urgente da fare, a parte il dialogo: riguarda beni di prima necessità per l’ominizzazione, che il mercato ha dismesso. La ripresa di iniziativa culturale del cristianesimo chiede, d’altro canto, disincanto del mondo, cultura impeccabile e passione per la cosa. Non siamo nel peggiore dei mondi possibili: sempre nella creazione di Dio, abitiamo. Devoti ossessivi e sbeffeggiatori impudenti ricavano energie parassitarie dalla nostra radiazione malinconica di fondo, che ormai si diffonde “globalmente”. E le investono su opposti estremismi, in nome della fede o della ragione, confondendo molti. In un mondo che perde logos, la reazione a catena del polemos (della guerra, della violenza, dell’aggressività di tutti contro tutti) guadagna terreno e si fa incontrollabile.
In un mondo che rimane senza l’audace e creativa testimonianza della sua comune destinazione cristologica, il politeismo degli dèi razzisti e corporativi occupa la scena. Il tentativo di annichilire il cristianesimo lavora certamente per il nichilismo – dovunque accada. Lo svuotamento dell’incarnazione di Dio fa regredire la religione e l’ominizzazione: indisgiungibilmente. Per questo, noi per primi ci dobbiamo purificare col fuoco, pur di restituire all’evangelo il suo onore. Non solo la sua verità. L’Occidente, del resto, ha covato a lungo il suo uovo di serpente. Puntuale, arriva la sua morìa dei primogeniti. L’autorealizzazione narcisistica (ce n’è un’altra?) rende infelici. L’infelicità può reggere alla penuria di benessere: ma non all’incredulità nei confronti della differenza del bene e del male, o all’indifferenza della vita e della morte. È così fin dall’inizio.
Mi espongo all’azzardo. Il banco di prova che misura la serietà intellettuale della cooperazione di religione e pensiero si può condensare in quattro idoli da sfidare in campo aperto, come Elia, che non guarda in faccia alla sfrontatezza dei sacerdoti di Baal, né alla vigliaccheria di Acab, che vi espone il popolo di Dio. Non sono semplicemente temi da sviluppare, fra gli altri. Sono bastioni da abbattere, luoghi comuni da disinnescare con perfetta ironia del logos: senza “se” e senza “ma”. Pura deontologia dell’onestà intellettuale, con soave letizia dell’annuncio evangelico e della testimonianza contraria. Li enuncio sinteticamente.
Il primo idolo è l’esistenza separata di un mondo giovanile: con logiche proprie, desideri propri, organizzazione propria, irresponsabilità propria. In pochi decenni, questa invenzione (essenzialmente mercantile) ha generato, per contraccolpo, l’universo tignoso della competizione senile: incorporazione di un’adolescenza infinita, scarso interesse per il lavoro della generazione, ricerca di complicità nel godimento e difesa corporativa del potere. I giovani non hanno guadagnato nulla da questa scomposizione, in un primo momento oggetto degli ammiccamenti compiaciuti di una classe intellettuale frustrata dalle sue rivoluzioni mancate. I giovani hanno incominciato a rendersene conto. L’ammiccamento del mercato, almeno, adesso è più scoperto. È l’ora della desublimazione: l’ultima frontiera del freudismo alla rovescia. Essere giovani significa poter godere sessualmente, in qualsiasi forma: senza cura per la generazione e senza fatica della dissimulazione. Essere se stessi, come si dice, senza orpelli ideologici. Caspita. Un piccolo passo per un giovane, un grande balzo per l’umanità. Sulla soglia di questa regressione, per “rimanere giovani” a loro volta, si affollano pateticamente gli adulti (anche quelli apparentemente più pensosi). L’ultimo atto di questo abbandono dell’uomo senza età al mito dell’orda primitiva, è l’incorporazione del concepimento fra le variabili del desiderio di godimento (a certe condizioni “si rimane giovani” e ci si sente “adolescenti onnipotenti”, anche “facendo” un figlio). Di fatto, abbiamo incominciato a perdere il senso delle stagioni e dell’unità della vita: anzi della storia e della sua destinazione. E perdiamo il senso più pieno della libertà: mai così potente come quando si distacca da sé per incorporarsi irreversibilmente in un altro, destinato a non essere parte di me.
Il secondo idolo è il vincolo condizionale dell’economia utilitaristica. Quello secondo il quale si deve crescere sempre, a prescindere. Quello secondo il quale senza risorse finanziarie non si produce neppure cultura, o democrazia, perché tutto ha un costo. Quello secondo il quale l’essere umano è una macchina biologica del godimento predatore e del desiderio autoriferito. Non voglio nemmeno discutere, qui, di capitalismo o di mercato: l’intrascendibilità del fondamento economico-libidico della storia dell’uomo è un credo che unisce tutt’ora il capitalismo e i suoi oppositori. Parlo della potenza simbolica – religiosa, quasi teologale – accordata alla presunta ovvietà di questo strumento che si è fatto fondamento. E della gerarchia che i sussiegosi officianti dei suoi riti distribuiscono come inevitabile, sbeffeggiando gli ingenui che ne dubitano. Battaglia dura: inutile girarci intorno, bisogna mettersi di traverso. È questo che corrode la mente e svuota l’anima. Ora – è evidente – non siamo più neppure in grado di sacrificare vita e creature per la Bestia che promette di tenerci in vita. Siamo straccetti. E non possiamo reggere il gioco. E ci dicono pure che siamo noi che sbagliamo a consumare. Pezzi di interi continenti, con uomini e donne sopra, affondano di questo. Non per caso Gesù dice ai suoi che la sovranità di Cesare, a certe condizioni, può essere riconosciuta. Quella di Mammona, mai.
Il terzo idolo la struttura essenzialmente comunicativa del sapere. L’ossessione informativa, funzionale, strumentale del sapere, ha imposto la credenza nella sua giustificazione strettamente utilitaristica. Non è per la verità, è per la notizia: dopodiché (come dice l’assessore) sono fatti vostri. In uno spazio così angusto, che si dilata solo orizzontalmente, non c’è posto per nessuna profondità, nessuna grandezza d’animo, nessuna verità dell’arte, nessun realismo per la differenza dello spirito, nessuna potenza dell’affezione che allarga la mente, creando libertà e sfidando la morte. Esibizionismo linguistico, tutto fa spettacolo. Perdiamo metà del mondo e quasi tutto il suo cielo. Gli umani si parlano per essere più umani, non solo per comunicare meglio. Il pensiero e il linguaggio avvolgono spessori dell’essere-umano – e anche dell’essere mondano – che si arricchiscono di mille sfumature, dispiegano potenze nascoste, inturgidano la vita di grandezze incomparabili e imperdibili dell’anima. La parola del pensiero – anche quella silenziosa – crea spazi di eternità per la vita a disposizione dell’anima: è per la circolazione extra-corporea dell’anima, che arricchisce di colori caldi il pianeta uomo. Il godimento immediato è sempre un godimento mancato. L’espressione spontanea di sé rimane sempre vagito. Sempre più individui, giovani e sani, grugniscono e firmano con la x. La mente e l’anima chiedono cura. E invenzione e sintassi, circolazione di esperienze e affinamento del linguaggio, abilità nella modulazione delle sintonie e passione per l’attitudine a nuove composizioni che allargano i sensi, fino a renderli capaci di presa sull’eterno. La bellezza dell’anima è la nostra casa comune. Non per niente la qualità della musica è la spia perfetta della civiltà dei sensi spirituali che corrisponde alla formazione dell’umano in noi. I ragazzi, a scuola, anche quelli con l’anello al naso, aspettano solo testimoni competenti, impeccabili, appassionati di questo. Muoiono di rachitismo spirituale, le creature, prima che di violenza e di dosi eccessive.
Il quarto idolo è il carattere privato della nominazione di Dio. Nella cultura occidentale si è sviluppato un consistente pregiudizio a riguardo del senso comune della nominazione di Dio: sarebbe l’indicatore principale della superstizione, dell’inganno, della violenza. Di fatto, nella convinzione di doverla anzitutto sottrarre alla religione, la regolazione della nominazione di Dio è passata alla politica, poi alla scienza. Pur dichiarandosene incompetenti, la politica e la scienza non fanno che parlarne. A vanvera. Manca invece una seria cultura della teo-logia, che è certamente di interesse pubblico, in virtù della sua originaria disposizione alla mediazione del logos. Il cristianesimo dovrà essere, a sua volta, meno timoroso e più generoso: e adoperarsi perché la teo-logia diventi una rispettabile funzione del sapere critico e autocritico di pubblico interesse, non un gergo di mera appartenenza. Nella realtà, la disumanizzazione della nominazione di Dio, rimpicciolito alla misura del privato sentire delle politiche di parte o di etnìa, incoraggia una vera legione di piccoli padreterni. Piccoli, ma non innocui. “Dio” è meglio lasciarlo misteriosamente oltre il limite dei nostri desideri e dei nostri godimenti, piuttosto che riempirlo rozzamente o svuotarlo stupidamente di realtà. Il delirio di onnipotenza è il trascendentale della stupidità, non dell’autorealizzazione: e fa danni, persino in nome di Dio. Di certo, la privatizzazione del nome di Dio, che lo separa dall’universale rispetto per la verità che deve essere restituita alla giustizia – e non possiamo, noi – non ha prodotto nulla di buono. Nulla.
Troppo difficile? Per quel che vale, a questo punto, vi dico la mia opinione anche su questo. Pochi passi dietro la linea del talk show, ci sono fior di menti – che persino i teologi ignorano, a vantaggio dei più nominati in classifica – che non ne possono più dei quattro idoli che ci affogano le creature. Un soprassalto creativo che riapre il mondo ci serve, non la conta delle lenticchie che ci uniscono e ci dividono. Siamo in ostaggio, con tutta la carovana, di passioni tristi: autorefenziali e scettiche, in egual misura, nei confronti della verità che non patteggia con la morte e del desiderio di non abitare la terra invano. Mettere il cuore nell’intelligenza delle cose più vere e degli affetti più sacri, che ci tengono insieme per l’eterno (la generazione, l’amicizia, la grandezza dell’animo, il rispetto del mistero nascosto in Dio), è passione lieta, capace di creare comunanza e slancio, in grado di rimettere in moto la storia.
La bellezza attuale del cristianesimo, per come la vedo io, deve apparire in questo: con tutti i difetti e le incongruenze che porta, questa figura religiosa del Logos è l’unica in grado di proclamare, in nome di Dio, che la verità di Dio è riscatto e salvezza per l’ostinazione di essere umani. La nuova frontiera del dialogo è questa. Per la nuova evangelizzazione, seguirei la stella, non il satellite.
Pierangelo Sequeri
Già pubblicato in Koinè, Anno XVIII – NN° 1-3 – Gennaio-Giugno 2011