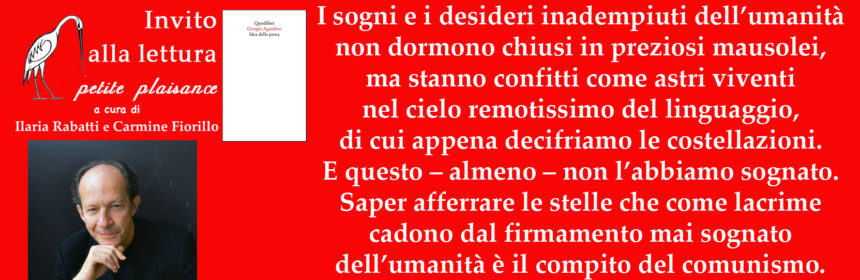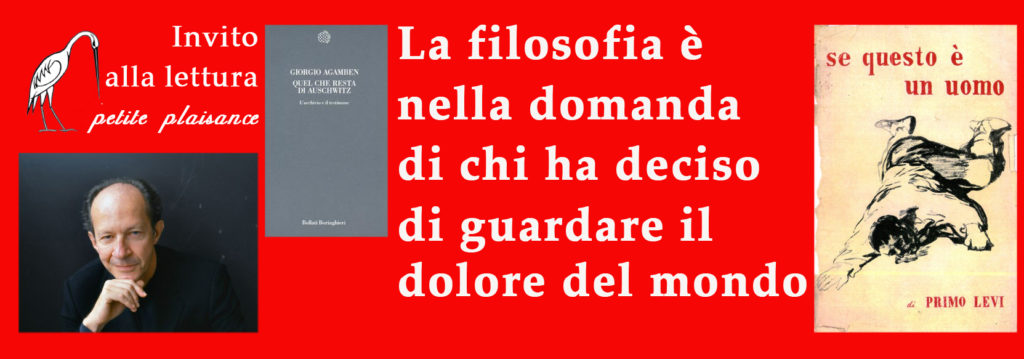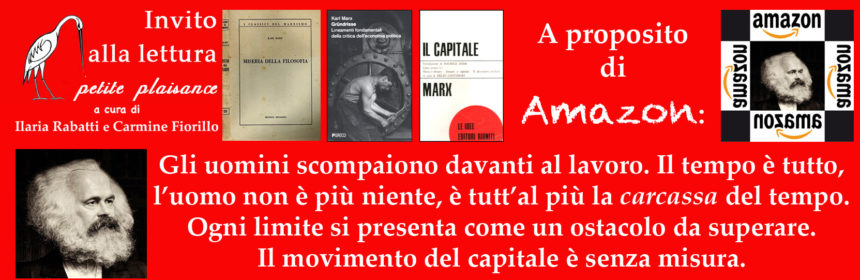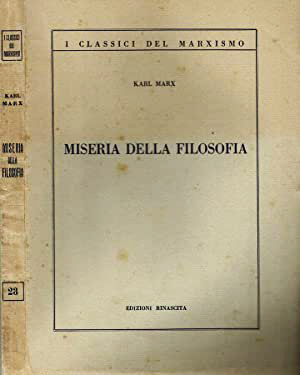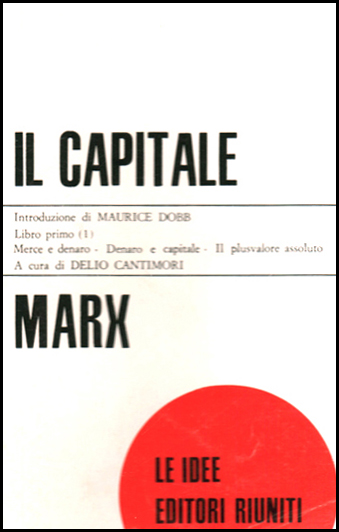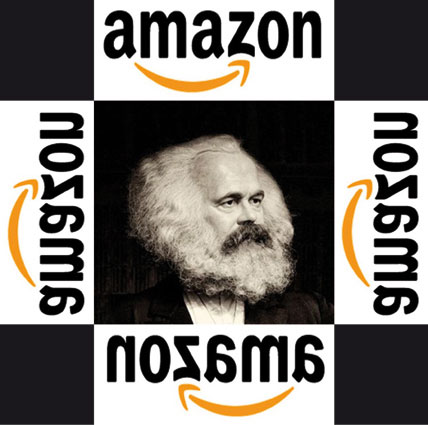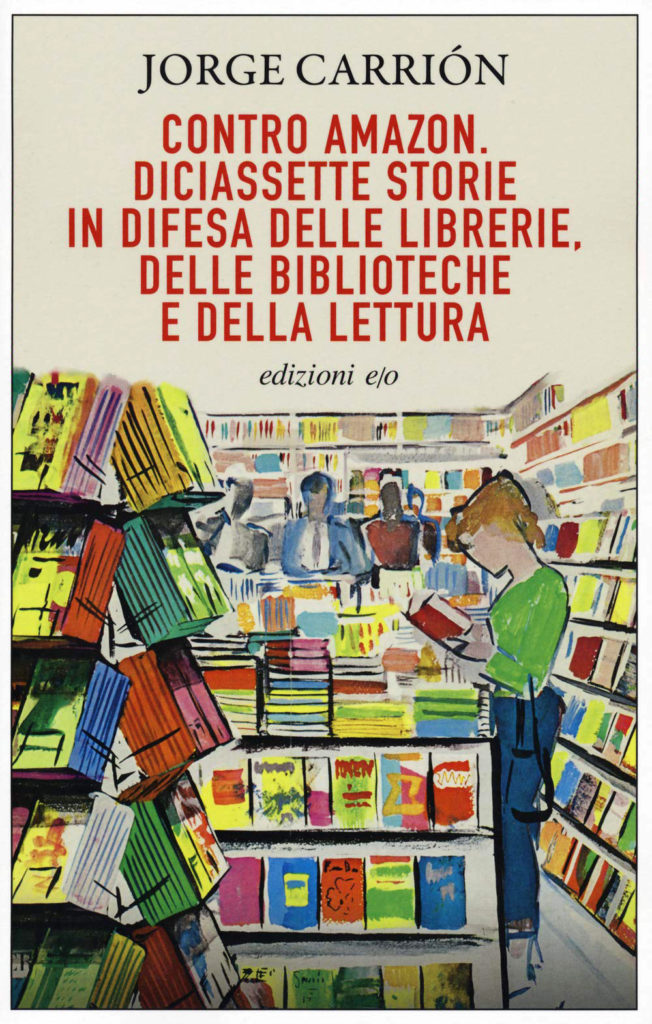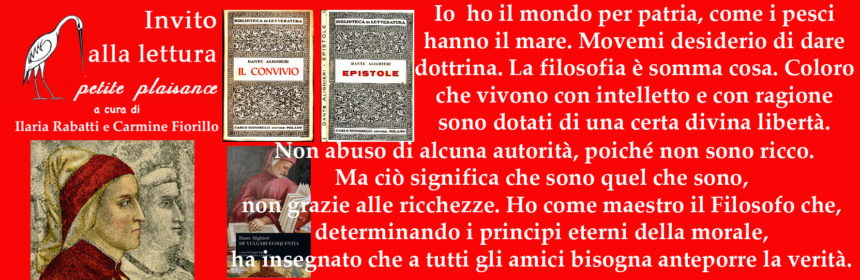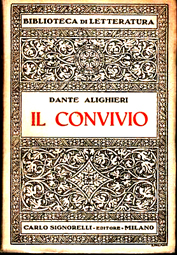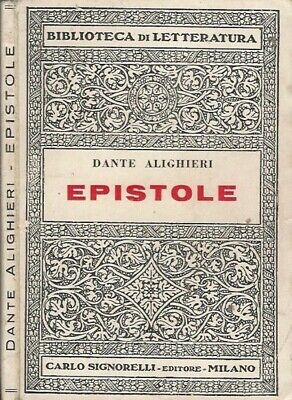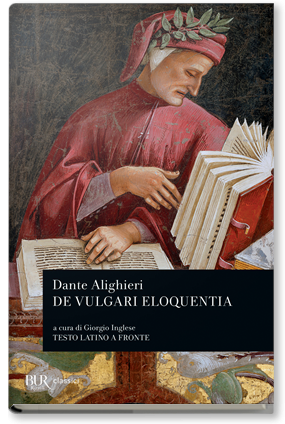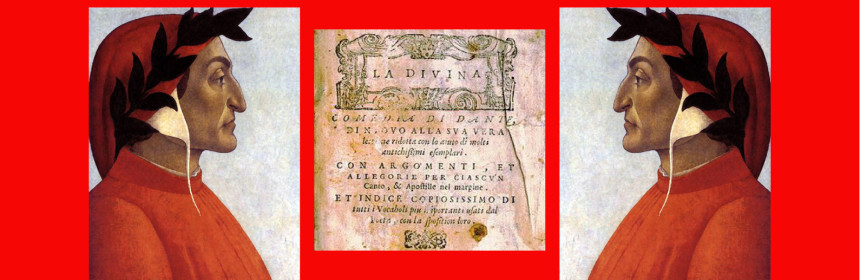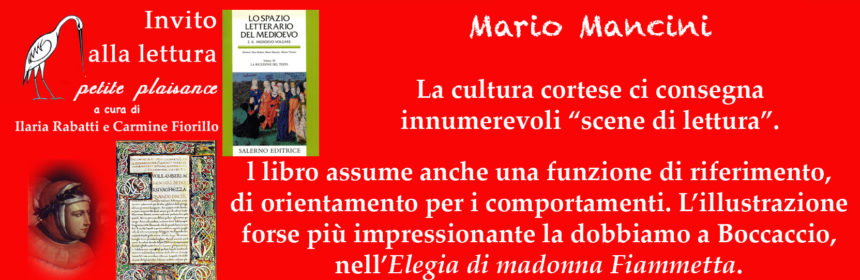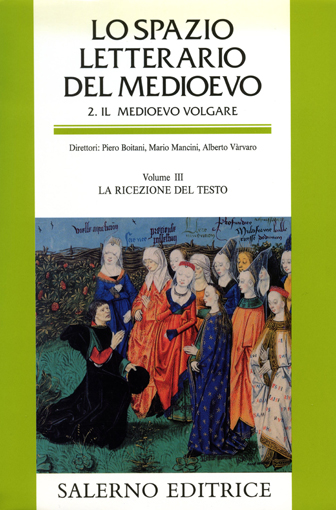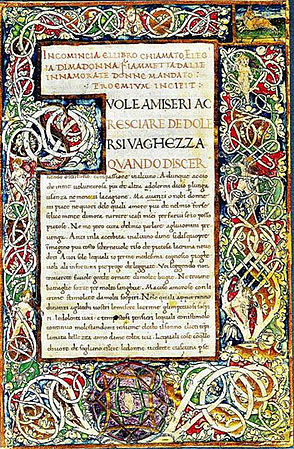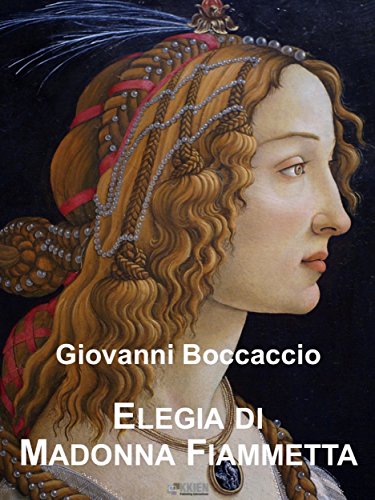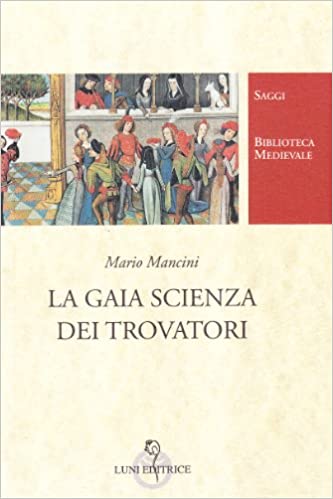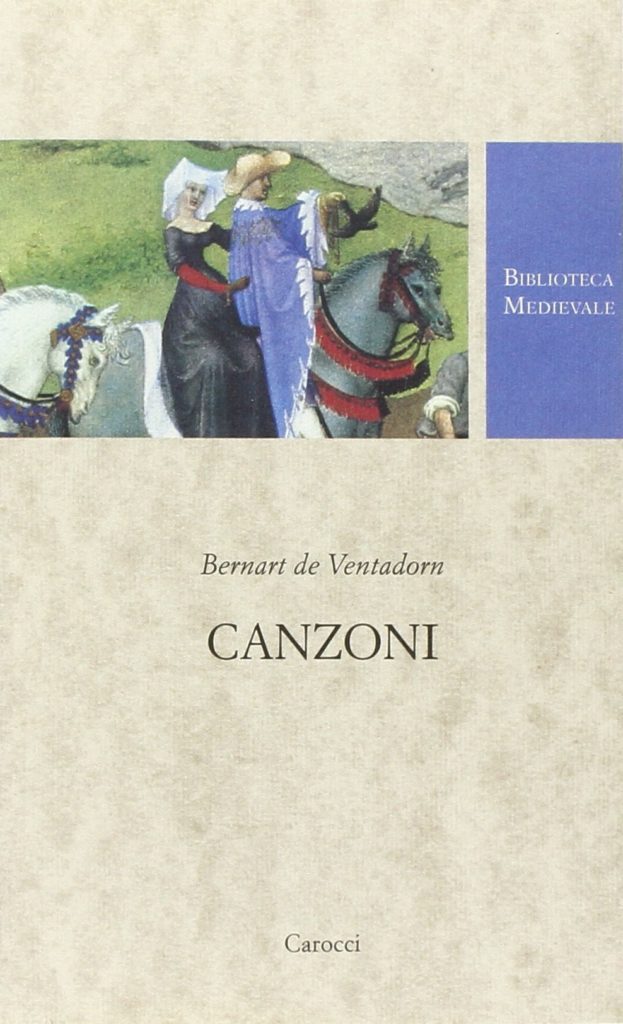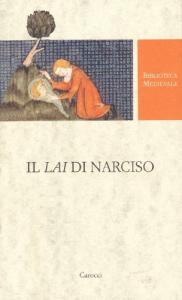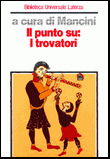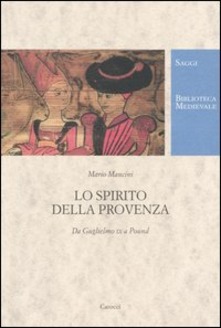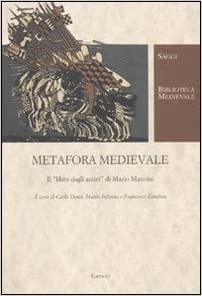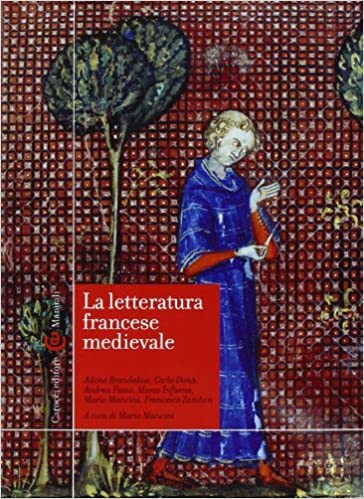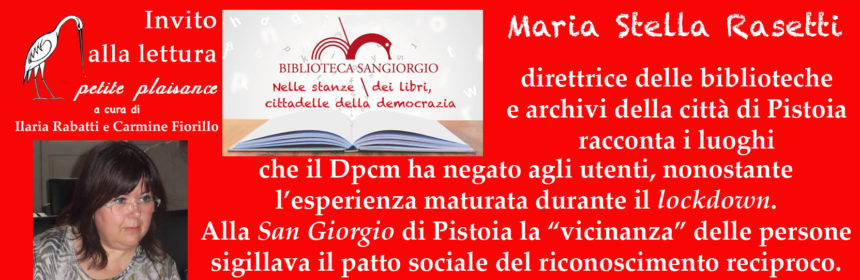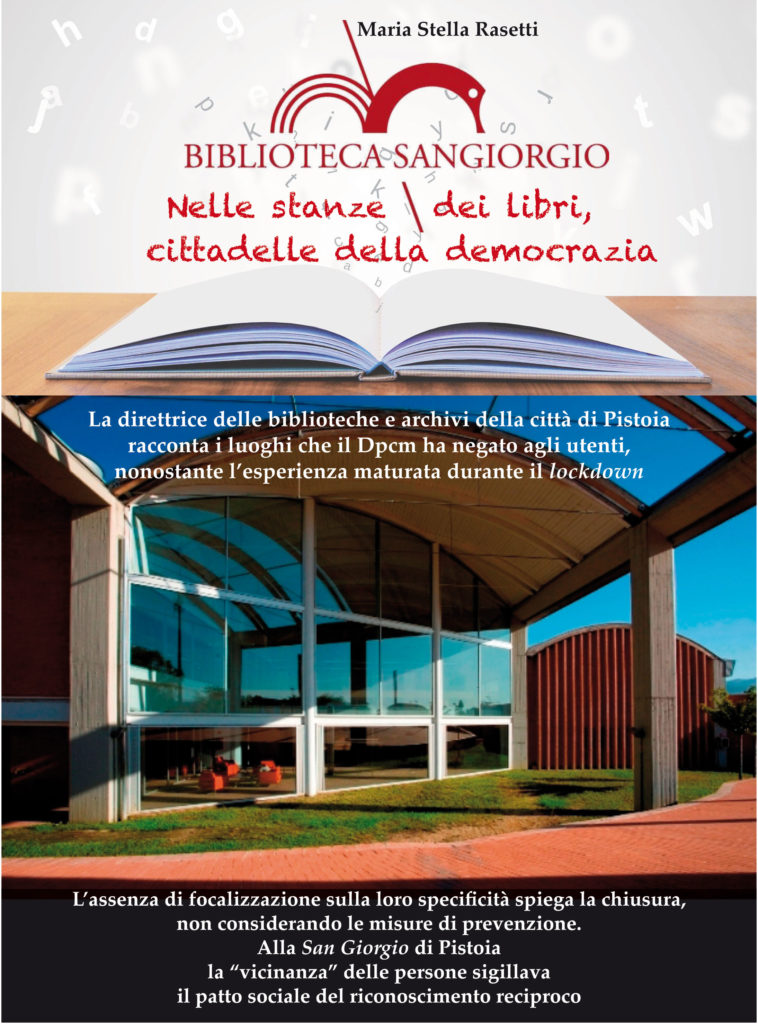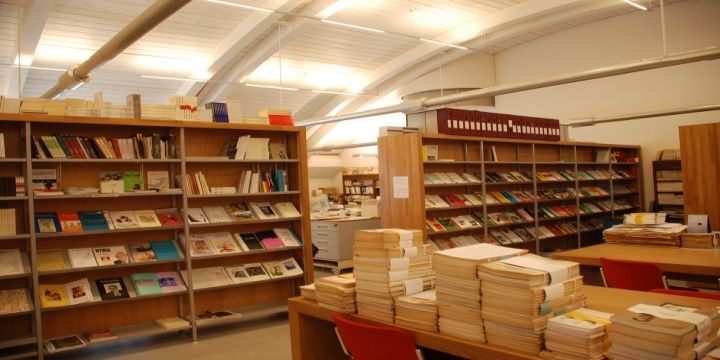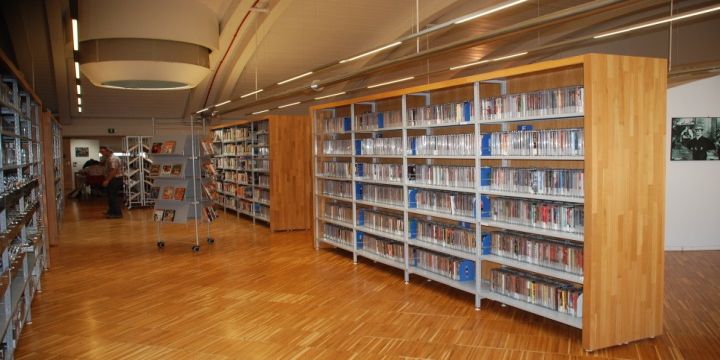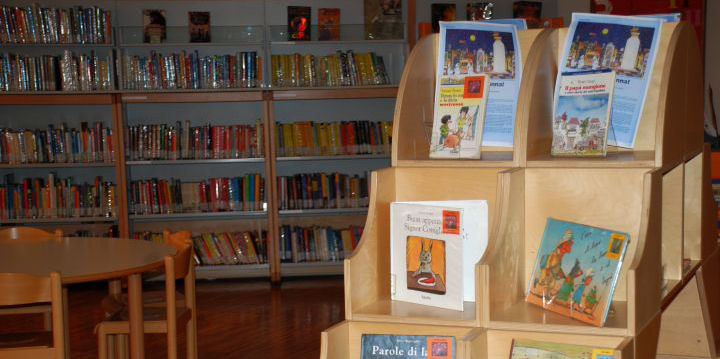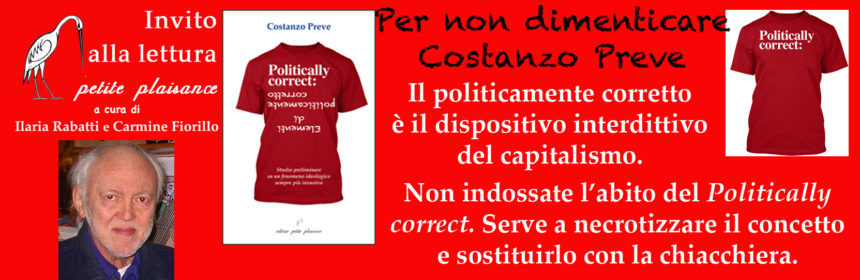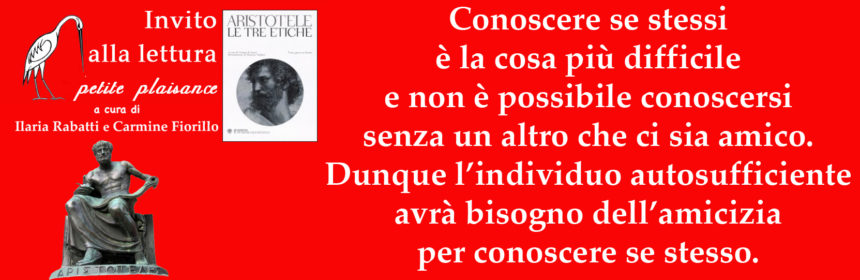Petite Plaisance – Per descrivere il “comunismo” Marx si rifugia spesso dietro la vaghezza del «sogno di una cosa» e banalizza la coscienza utopica che desidera il sorriso delle stelle (“de-sidera”) per l’armonia comunitaria di cui avverte la mancanza. Non dice che il comunismo è conforme alla natura umana, che è realizzabile in atto poiché è in potenza presente nella natura umana. La stella polare è nella Fondata progettualità della buona utopia per una buona vita, e Non nelle «ricette per la trattoria dell’avvenire». Eppure aveva ben chiaro il rapporto tra l’ape e l’architetto.
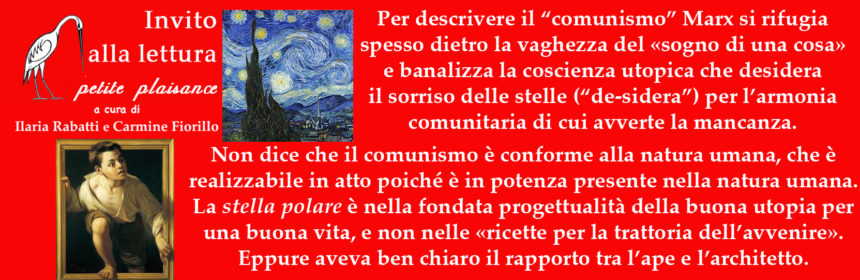
«Mi si rimprovera […] di essermi limitato ad una scomposizione puramente critica del dato, invece di prescrivere ricette (comtiane?) per la trattoria dell’avvenire».
K. Marx, Poscritto alla seconda edizione del I Libro de Il capitale, Londra, 24 gennaio 1873.
«[…] l’ape fa vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che fin da principio distingue il peggior architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. […] egli realizza nell’elemento naturale, allo stesso tempo, il proprio scopo, che egli conosce, che determina come legge il modo del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà».
K. Marx. Il capitale, vol. I, Editori Riuniti, Roma 1973. pp. 195-196.

Petite Plaisance
Per descrivere il “comunismo” Marx si rifugia spesso dietro la vaghezza
del «sogno di una cosa» e banalizza la coscienza utopica
che desidera il sorriso delle stelle (“de-sidera”) per l’armonia comunitaria
di cui avverte la mancanza.
Non dice che il comunismo è conforme alla natura umana, che è realizzabile in atto
poiché è in potenza presente nella natura umana.
La stella polare è nella fondata progettualità della buona utopia per una buona vita,
e non nelle «ricette per la trattoria dell’avvenire».
Eppure aveva ben chiaro il rapporto tra l’ape e l’architetto.

Marx ed Engels avevano ragione a sostenere che se il comunismo non fosse in potenza presente nella realtà capitalistica, esso non potrebbe nemmeno realizzarsi in atto. Tuttavia, affermando soltanto che esso era in potenza presente nella dialettica storica, Marx ed Engels non hanno mai esplicitamente sostenuto che così è in quanto il comunismo è conforme alla natura umana, e dunque che il comunismo è realizzabile in atto (e desiderabile) poiché è in potenza presente nella natura umana.
Non è infatti la dialettica storica, la quale è prodotta spesso da situazioni contingenti, ciò che deve rendere più o meno ottimisti circa la possibilità di realizzare il comunismo, ma è proprio la natura umana.
Il comunismo è invero costantemente ricercato dagli uomini, anche se sovente con scarsa consapevolezza, proprio in quanto esso costituisce quel mondo razionale e morale in cui gli uomini stessi desiderano vivere. Esso rappresenta il modo di produzione più adatto a creare quella armonia comunitaria in cui principalmente consiste la buona vita.
Sostenere ciò non significa affermare che il comunismo necessariamente si realizzerà in atto, come prevalentemente sostennero Marx ed il marxismo in base alla presunta «dialettica storica». La dialettica storica non può essere interamente controllata. Sostenere questo significa solo affermare che se il comunismo si realizzerà in atto, è unicamente poiché esso è presente in potenza nella natura umana.
La dura critica riservata da Marx agli utopisti nel Manifesto (ma anche in Miseria della filosofia e altrove) non fu dovuta alla loro critica delle fondamenta privatistiche e mercificate della società esistente. La pars destruens posta in essere dal pensiero utopico, per quanto poco scientifica, era sufficientemente argomentata.
Il problema era nella pars construens, che Marx ed Engels ritenevano essere completamente disancorata dalle possibilità reali offerte dalle modalità sociali.
Tuttavia, su questo punto occorre riflettere, per mostrare come una fondata progettualità comunista possa anche essere costruita sul pensiero classico antico, e non solo sul pensiero marxiano. La critica di Marx non è infatti estendibile a tutto il pensiero utopico – la Repubblica di Platone, ad esempio, è un’utopia politica molto attenta a considerare le modalità sociali presenti –, ed in più va sottolineato che il confronto fra la pars construens (sempre ad esempio) di Platone e la pars construens di Marx è innanzitutto un confronto fra qualcosa che esiste compiutamente (in Platone) e qualcosa che non esiste se non implicitamente (in Marx), e fra queste due alternative la prima è sempre preferibile alla seconda.
Quando devono descrivere il “comunismo”, Marx ed Engels si rifugiano pressoché sempre dietro la vaghezza di espressioni quali «il sogno di una cosa»,[1] o altre dello stesso tenore, oppure tendono ad affermare che il comunismo deve essere l’opposto dialettico del capitalismo, attribuendo però a quest’ultimo una importanza troppo grande e troppo aleatoria, nel ritenerlo (per quanto “in negativo”) un riferimento costitutivo.
Non si vuole qui sostenere che si debbano elaborare a tavolino anche i “particolari” della futura società ideale comunista. Tuttavia, almeno le linee generali della stessa dovrebbero essere elaborate in anticipo, poiché chi aspira al comunismo deve sapere non solo che ciò fa parte della sua natura di uomo, ma deve anche sapere, in linea di massima, in quale modo di produzione potrà realizzare la propria natura, per valutare se l’alternativa al tempo presente sia o meno desiderabile.
Questo è il compito principale del pensatore comunista. Limitarsi a criticare, per quanto con buone ragioni, il modo di produzione esistente senza essere in grado di pensare nemmeno ad una alternativa possibile migliore, è sterile ed inconcludente, e forse addirittura dannoso per la stessa credibilità della proposta teorica comunista. Limitarsi oggi a fare quello che suggeriva Marx, ossia ad essere gli “esecutori” delle presunte leggi della storia, anziché i “grandi architetti” di future società giuste, significa mettersi interamente nelle mani del modo di produzione capitalistico, le cui interne contraddizioni, sicuramente ben comprese da Marx, potrebbero richiedere secoli per determinarne la dissoluzione. Il tema interessante è che quando in Marx ed Engels la descrizione del comunismo assume una qualche concretezza, come appunto nel Manifesto, le linee generali di un modo di produzione comunista sono delineate in maniera universalistica, ossia attenta a princípi e fini generali, volte a creare un quadro di produzione sociale razionalmente e moralmente gestibile per la soddisfazione dei principali bisogni umani. In questo senso, la più importante indicazione di Marx ed Engels è quella della pianificazione comunitaria. Ciò è comprovato, appunto, dalle pur contingenti indicazioni del Manifesto: «espropriazione della proprietà fondiaria», «imposta fortemente progressiva», «abolizione del diritto di eredità», «accentramento dei mezzi di trasporto nelle mani dello Stato», «aumento delle fabbriche nazionali e degli strumenti di produzione, dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano comune», «educazione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli», ed in generale «accentramento di tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato». È possibile certo sostenere che anche questa idea di “comunismo”, in Marx ed Engels, fu derivata in opposizione dialettica alla idea di “capitalismo”, e pertanto non può assumere valore generale. Questo è in parte vero. Tuttavia, anche in assenza di una esplicita fondazione umanistica da parte di Marx, queste sue indicazioni progettuali paiono molto coerenti e concrete, certamente compatibili – almeno in parte – con una pianificazione comunitaria e democratica della produzione sociale. Sapere di condividere, se non la lettera, almeno lo spirito di fondo di un pensatore come Marx, sicuramente il maggiore teorico del comunismo mai vissuto consente di non consegnare Marx ai semplici sostenitori del bellicoso “comunismo-antagonismo” o del vago “comunismo-autogestione”, dannosi i primi, inconcludenti i secondi.[2]
Note
[1] «La riforma della coscienza consiste soltanto nel fatto che l’uomo lascia che il mondo divenga la sua coscienza interna, che l’uomo si risvegli dal sogno su se stesso, che si renda chiare le proprie stesse azioni. Il nostro intero scopo non può consistere altro – come nel caso di Feuerbach riguardo alla religione – che ogni domanda religiosa e politica venga tradotta in forma umana autocosciente. […] Si vedrà allora che da tempo il mondo possiede [nel senso di custodisce, ha in sé] il sogno di una cosa, del quale gli manca solo di possedere la coscienza, per possederla veramente» (K. Marx, Lettera a Ruge, settembre 1843, in K. Marx – F. Engels, Opere complete, III, 1843-1844, Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 156). Interessante notare – per rendersi conto di quanto queste espressioni di Marx abbiano influenzato la riflessione teorica di tanti intellettuali del Novecento – come il «giovane» P. P. Pasolini incontri il «giovane» Marx proprio quando deve scegliere il titolo del suo primo romanzo, Il sogno di una cosa (scritto nel 1949-50, ma pubblicato da Garzanti solo nel 1962). Il tema del «sogno» verrà ripreso anche da E. Bloch nel suo Karl Marx, il Mulino, Bologna 1972, pag. 57-82.
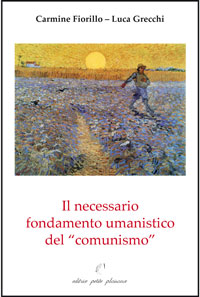
Carmine Fiorillo – Luca Grecchi
Il necessario fondamento umanistico del “comunismo”
indice – presentazione – autore – sintesi
[2] Cfr., su questi temi, Carmine Fiorillo – Luca Grecchi, Il necessario fondamento umanistico del “comunismo”, Petite Plaisance, Pistoia 2013, pp. 80-83.