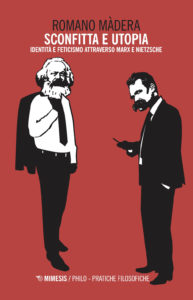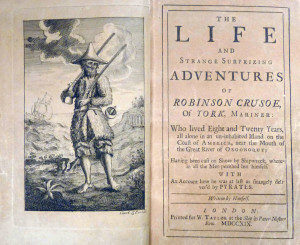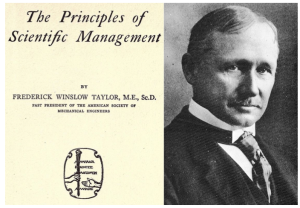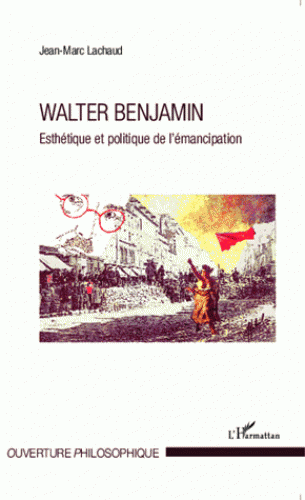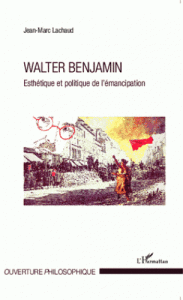In questo numero, ampio spazio è stato dedicato all’analisi di due contributi – il tuo libro scritto con Orso ed il volume di Boltanski e Chiapello – entrambi accomunati dall’intento di rivitalizzare una disciplina che (in tempi di postmodernismo e disincantamento del mondo) appariva totalmente demodé: la diagnosi (socio-filosofica) del capitalismo reale. Nel tentativo di mettere a fuoco motivi e argomenti che possono forse permettere al lettore di arricchire la propria prospettiva su tali questioni, prenderei le mosse da questi due rilevanti studi per iniziare la nostra breve discussione. Boltanski concludeva il proprio discorso con un’affermazione molto importante: nel capitalismo “la natura della risposta in termini di giustizia dipende in gran parte dalla critica.Se gli sfruttati, gli infelici, coloro che non riescono restano silenziosi ed esclusi, allora non c’è necessità per il capitalismo di rispondere in termini di giustizia”. Il fatto nuovo per il pensatore francese è che – nella terza età del capitalismo – il mondo del lavoro ha rinunciato a rovesciare il capitalismo, limitandosi ad aggiustarlo o riformarlo.
In una recensione dedicata a Le nouvel esprit du capitalisme, de Benoist evidenziava magistralmente come ci si continui a scontrare sulla ripartizione del plusvalore, ma non si discuta più sulla maniera migliore per accumularlo:
“È quella che Jacques Julliard ha definito ‘l’interiorizzazione da parte dei lavoratori della logica capitalistica’. Ciò che sembra in tal modo scomparire è un orizzonte di senso che giustifichi ilprogetto di cambiare in profondità l’attuale situazione. Di fatto, tutti quanti si piegano perché nessuno crede più alla possibilità di un’alternativa. Il capitalismo viene vissuto come un sistemaimperfetto ma che, in ultima analisi, rimane l’unico possibile. La sensazione si diffonde a tal punto che non è più possibile sottrarsene. La vita sociale ormai viene vissuta esclusivamente nella prospettiva della fatalità. Il trionfo del capitalismo risiede innanzitutto in questo fatto, di apparire come qualcosa di fatale”.
Assistiamo oggi a una degenerazione del principio di realtà, un’assenza completa di illusioni e un’attrazione irresistibile della “forza delle cose”; “Adeguati!” è il comandamento psicologico-politico del momento: per sopravvivere bisogna andare “a scuola di realtà”.
Un’intera epoca – pervasa dalla certezza che la storia avesse un senso, in cui si era convinti che il passaggio dalla preistoria alla storia fosse una questione di anni o al massimo decenni – si è rovesciata dialetticamente nella sicurezza (tale da diventare quasi un pilastro del senso comune) che il mondo che ci troviamo davanti è qualcosa di immodificabile e intrascendibile.
Il sistema è un grande Moloch invincibile, contro cui è inutile battersi e a cui al massimo si può strappare qualche concessione. Viviamo in una sorta di “positivismo tragico” – come lo definisce Sloterdijk – “il quale, ben prima d’ogni filosofia, sa già che il mondo non va né interpretato né cambiato: esso va sopportato”.
Ci si adatta all’ingiustizia. Si perde l’abitudine ad indignarsi. E ci si autoinibisce a priori la possibilità di cambiare lo stato di cose presente. La disoccupazione, la mortalità infantile, la povertà sono oggi trattate come il risultato di forze impersonali che agiscono ad un livello globale, contro cui non si può fare nulla.
Qual è la tua posizione a proposito? C’è una possibile via d’uscita, o bisogna “rassegnarsi” come suggeriva Umberto Galimberti in una recente intervista?
Quando ero giovane, avevo un programma massimo, che era quello di cambiare il mondo. Diventato vecchio, ho ormai un programma minimo, quello di impedire al mondo di cambiarmi. Anche io, come Sloterdijk, sopporto il mondo. Ma, a differenza di lui e dei suoi innumerevoli cloni meno dotati, rifiuto di trasformare la sopportazione in esito terminale della filosofia della storia, e questo in base al principio elementare del pudore.
Civettando con il linguaggio di Hegel, la nostra è un’epoca di gestazione e di trapasso verso un’impotenza sociale collettiva senza precedenti storici. In mancanza di precedenti storici che ci permettano di fare analogie, non esistono filosofie del passato (neppure quelle ellenistiche dell’interiorità all’ombra del potere e del rifugio in una comunità protetta di amici) che possano veramente aiutarci a pensare la sconvolgente novità epocale del nostro tempo. Superate le precedenti fasi astratta e dialettica e giunto alla fase speculativa, il capitalismo sembra essersi rinchiuso da solo in una gabbia d’acciaio (Max Weber) ed in un dispositivo tecnico imperforabile (Martin Heidegger). Le facoltà di filosofia sono ormai in occidente o palestre per carrieristi disincantati, o cliniche antidepressive per gente con velleità culturali.
Gli oppressi restano silenziosi perché (esattamente come Sloterdijk, ma a differenza di lui senza sapere chi erano Kant o Hegel) ritengono che non ci sia niente da fare. Questo è ad un tempo elementare ed enigmatico. Fichte avrebbe definito la precarietà in termini di Non – Io, ma egli viveva in un tempo in cui l’Io era ancora concepito come l’intera umanità pensata come in grado di fare il proprio destino. In appena due secoli la situazione è rovesciata. Oggi il concetto filosofico novecentesco che sembra connotare meglio l’attuale situazione è quello heideggeriano di Dispositivo (Gestell), e questo non a caso. Naturalmente non sono in grado di dare indicazioni per il superamento dell’attuale situazione. La filosofia, come la nottola di Minerva, si alza al crepuscolo. So però che di fronte alla globalizzazione finanziaria non bisogna perseguire l’inclusione, ma l’auto – esclusione. Il rovesciamento magico della globalizzazione in comunismo postmoderno, e cioè la teoria di Negri, è una vera e propria vergogna. Come sempre è avvenuto nella storia, la Resistenza verrà in un tempo ed in uno spazio determinato, non in un mappamondo finanziario.
Non so però né dove, né come, né quando.
A tuo parere – come si può rinvenire in molti saggi da te pubblicati – il pensiero marxiano è inficiato da due “errori di previsione”, che falsano le analisi di Marx e da cui è necessario separarsi per non incappare nuovamente in un’inevitabile sterilità teorica e politica:
1) il proletariato non è affatto una classe rivoluzionaria in grado di attuare la transizione decisiva dal modo di produzione capitalistico alla società senza classi. Le classi subalterne non sono state in grado di resistere alla radicalizzazione della sottomissione del lavoro al capitale, che al contrario le ha integrate nei gruppi sociali di produzione capitalistica “smentendo empiricamente” l’attribuzione metafisica che aveva fatto di queste classi un soggetto intermodale.
2) il capitalismo (a differenza di quanto Marx credeva) si è mostrato capacissimo di sviluppare le forze produttive, ed a svilupparle anzi ad un ritmo prodigioso, nonostante i danni enormi che ha inflitto sia all’uomo che alla natura.
Nel momento in cui si decide di accettare tali critiche, la scientificità di ciò che un tempo si chiamava “materialismo storico” non rischia di entrare drammaticamente in crisi?
Cerco di spiegarmi meglio. Come sappiamo per Marx “una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza”; il Nuovo diverrà necessario esclusivamente allorquando il Vecchio si sarà tramutato in “vincolo e pastoia“.
Giungerà il momento in cui, compiutamente sviluppato, il capitalismo diverrà un limite alla produttività umana che fino ad allora aveva promossa, e sarà allora che il proletariato si ergerà come classe emancipatrice dell’intera umanità, chiudendo il ciclo storico delle società divise in classi e aprendo le porte alla futura società comunista.
Ma se – preso atto degli errori che inficiano l’analisi marxiana – è impossibile delineare il momento in cui il vecchio diviene “vincolo e pastoia”; e se inoltre il proletariato si rivela affetto da una “pittoresca ed incurabile subalternità”, la scientificità della concezione materialistica della storia non va completamente all’aria?
Il problema non è marginale. La forza e la fortuna avuta da Marx e dal marxismo nel novecento derivava infatti proprio dalla certezza che il materialismo storico avesse un carattere scientifico, previsionale. Quando Marx contrappone il suo socialismo, in quanto scientifico, al socialismo utopistico di Owen, di Saint-Simon e di Fourier, intende sostenere che il suo socialismo – a differenza dell’altro – è in grado non solo di dire come stanno le cose, ma anche di indicare che necessariamente dovranno andare in un determinato modo.
Bisogna trarre la conclusione che il famoso passaggio “dall’utopia alla scienza” è stato in fin dei conti illusorio, ed il comunismo non è affatto il movimento reale che abolisce lo stato presente di cose (né l’orizzonte verso cui conduce il meccanismo del modo di produzione capitalistico indagato scientificamente) ma un’utopia che viene spacciata come scienza? Ed in un quadro come questo, non è forse secondario continuare a discutere sullo statuto filosofico di Marx (idealista o materialista) mentre sarebbe necessario proporre una via d’uscita dall’empasse in cui la critica marxiana è finita?
Fino ad alcuni anni fa avevo l’abitudine di autocertificarmi e di autodefinirmi “filosofo marxista”, ma si trattava spesso di una pura intenzionalità ideologico – politica, di una testarda fedeltà alla mia giovinezza e ad amici defunti (Labica, eccetera), di un rifiuto dell’approdo liberaldemocratico o postmoderno, eccetera. Oggi capisco che si trattava di un inutile equivoco, ed ho rotto con questa autocertificazione.
In Marx esiste una specifica schizofrenia, che si tratta di individuare con precisione. Da un lato una filosofia della storia di origine idealistica (a metà fichtiana ed a metà hegeliana), fondata su di un uso originale del concetto di alienazione. Dall’altro una teoria della storia di tipo positivistico, fondata su di una concezione predittiva (o, più esattamente, pseudo – predittiva) delle leggi storiche, pensate come omologhe alle leggi delle scienze della natura (donde materialismo dialettico e teoria gnoseologica del rispecchiamento).
Questa schizofrenia non permette in alcun modo una coerentizzazione del pensiero complessivo di Marx, che infatti non è coerentizzabile. Il successivo marxismo Engels – Kautsky (1875 – 1895) non lo coerentizzò, ma edificò una variante di sinistra del positivismo su base gnoseologica neokantiana. Ebbene, meglio tardi che mai. Sebbene in ritardo, sono ormai estraneo sia all’illusione di avere scoperto il “vero” Marx, sia alla dichiarazione identitaria di appartenenza alla “scuola marxista”.
In quanto al fatto se Marx sia prevalentemente idealista o materialista, si tratta di un problema di storiografia filosofica che mi è ormai del tutto indifferente. Propendo tuttavia per l’interpretazione idealistica per un insieme di ragioni non storiografiche e non filologiche. Primo, troppo spesso il “materialismo” è o ateismo (con il bel risultato di far risucchiare il pensiero di Marx nel laicismo nichilistico), o strutturalismo (con gli esiti finali aleatori dell’ultimo Althusser), o teoria del rispecchiamento (adatta alle necessità conoscitive delle scienze della natura, ma non alla doppia conoscenza – valutazione veritativa delle filosofia). Secondo, idealismo significa scienza filosofica (vedi Scienza della Logica di Hegel), e la scienza filosofica dell’approdo alla libertà del concetto – soggetto è la sola alternativa alla scienza positivistica della previsione.
Il discorso sarebbe lungo, ma per ora può bastare. Comunque, per me oggi Marx non è più il solo classico di riferimento, ma è un classico fra gli altri, ed Aristotele ed Hegel gli stanno ormai davanti.
Uno dei centri della tua riflessione è la negazione della pertinenza attuale della dicotomia Destra/Sinistra come criterio di orientamento nelle grandi questioni politiche, economiche, geopolitiche e culturali.
Hai infatti più volte sostenuto la convinzione secondo cui la globalizzazione nata dall’implosione dell’URSS non si lasci più “interrogare” attraverso le categorie di Destra e di Sinistra, e richieda invece altre categorie interpretative. In un recente dibattito con Losurdo hai infatti scritto:
“La mia bussola di orientamento oggi si basa su tre parametri interconnessi:
- a) il principio di eguaglianza massima possibile all’interno di un popolo su diritti, consumi, redditi, partecipazione alle decisioni. Centralità del tema dell’occupazione. Posto fisso preferibile al lavoro temporaneo, flessibile e precario. Diritti eguali agli immigrati (che non significa immigrazione incontrollata). Messa sotto controllo del capitale finanziario speculativo di ogni tipo. Preferenza del lavoro rispetto al capitale. Difesa della famiglia e della scuola pubblica;
- b) il rifiuto del colonialismo e dell’imperialismo, che oggi hanno come aspetto principale l’impero USA ed in Medio Oriente il suo sacerdozio sionista, che utilizza per i suoi crimini il senso di colpa dell’Europa e dei suoi intellettuali rispetto al genocidio effettuato da Hitler, che ovviamente non mi sogno affatto di negare. Diritto assoluto alla lotta per la liberazione patriottica (lo stato nazionale esiste, eccome, ed è un bene e non un male, come dicono i seguaci di Negri e del Manifesto) per l’Iraq, l’Afganistan e la Palestina. Appoggio a tutti i governi “sovranisti” indipendenti (Venezuela, Iran, Birmania, Corea del Nord, Bolivia, eccetera), il che non implica necessariamente l’approvazione di tutti i loro profili interni ed esteri;
- c) considerazione dell’elemento geopolitico e rifiuto della sua virtuosa ed infantile rimozione. A differenza di Losurdo, non penso affatto che la Cina abbia una natura sociale “socialista”. Ma la appoggio egualmente, perché un equilibrio multipolare è preferibile ad un unico impero mondiale USA con vari vassalli (fra cui l’Italia è la più servile, con possibile eccezione di Panama e delle Isole Tonga). Chi appoggia questa cose è per me dalla parte giusta. Se poi si dichiara di destra o di sinistra, questo è affare suo, della sua biografia politica e della sua privata percezione valoriale. Ma la percezione valoriale è un affare privato, come i gusti sessuali e letterari e la credenza o meno in un Dio creatore”.
Lasciando da parte la pur pertinente critica avanzata da Losurdo, secondo cui ciò che tu cacci dalla porta rientra dalla finestra, cosa bisogna fare per tradurre (e – soprattutto – cosa accade quando si traduce) politicamente la critica di questa dicotomia?
Cosa distinguerebbe ciò dalla semplice riproposizione di un’ideologia da “terza posizione”?
Sebbene io sia spesso considerato un pensatore del superamento della dicotomia Destra / Sinistra (cosa che ovviamente non rinnego affatto), questo per me è ormai un argomento superato, secondario e poco interessante. Mi interessa invece il superamento del presupposto storico – ideologico della dicotomia, che è a sua volta la falsa dicotomia Progresso (sinistra) / Conservazione (destra). Per me il progresso e la conservazione sono solo opposti simmetrici in solidarietà antitetico – polare, ed io li respingo entrambi, il che mi costringe anche a respingere la loro concretizzazione identitaria (la dicotomia Destra / Sinistra appunto). Il prezzo da pagare in termini di fraintendimenti e diffamazione fa parte di quella costellazione chiamata da Heidegger “chiacchiera” (gerede). Come non sono né laico né cattolico, parimenti non sono né progressista né conservatore. Se devo definirmi in positivo lo faccio da solo, e non mi faccio classificare dagli altri, e per di più da altri maligni, ostili ed in malafede.
Sul così detto rossobrunismo c’è un equivoco da sfatare. Io non mi considero assolutamente un rosso-bruno, non lo sono e so di non esserlo, e questo non solo politicamente (non mi sono mai sognato di appartenere a gruppi rosso – bruni), ma anche e soprattutto filosoficamente. Il rossobrunismo è del tutto interno all’accettazione ideologica della dicotomia Progresso / Conservazione, e semplicemente vuole unire i “lati buoni” di entrambe le posizioni.
E così si coniugano insieme Marx e Nietzsche, Stalin e Mussolini, con il risultato di fare non solo una grande confusione, ma anche di offrire agli ideologi del potere (e cioè della pseudo democrazia come fantasma di legittimazione) un repertorio di diffamazione su di un piatto di argento. Un conto è essere rosso-bruni, ed un conto è essere oltre il Rosso ed il Bruno. Mi spiace di dover usare un lessico alla Nietzsche / Vattimo, che come sai non mi appartiene, ma è necessario insistere sul fatto che cercare di essere oltre la dicotomia Rosso / Bruno significa non essere né Rossi, né Bruni, né infine rossobruni.
Come scrisse Dante Alighieri, bisogna “lasciar dir le genti”. La capacità di ragionare è inversamente proporzionale all’esibizionismo presenzialistico, che oggi il facile accesso ad internet ed il superamento (Umberto Eco) della separazione fra alta cultura e cultura di massa ha portato a livelli socialmente e culturalmente intollerabili.
Il potenziale del capitalismo di generare crisi ambientali sorpassa di gran lunga quello di tutti i sistemi economico-sociali precedenti, e ciò è intrinseco alla sua stessa logica di sopravvivenza.
Ben lungi dal riconosce il comune interesse delle generazioni presenti e future per la natura e la società quali condizioni dello sviluppo umano, il capitale converte la natura e le relazioni sociali in puri mezzi di sfruttamento e di accumulazione monetaria.
Fulcro della tua proposta filosofica è l’insistenza sul fatto che l’etica comunitaria dei greci era basata sul metron (ossia la misura opposta allo smisurato), da te intesa come il “cuore sempre vivo dell’insegnamento dei nostri maestri greci”.
Nei tuoi studi sostieni infatti la tesi secondo cui la democrazia della polis antica era prima di tutto una tecnica politica rivolta a limitare e ad addomesticare la dinamica spontanea dell’arricchimento illimitato di pochi (dinamica che porta infallibilmente alla dissoluzione della comunità), dichiarando altresì che la filosofia stessa “trova la sua origine storica nella piazza pubblica greca detta agorà, in cui i cittadini mettevano in mezzo (es meson) la loro capacità di ragione, linguaggio e calcolo (logos), e che questa messa in mezzo comunitaria era rivolta a portare la misura (metron) nelle cose pubbliche di tutti (ta koinà), in modo che concedendo ai cittadini l’eguale accesso regolato alla parola pubblica (isegoria) si potesse raggiungere un nuovo equilibrio (isorropia), e questo nuovo equilibrio potesse portare infine alla concordia fra cittadini (omonoia)”.
A tuo parere Marx stesso è hegelianamente un avversario della “illimitatezza indeterminata”, ed è aristotelicamente un amico della misura nella riproduzione sociale; per il pensatore di Treviri la contraddizione fondamentale del capitalismo sarebbe perciò quella fra ricchezza per il capitale e ricchezza per i produttori e le loro comunità.
In una recente intervista hai inoltre sostenuto che “il problema fondamentale del capitalismo attuale sta nella dinamica di sviluppo illimitato della produzione capitalistica, e nel fatto che l’infinito-illimitato è il principale fattore di disagregazione e di dissoluzione di qualunque forma di vita comunitaria”. Sembri perciò auspicare una rinnovata applicazione del concetto normativo di metron al mondo sociale (ed ambientale); è così?
Murray Bookchin sosteneva che «Il capitalismo non può essere “convinto” a porre dei limiti al proprio sviluppo più di quanto un essere umano possa essere “convinto” a smettere di respirare»; Condividi tale affermazione? A tuo parere, il sistema capitalistico potrebbe tramontare perché costretto a darsi un fine diverso dal profitto, vale a dire la salvaguardia della base naturale (e conseguentemente sociale)?
Murray Bookchin coglie genialmente il cuore filosofico della questione del capitalismo, anche se non sono affatto ottimista sulla possibilità di riuscire a darci un fine diverso dal profitto. Per questo ci vuole sempre la buona vecchia rivoluzione, anche se non si vedono soggettività individuali (teoria) e collettive (prassi) in grado di riprendere sensatamente il progetto rivoluzionario. Comunità politica e decrescita economica sono per ora soltanto idee – forza senza basi storiche realmente efficaci.
In greco antico metron significa misura, ma il termine non ha nulla a che vedere con il concetto di misura della rivoluzione scientifica moderna, che ha permesso di passare dal mondo del pressappoco all’universo della precisione (la formula è di Alexandre Koyrè). Si tratta di una misura sociale e politica, legata al termine logos, che non significa soltanto parola pubblica o ragione (logos contrapposto a mythos), ma significa soprattutto calcolo sociale (il verbo loghizomai significa calcolare). L’unione fra logos (calcolo politico e sociale) e metron (misura politica e sociale) sta alla base della teoria della giustizia antica (dike), che non ha ovviamente nulla a che vedere con le moderne teorie della giustizia (Rawls, Habermas, Bobbio), che prescindono tutte dalla sovranità democratica sulla riproduzione economica, eretta ad un Assoluto che ha sostituito il vecchio Assoluto religioso cristiano (comparativamente migliore, a mio avviso, al di là della sua pessima funzione ideologica di legittimazione feudale e signorile).
Polanyi ha fatto molto bene a tornare al concetto di metadoni ed alla distinzione aristotelica fra economia e crematistica (su cui fonda la sua ricostruzione dell’umanesimo greco il filosofo Luca Grecchi). Tutti coloro che invece enfatizzano unicamente i due significati di logos come discorso pubblico o come ragione (ad
esempio Hannah Arendt), dimenticando che invece il significato principale di logos è quello di calcolo sociale rivolto alla doppia fatale dismisura del potere e della ricchezza (metaforizzata, a mio avviso, dall’apeiron di Anassimandro), ci ripropongono una grecità normalizzata e “decaffeinata” (per usare un arguto termine di
Slavoj Zizek). Ma una grecità correttamente interpretata sarebbe ancora più attuale non solo della liberaldemocrazia ottocentesca, ma anche della stessa tradizione marxista, ribadendo che ciò che generalmente passa per “marxismo” non è che un positivismo di sinistra a base gnoseologica neokantiana.
Vorrei soffermarmi ancora brevemente su tale concetto. Tu infatti sostieni che impadronirsi della genesi della filosofia (e della democrazia) come “razionalizzazione logica (logos) e dialogica (dialogos)” dei conflitti sociali in termini di scontro fra Misura (metron) e Dismisura (apeiron) “è di importanza eccezionale, perché permette di tenere ferma ancora oggi la centralità del conflitto sociale e politico senza più fare ricorso al concetto di Progresso”.
Sembri quindi delineare la possibilità che – attraverso il recupero del principio greco del metron – sia possibile criticare ogni apologia incondizionata del progresso “illimitato”; è così?
Hai inoltre recentemente sostenuto che il principio ideologico del progresso ed il principio filosofico dell’emancipazione devono essere non solo distinti, ma separati, evidenziando la necessità di abbandonare il primo senza rinunciare ad una prospettiva emancipativa. Puoi sviluppare più ampliamente questa tua idea?
Molto spesso i critici del principio ideologico del progresso sono anche scettici sulla possibilità di realizzare concretamente il principio filosofico dell’emancipazione (pensiamo alla dialettica negativa di Adorno, al pessimismo radicale dell’ultimo Horkheimer ed al famoso “un solo Dio può ancora salvarci” di Heidegger). Inversamente, si hanno anche sostenitori del principio filosofico dell’emancipazione che restano attaccati al principio ideologico del progresso (pensiamo all’ontologia dell’essere sociale di Lukàcs o all’utopismo escatologico di Bloch). Si tratta allora di capire se vi sia una terza strada, diversa sia da quella di Adorno, Horkheimer ed Heidegger, sia da quella di Lukàcs e di Bloch. Il principio ideologico del progresso ed il principio filosofico dell’emancipazione sono dunque inscindibili ed inseparabili?
Non lo credo, e si tratta appunto di una delle mie principali tesi filosofiche, ed una di quelle cui tengo di più. Il principio ideologico del progresso è “ideologico” appunto perché nacque al servizio di una legittimazione ideologica della borghesia europea settecentesca, che costruì una filosofia progressistica della storia universale (poi sistematizzata in forma ulteriormente meccanicistica, deterministica e finalistica dal positivismo ottocentesco e dal suo fratellino minore, il marxismo storico). Ma ad esempio già l’idealista Fichte fonda la sua teoria dell’emancipazione non su di una ideologia del progresso, ma su di una interpretazione radicale del diritto naturale. Lo stesso “progressismo “ di Hegel (indubbiamente un pensatore progressista) è assai più una teoria dell’acquisizione di una libera autocoscienza, che una teoria della successione obbligata di “stadi” nella storia, come avvenne più tardi nel marxismo, dottrina integralmente “progressista”. Georges Sorel fu uno dei pochissimi pensatori che cercarono di separare il principio del progresso da quello dell’emancipazione, e ritengo che si muovesse nella direzione giusta, anche se il suo codice teorico benemerito era indebolito da una insufficiente comprensione del pensiero greco e di quello idealistico. Ma si tratta di riprendere un secolo dopo il corretto programma di Sorel, radicalizzandolo con un esplicito ritorno al pensiero dei greci, che definirei sommariamente un pensiero della giustizia sociale e politica, sia pure in assenza di una filosofia della storia nel senso moderno del termine.
In diversi tuoi libri hai sostenuto la tesi per cui in verità la realtà in cui stiamo vivendo è quella di un’oligarchia o, più esattamente, un sistema oligarchico controllato congiuntamente da un circo mediatico e da una rete di mercati finanziari: “un sistema di potere periodicamente legittimato da referendum elettorali di facciata, che ha incorporato residui costituzionali della tradizione liberale classica”.
La democrazia sarebbe in realtà un fantasma di legittimazione, così come erano fantasmi di legittimazione il carattere cristiano della societas christiana del Medioevo europeo o il riferimento al pensiero di Karl Marx del comunismo storico novecentesco. Puoi precisare questa tua argomentazione, facendo riferimento alla prospettiva delineata ne Il popolo al potere?
Come già in due casi precedenti (l’interpretazione controcorrente del pensiero filosofico di Karl Marx e la ricostruzione controcorrente della storia della filosofia occidentale dai greci ad oggi) anche nel caso della filosofia politica moderna (di cui la teoria della democrazia è parte integrante) io perseguo un esplicito riorientamento gestaltico. La teoria moderna della liberaldemocrazia insiste su di una dicotomia virtuosa, quella Democrazia / Dittatura. La democrazia è il lato buono, la dittatura (nelle sue varie forme, fasciste, comuniste, populiste, fondamentalistico – religiose, eccetera) il lato cattivo. Io considero questa dicotomia un fantasma di legittimazione, e “fantasma” perché il fondamento della democrazie, il popolo, deve essere in qualche modo sovrano sulla forma essenziale della sua riproduzione sociale. Ma questa sovranità non esiste, perché è nelle mani di oligarchie che nessuno ha eletto. La dicotomia non è dunque oggi (parlo di oggi, non del 1930) Democrazia / Dittatura, ma Democrazia / Oligarchia.
Se si accetta questo riorientamento gestaltico (ma esso è rifiutato da tutto il pensiero universitario, mediatico e politico, non importa se di destra, di centro o di sinistra) il problema non è più di forma, ma di contenuto. E il contenuto sta nella sovranità militare (niente basi atomiche straniere sul territorio nazionale), ed economica (niente delocalizzazioni industriali, precarizzazione e flessibilizzazione del lavoro, eccetera), cui poi seguono “a cascata” tutte le altre sovranità (mediatica, culturale, linguistica, eccetera). È del tutto evidente che oggi non esistono neppure gli elementi minimi di questa sovranità, e per questo la presunta “democrazia” non è che un fantasma di legittimazione.
Vi è quindi “democrazia” oggi (sia in senso greco, che in senso popolare ottocentesco) soltanto quando si è in presenza di reali movimenti sociali e politici di tipo anti – oligarghico, che non si fanno spaventare dal teatro dei burattini delle accuse di “populismo”, categoria tuttofare che ha sostituito il vecchio mostro totalitario a due teste fascismo / comunismo, che è oggi obsoleto come la dicotomia Guelfi / Ghibellini. Benedetto Croce e Norberto Bobbio hanno fatto il loro tempo, e prima o poi forse qualcuno
se ne accorgerà, se riuscirà a perforare la crosta della dittatura ideologica dei mercati finanziari, dei politici, dei giornalisti e dei politologi universitari.
In questi ultimi anni hai lavorato moltissimo dando alla luce decine di importanti saggi (molti dei quali ancora inediti); prima di congedarci, ci concederesti qualche informazione circa i tuoi progetti editoriali futuri?
A proposito del lavoro svolto nei trent’anni precedenti io posso dichiararmi insieme soddisfatto ed insoddisfatto. Sono moderatamente soddisfatto sia per la quantità sia soprattutto per la qualità di molti miei lavori (non di tutti). È vero che non toccherebbe a me dirlo, ma penso che un autore debba avere una certa autoconsapevolezza soggettiva della natura del suo lavoro. Il riconoscimento sociale è stato pressochè nullo, ma tendo a pensare che la ragione di fondo sia dovuta all’assoluta novità delle soluzioni proposte, inaccettabili e irricevibili della casta degli “intellettuali di sinistra”. E’ possibile, anche se lo considero poco probabile, che ci possa essere un moderato riconoscimento postumo. In ogni caso, quando saremo ridotti in polvere, il riconoscimento o meno ci sarà del tutto indifferente.
Sono moderatamente insoddisfatto per almeno due ragioni. Primo, per l’incredibile ritardo identitario a sganciarmi anche formalmente dalla tribù marxista ufficiale – ufficiosa, laddove ormai ero divenuto un filosofo del tutto indipendente. Secondo, il fatto che da un lato ho sempre rimproverato Marx per non avere coerentizzato il suo pensiero, e poi dall’altro neanch’io sono riuscito a coerentizzare il mio. Lo ritengo una lacuna molto grave.
Detto questo, ad altri più giovani toccherà, se lo vorranno, giudicare il mio pensiero. Ritengo però che i miei lavori migliori e significativi siano ancora inediti, e ne segnalo il contenuto a quelle poche decine di amici di cui ho conquistato la stima.
Ho scritto molti saggi monografici su Marx, ma ce n’è ancora un ultimo inedito che ritengo più significativo di altri. In quest’ultimo ho esplicitato oltre ogni dubbio la mia interpretazione di Marx come pensatore tradizionale (e non progressista) e come filosofo idealista (e non materialista) e soprattutto come allievo minore di Aristotele e di Hegel. Non c’è nulla di definitivo finchè si vive, ma ritengo questa interpretazione il mio provvisorio bilancio definitivo di Marx.
Il lavoro cui tengo di più è però una mia originale storia della filosofia, di cui ho scritto una variante più breve (250 pagine) ed una più lunga (600 pagine). Si tratta di una ricostruzione dell’intera storia della filosofia occidentale che non ha precedenti (almeno a me noti), perché da un lato utilizza sistematicamente il metodo “materialistico” della deduzione storico – sociale delle categorie del pensiero filosofico (metodo proposto nel novecento da Alfred Sohn – Rethel, che io però utilizzo in modo del tutto originale), e dall’altro questo metodo è però inserito in una concezione pienamente veritativa del pensiero filosofico, ispirata non certo ai sociologi marxisti, ma ai greci e ad Hegel. È questo il lavoro che considero il più significativo della mia vita.
Vi sono poi alcuni saggi monografici inediti, non casuali, ma che compongono un disegno coerente. Primo, un saggio su Althusser, in cui esamino il suo pensiero, e ne prendo decisamente le distanze su di un punto essenziale. Mentre per Althusser l’equazione filosofica peggiore si scrive come (Soggetto = Oggetto) = Verità, questa per me è invece l’equazione filosofica migliore che si possa scrivere. Secondo, un saggio su Adorno, in cui prendo decisamente le distanze dalla dialettica negativa, considerandola in termini di una sofisticata apologia ideologica di adattamento al capitalismo travestita da opposizione radicale. Terzo, un saggio su Sohn – Rethel, in cui da un lato elogio il metodo della deduzione sociale delle categorie, dall’altro rifiuto la sua la sua critica dell’idealismo ed il suo sociologismo relativistico. Quarto, un saggio su Karel Kosìk, visto come uno dei pochissimi filosofi marxisti novecenteschi che non si sono vergognati di scrivere un capolavoro di filosofia pura (La Dialettica del Concreto) senza sempre travestirla da ideologia. Quinto, un ritorno meditato sulla Ontologia dell’Essere Sociale di Lukàcs, sempre lodata e stimata, ma anche questa volta maggiormente criticata per le sue insufficienze.
Vi sono anche altri studi sul comunitarismo, ancora inediti, e interventi su riviste che prima o poi qualcuno forse raccoglierà. Ma ciò che più conta in un filosofo è quello che i tedeschi chiamano Denkweg, e cioè il percorso di pensiero.
Approfondendo con radicalità il marxismo, ed applicando anche al marxismo stesso la marxiana critica delle ideologie (cosa che in generale i marxisti non fanno, mostrando così a tutti la loro miseria), sono arrivato alla fine a riscoprire il pensiero greco e la cosiddetta metafisica classica. E questo non certo per conversione o pentimento, ma al contrario proprio sulla base del metodo della critica immanente, metodo dialettico se mai ce n’è stato uno.
E con questo posso proprio chiudere.

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-07-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-07-2018)