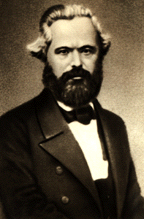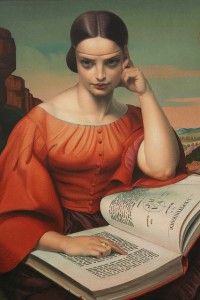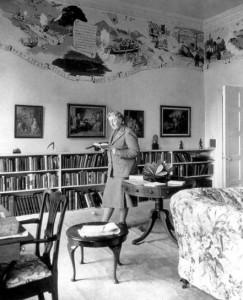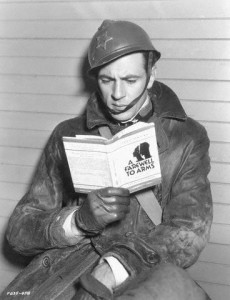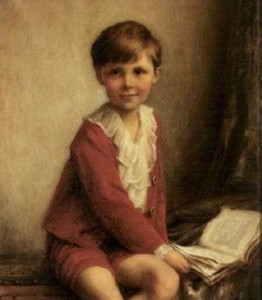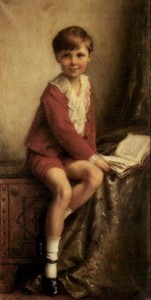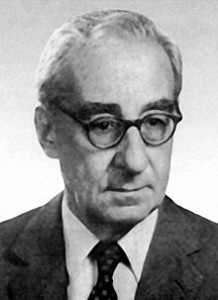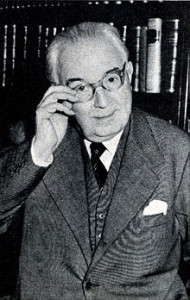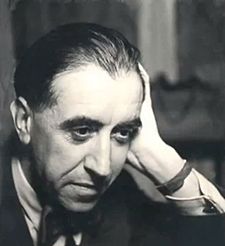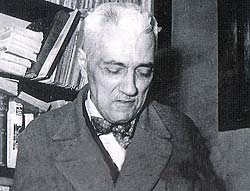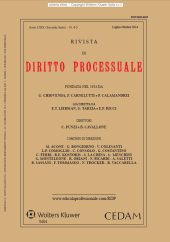Autore: ppci
Leon Battista Alberti (1404-1472) – L’animo degli studiosi sia acceso di virtù e di sapienza
L’animo degli studiosi sia acceso da una particolare brama
non già d’oro e di ricchezze,
bensì di virtù e di sapienza.
Leon Battista Alberti
Karl Marx – Il denaro è stato fatto signore del mondo
«Il denaro,
questa astrazione vuota ed estraniata della proprietà,
è stato fatto signore del mondo».
Karl Marx
Jean Despujols (1886–1965) – Donna con libro
Agatha Christie (1890-1976)
Marco Penzo – Alle origini del concetto di “comunismo”
Rappresentando per Marx comunismo la realizzazione di una società nella quale vale l’affermazione «a ognuno secondo i suoi bisogni»,[1] questo presupposto ci può portare a riflettere più dettagliatamente al pensiero comunista ai tempi a noi remoti dei Greci e dei Romani e in generale di quel mondo che definiamo antico: convenzionalmente il mondo antico si conclude con la deposizione di Romolo Augustolo e la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.), e, seguendo il Musti,[2] con la chiusura della Scuola di Atene (529 d.C.), che segna effettivamente la fine della grande storia del mondo greco antico, già debilitato dal 146 a.C., anno della distruzione di Corinto e fondazione della provincia di Acaia da parte dei Romani.[3] Ricordiamo però la storia greca manualistica si chiude in genere con la battaglia di Azio e la morte di Marco Antonio e Cleopatra nel 30 a.C.[4] Sta di fatto che un ordine “stabile” successivo alla fine dell’Impero Romano d’Occidente non si ha fino alla caduta dei Longobardi e la vittoria decisiva di Carlo Magno tra il 774 e il 776 d.C., che riporta in auge il concetto di Impero Romano, subentrando come figura legittima del potere imperiale (vedi la sua incoronazione a imperatore nell’800 d.C.) e come naturale successore dei Romani, e ufficiale avviatore di una nuova fase: ecco il Medioevo, quello che era nato con l’arrivo di popoli come Ostrogoti, Visigoti e Longobardi, ma che ha trovato autentica legittimazione e realizzazione con l’ascesa di Carlo Magno, guida dei Franchi.[5]
Ma, tornando al concetto di comunismo, forse dobbiamo riprendere i passi proprio dal mondo greco e così proprio dalla grande scuola di Atene, il pantheon della filosofia antica.
Pensando a Raffaello e alla sua opera della Scuola di Atene, ci ricordiamo dell’enumerarsi di figure storiche che hanno fondato il pensiero filosofico antico, con al centro della scena i due padri della filosofia antica (senza dimenticare il padre putativo, l’Ungaretti per gli ermetici, il Baudelaire per i simbolisti, del pensiero razionale greco, cioè Socrate): Platone e Aristotele.
Proprio questi due avrebbero creato “involontariamente” quella divisione che ben espresse l’ottimo Coleridge tra “platonici” e “aristotelici”, come ricorda ad esempio Pugliese Carratelli [6]: e mai come altri questi due pionieri del pensiero sono stati alla base del futuro pensiero di Marx, a mio dire uno degli ultimi grandi allievi di questi pensatori.
Bisogna però sottolineare che la concezione di comunismo nasce ben prima dell’evoluzione del pensiero della Trinità della filosofia greca Socrate-Platone-Aristotele.
Se vogliamo guardare molto lontano, Pettinato ci chiarisce che nell’arcaico periodo assiro sotto il regno di Ur III, fondato da Ur-Nammu e poi riformato da Shulgi si venne ad organizzare una società con principi che si possono definire comunisti (2100 a.C).[7]
Sta di fatto che nel mondo greco, e più precisamente nel VI secolo a.C., si fa risalire la prima e singolare esperienza del mondo classico: Pentatlo, uomo di Cnido che, trascinandosi nell’onda della colonizzazione greca dell’Italia, in particolare di Sicilia e Magna Grecia, tentò l’impresa di conquistare Lilibeo e Erice e sostenne Selinunte contro Segesta in una lotta che lo vide morire per mano degli Elimi, abitanti la Sicilia occidentale. I seguaci di Pentatlo in quest’avventura colonizzatrice si rifugiarono nelle isole Eolie e, probabilmente sulla base dei principi della loro guida, stabilirono una società di stampo comunista, dove Lipari era l’epicentro, mentre Stromboli, Vulcano e Salina le zone agricole. Seguendo il Musti[8] possiamo riassumere come fossero organizzate le terre, secondo una gestione di proprietà comuni o che venivano rese private limitatamente nel tempo: ogni 20 anni doveva avvenire una redistribuzione delle terre.
L’esperienza di Lipari non è però un caso così singolare: è lo stesso Musti[9] a sottolineare l’influenza dorica nella gestione “comunista” delle terre…
A proposito, viene da pensare a come i Dori in Laconia gestivano le terre, dividendole in parti uguali per la coltivazione e mantenendo il pascolo comune, sempre con la preoccupazione di gestire l’uguaglianza tra le genti “pari” e si ricorda come a Sparta si evitava l’uso di materiali preziosi come l’oro per la coniazione di monete, il tutto per scacciare quella sorta di ὓβρις tanto temuta dai Greci. Questo riporta Plutarco su Licurgo, lo storico legislatore spartano: «Licurgo si preoccupò di dividere le proprietà in modo che ogni sentore di irregolarità e di non eguaglianza potesse essere rimosso […]. Fece ritirare tutte le monete in oro e argento e impose l’uso delle sole monete di ferro. Di conseguenza a un peso e una massa grandi diede un valore insignificante, cosicché per 10 mine fosse necessario un largo ripostiglio in casa, e un giogo di buoi per trasportarle. Quando le monete ebbero corso, molti tipi di iniquità furono cacciati da Sparta».[10]
Questo concetto di moderazione, di limite, è fondamentale nel mondo antico: “in medio stat virtus” è il motto per eccellenza del mondo antico, e l’Etica Nicomachea di Aristotele il testo per eccellenza della ricerca dell’ἀρετή nella medietas. E grande fautore di questa moderatio fu il filosofo del numero, quel Pitagora che tanti conoscono per le formule matematiche, ma che forse non conoscono sotto l’ambito politico-sociale: per lui il numero è armonia, equilibrio, essenziale metro di valutazione della verità (in questo Platone, soprattutto quello più vecchio, si rifarà al pensiero pitagorico…). Il numero è il simbolo dell’ordine, quindi la società deve essere ordinata secondo questo metodo di armonizzazione. La società ideale è comunitaria, una società composta da “amici”: l’amicizia è fondamentale per una società di uguali e il “comunismo” diventa la filosofia della πόλις della Magna Grecia per eccellenza, Crotone, dove l’élite pitagorica assumeva forme certamente non prettamente o propriamente democratiche, ma comunque aristocratiche nel loro significato più nobile.[11]
Gli ἄριστοι sono nel mondo greco i “migliori”, coloro che hanno le competenze e le conoscenze per gestire la res publica: è ispirandoci a tali concezioni che arriviamo a Platone, che non solo è il massimo teorico del mondo antico sotto l’ambito politico, ma è in lui che il concetto di λόγος assume le sfumature più complete, da parola a dialogo, da ragionamento a numero. L’armonia delle idee, dei numeri porta a una concezione in cui l’uomo deve ricercare la felicità, e felicità per Platone è sapere: il mito della caverna riportato nella Repubblica[12] è l’esempio non solo gnoseologico della scoperta del Bene, ma anche uno dei primi manifesti politici sul compito dell’uomo, che nella sua pienezza è filosofo, amante della σοφία.
Tutti hanno la potenzialità di arrivare al Bene, ma molti di essi necessitano di una spinta, hanno bisogno della “discesa” al mondo della δόξα del filosofo, che rischia di essere disprezzato o ucciso dagli uomini[13], ma che fa del “comunismo della Verità” il suo scopo di vita. Il mito della caverna è grande perché dà la dimostrazione essenziale del valore non solo gnoseologico, ma anche e in un certo senso soprattutto morale del cammino del filosofo sganciato dalla δόξα.
Ed è per questo che mi permetto di definire Platone il “filosofo della libertà” del mondo antico, così come Marx lo è per il mondo contemporaneo.
Tornando a teorici di società con principi comunisti, Aristotele nella Politica parla di Falea di Calcedone, vissuto nell’età della sofistica, il quale voleva dividere in parti uguali i possedimenti per dare la maggior giustizia possibile;[14] così anche di Ippodamo di Mileto, famoso organizzatore della città e del Pireo basandosi sulla geometria pitagorica di cui fu grande sostenitore, il quale divise la società in 3 parti (soldati, artigiani, contadini) così come il territorio (comune, privato, sacro), seguendo il fatto che il 3 era il numero perfetto per i Pitagorici, tutto per ritrovare quell’armonia comunista di stampo pitagorico di cui abbiamo già parlato.[15]
E’ Aristotele a riportare le differenti teorie “comuniste” del mondo greco, ma mentre Falea e Ippodamo danno un senso tecnico più vicino alla realtà, per Aristotele il nostro Platone ha cogitato una società irrealizzabile[16]: si tratta del primo vero esempio di Utopia, nome dell’opera poi scritta da Thomas More e pubblicata nel 1516.[17]
Ma in cosa consiste questa società che per prima ha dato l’idea sì di utopia, ma anche l’idea di un mondo migliore? In Platone c’è il desiderio, la pretesa di portare un mondo ideale sulla Terra: in questo senso è un filosofo idealista, che vede nelle Idee dell’Iperuranio delle formule perfette che devono riportare la verità.
Una simile posizione non poteva essere apprezzata da un filosofo liberale come Karl Popper, il quale vide appunto in Platone (e in un certo senso, per ovvie ragioni, Socrate), ma anche in Hegel e Marx, gli ideologi del “totalitarismo”[18]: questa visione limita notevolmente la profondità del pensiero platonico e l’ambizione sociale di Hegel e Marx, che (e soprattutto il secondo), contrariamente a quanto possa pensare Popper, hanno cercato di dare un senso alla società umana intera. Per Hegel la storia si concludeva nel presente, “giustificando” il potere prussiano, mentre per Marx la storia è un processo da analizzare per cogitare una società più ugualitaria, in cui appunto il comunismo è il termine “ultimo”, il tipo di società dove ognuno ha la potenzialità di arrivare al Bene (volendo riprendere Platone) secondo, in fondo, quel principio successivo di Gramsci secondo il quale «tutti gli uomini sono “filosofi”».[19]
E in questo senso, ritornando a Platone, criticato da certa scuola marxista di essere antidemocratico,[20] contro cioè gli interessi dei più poveri e deboli, si può leggere una corretta visione platonica della società, che pure Aristotele ammette rifarsi alla democrazia oltre che all’oligarchia[21], o, meglio, all’aristocrazia di stampo pitagorico. Platone divide in 3 parti (vedi Ippodamo) la società: filosofi-guide, guerrieri, lavoratori. E’ una sorta di democrazia a piramide, dove per guidare uno stato-πόλις bisogna avere le competenze (ecco l’allievo di Socrate) e chi meglio di chi ha voluto affrontare l’uscita dalla caverna e salire al Sole, al Bene, può guidare la πόλις… E’ però lo stesso Platone ad intendere la potenzialità di ogni individuo ad arrivare all’Idea del Bene, l’ἀλήθεια per eccellenza: ritorna ancora fondamentale il mito della caverna, forse il più complesso di Platone.
Accusare Platone di antidemocrazia è fuorviante e sbagliato. Per sostenere questa posizione si può riportare la critica di Platone al possedimento smisurato della proprietà privata, che a maggior ragione i filosofi devono lasciar stare, perché contrastante con quel principio di medietas essenziale nel mondo greco e romano.
Il limite: ecco il comandamento dell’uomo antico. Platone fa valere più degli altri questo principio, che poi Aristotele esemplificherà benissimo nella differenza tra economia e crematistica, l’amministrazione della casa contro l’abuso di ricchezze,[22] e nell’affermazione di uomo come animale politico, cioè sociale.[23]
Per Platone non c’è spazio per il profitto, soprattutto nel Platone delle Leggi[24], e, se c’è, tale deve essere incamerato dallo Stato per l’amministrazione saggia e a favore del bene comune.
Se di comunismo dei beni si può parlare con Platone, quindi sotto un ambito prettamente economico, questo non si può propriamente dire nell’ambito sociale nel suo senso più esteso: tema centrale, soprattutto del mondo greco, è la schiavitù, e difatti lo schiavo per Aristotele, ad esempio, è pari a «un oggetto che respira»[25] (più tardi Varrone avrebbe utilizzato la formula «strumento che parla»[26]). Saranno gli Stoici, soprattutto quelli vicini all’ambiente romano, a rivalutare la figura dello schiavo. In particolare Seneca ed Epitteto dettero il via a un maggiore rispetto per questa classe sottomessa. Ma fu il pensiero e l’azione di Blossio di Cuma, maestro e sostenitore di Tiberio Gracco,[27] a risaltare questo atteggiamento impegnato a favore dei più disagiati: esaltò gli schiavi e si schierò dalla loro parte nella rivolta di Aristonico avvenuta nella seconda metà del II secolo a.C., il quale attirò a sé, più o meno legittimamente, più o meno onestamente, il favore degli schiavi nella lotta contro l’imperialismo schiavistico romano e nella sognata fondazione di Eliopoli, la Città del Sole che richiama verosimilmente all’Isola del Sole di Giambulo[28] e che potrebbe essere stata formulata grazie proprio alle teorie democratiche di Blossio.[29]
La Città del Sole[30] è anche il titolo dell’opera di Tommaso Campanella del 1602 che probabilmente si rifece, oltre che a Platone, anche a una simile vicenda.
Accanto a questa pretesa di giustizia sociale ante litteram, si affiancava in grandi intellettuali dell’epoca tardo-repubblicana la critica all’avidità di denaro (Sallustio[31]), ma anche un rivisitazione della condizione dello schiavo (soprattutto tramite gli storici Agatarchide di Cnido e Posidonio di Rodi[32]).
Sotto Roma lo schiavo poteva affrancarsi dal padrone e diventare liberto (cosa che non accadeva nel mondo greco): ecco quindi emergere i grandi Stoici del periodo imperiale romano, cioè Seneca, maestro di Nerone e sognatore, come prima Platone, di una società dove doveva regnare la giustizia, ed Epitteto, appunto liberto.
Pensiero affine a quello stoico era il pensiero cinico, al quale il fondatore delle Stoà, Zenone di Cizio, si ispirò per portare avanti i suoi precetti. Per i cinici, contrariamente alla visione del Greco classico, il lavoro, soprattutto manuale, era un valore: gli schiavi potevano avere dignità umana come i liberi. Ecco in quale ambiente culturale si sviluppò la manumissio dello schiavo, la sua emancipazione: il II e il I secolo a.C. furono appunto anche i periodi dove emersero le famose rivolte servili, due in Sicilia, e una, l’ultima, la più famosa e clamorosa (praticamente contemporanea alla guerra mitridatica, dove ci furono elementi servili sotto la guida di Mitridate…[33]), con Spartaco, il Trace che tra il 73 e il 71 a.C. ha scombussolato le file dell’esercito romano. Sempre con Spartaco, particolarità che ci collega agli Spartani e a Licurgo, si evitò l’uso di materiali come oro e argento a favore di bronzo e ferro[34]: in questo caso non c’era l’interesse per la coniazione di monete, ma vi era l’obbiettivo pratico di costruire armi per difendersi dai Romani (senza poi escludere una “superiorità morale” riportata da Urbainczyk[35]).
Anche nell’organizzazione della banda di Spartaco c’era un certo comunismo tra schiavi ribelli: l’intento era respingere l’imperialismo romano a favore della libertà comune.
Il comunismo non fu un elemento così fortuito, ma non era sviluppato al pensiero socialista di tipo “scientifico” marxiano: non si può parlare propriamente di rivoluzione in questo senso nel mondo antico, anche se, per concludere con Spartaco, ci furono delle avvisaglie di questa, tanto che lo stesso Marx nello scrivere a Engels, il caro amico, non nascondeva il fascino che scaturiva da Spartaco, risultando una delle figure più grandiose del mondo antico.[36]
D’altro canto, il comunismo assunse nel passato delle connotazioni particolari anche in ambito religioso: rimanendo soprattutto nell’ambito monoteistico, Giuseppe Flavio ci dice che gli Esseni (della cui comunità faceva probabilmente parte anche Gesù di Nazareth) erano un popolo che viveva in confraternite comunitarie dove vigeva la proprietà collettiva;[37] così i primi Cristiani, seguendo i precetti dei Padri della Chiesa, dovevano condividere i beni e disprezzare le ricchezze superflue:[38] non è un caso che dalla divisione del pane (corpo di Cristo) deriva il termine tanto caro ai sinistrorsi “compagno”…
Ma più di ogni altro fu Marcione che portò avanti quello che Mazzarino definisce «comunismo della carità»,[39] promuovendo uno stile di vita molto radicale sotto l’ambito dell’astinenza alimentare e libero dal matrimonio, a causa del quale secondo Marcione era vietato ricevere battesimo; comunque non c’era una pura e severa divisione tra battezzati e catecumeni durante le cerimonie, cosa che accadeva invece nel rituale del cattolicesimo primordiale.
Mazdak, figura importante del mondo persiano vissuta tra il V e il VI secolo d.C., portò avanti teorie in campo religioso, ma soprattutto in ambito sociale, dove si prevedeva la comunione dei beni per evitare cupidigia e inimicizia nella comunità.[40]
Come conclusione si può affermare che il comunismo fu presente sin dal mondo antico, ma naturalmente non nella formula marxiana: ovviamente Marx è un uomo della storia contemporanea, un filosofo che però fece del pensiero antico della Trinità greca Socrate-Platone-Aristotele un punto di riferimento fondamentale. In particolare Platone fu il vero riferimento ideologico del filosofo di Treviri, ma anche l’Ateniese non fu un innovatore ex-novo del comunismo, o più propriamente della comunione di beni: gli esempi soprariportati ci danno l’idea dello sviluppo di un pensiero, di un’azione che aveva origini precedenti alla nascita di Platone, così come società o ideologie di stampo comunista si ebbero successivamente avvicinandoci al Medioevo… Sarà con Marx che ci sarà la svolta decisiva, ma siamo in una società guidata dal capitale, che porta alla reificazione e all’alienazione dell’uomo: è il filosofo tedesco a svelare l’inganno del capitale e a lanciare contro di esso l’accusa definitiva.
Marco Penzo
Marco Penzo – nato a Sinalunga (SI) nel 1988, diplomato presso il Liceo Classico “F. Petrarca” di Arezzo e laureato presso la facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, si dedica con passione alla scrittura passando da poesia a saggistica.
Note
[1] K. Marx-F. Engels, Opere scelte, Editori Riuniti, Roma, 19692, p. 962. Questa citazione viene dalla Critica del programma di Gotha (1875). Cf. Atti degli Apostoli (At. 4, 35).
[2] Cf. D. Musti, Storia Greca, Laterza, Bari, 20063, pp. 849-850.
[3] Cf. E. Ciccotti, Storia Greca, Vallecchi, Firenze, 1922.
[4] Cf. G. Giannelli, Trattato di storia greca, Tumminelli, Roma, 19675.
[5] Per lo studio del passaggio al Medioevo cf. H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, PUF, Paris, 1937. Il testo è fondamentale perché spiega come l’economia europea fu “bloccata” dall’espansionismo islamico del VII secolo e come ci fu il successivo emergere di Carlo Magno, elementi che segnarono per l’autore definitivamente il passaggio dal mondo antico a quello medioevale.
[6] Cf. Platone, Discorsi sull’amicizia e sull’amore, introduzione di G. Pugliese Carratelli, a cura di E. Totti, Opportunity Book, Milano, 1995, p. 7.
[7] Cf. G. Pettinato, I Sumeri, Rusconi, Milano, 1994, pp. 283-289.
[8] Cf. D. Musti, op. cit., p. 193.
[9] Cf. Ibidem, p. 194.
[10] Plu. Lyc. 9.
[11] Come osservazione sul pensiero politico-sociale di Pitagora cf. C. Fiorillo-L. Grecchi, Il necessario fondamento umanistico del “comunismo”, Editrice Petite Plaisance, Pistoia, 2013, pp. 22-25.
[12] Cf. Pl. R. 514 a-517 a.
[13] Cf. Ibidem 517 a.
[14] Cf. Arist. Pol. II, 7, 1266 a-b.
[15] Cf. Ibidem II, 8, 1267 b.
[16] Cf. Ibidem II 1-6, 1260 b-1266 a.
[17] Cf. T. More, Utopia, Penguin, London, 2012.
[18] Cf. K. Popper, The Open Society and Its Enemies, Routledge, London, 1945.
[19] A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino, 2007, vol. II, p. 1375.
[20] Sull’argomento cf. C. Fiorillo-L. Grecchi, op. cit., pp. 25-26.
[21] Cf. Arist. Pol. II, 6, 1266 a.
[22] Cf. Ibidem I, 9, 1256 b-1258 a.
[23] Cf. Ibidem I, 2, 1253 a.
[24] Cf. Pl. Lg. 741 E.
[25] Arist. E.N. VIII, 13, 1161 b.
[26] Varr. R. R. I, 17, 1.
[27] Cf. Plu. T. G. 20, 7.
[28] Cf. D. S. II, 55, 1-2.
[29] Su Blossio cf. D. R. Dudley, Blossius of Cumae, “Journal of Roman Studies”, 31 (1941), pp. 94-99.
[30] Cf. T. Campanella, La Città del Sole, Arnoldo Mondadori, Milano, 1991.
[31] Cf. Sall. Cat. XI.
[32] Cf. K. Meister, La storiografia greca, Laterza, Bari, 20078, pp. 179-183, 198-204.
[33] Cf. Plu. Sull. 18, 8-10.
[34] Cf. App. B. C. I, 117, 547.
[35] Cf. T. Urbainczyk, Spartacus, Bristol Classical Press, London, 2004, p. 64.
[36] Cf. K. Marx-F. Engels, Opere XLI Lettere Gennaio 1860-Settembre 1864, Editori Riuniti, Roma, 1973, p. 176.
[37] Cf. J. B. J. II, 122.
[38] In merito cf. C. Fiorillo-L. Grecchi, op. cit., pp. 35-56.
[39] S. Mazzarino, Trattato di Storia Romana – L’Impero Romano, Tumminelli, Roma, 1956, p. 202.
[40] Cf. C. Fiorillo-L. Grecchi, op. cit., p. 18 nota 18.
Pico della Mirandola (1463-1494) – I “sapienti” che lucrano
Ormai non vengono ritenuti sapienti
se non quanti rendono lucroso lo studio della sapienza.
Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate.
Gary Cooper (1901-1961)
Herbert James Draper (1863-1920)
Fabio Pecoraro – Salvatore Satta nei suoi «Soliloqui e colloqui di un giurista». Riconoscere che la scienza nasce dalla vita e non la vita dalla scienza
Salvatore Satta
Carissimo Carmine,
raccolgo il tuo invito a dare un piccolo contributo al blog Petite Plaisance. Ci siamo conosciuti in occasione del mio lavoro, più volte abbiamo parlato di giustizia e di diritto ed è per questo, ma non solo per questo, che rivolgo ai lettori, un invito alla lettura certamente ardito, per il tecnicismo di alcuni contenuti, ma di grande spessore umano. Si tratta, peraltro, di una lettura quasi impossibile anche dal punto di vista del reperimento del volume ed è per questo che trascriverò alcuni passaggi che ho particolarmente apprezzato, procurando, se non altro, beneficio a coloro i quali avrebbero, comunque, saltato i passaggi più strettamente giuridici. Il libro è una raccolta di scritti di Salvatore Satta, edita da Ilisso nel 2004, intitolato Soliloqui e colloqui di un giurista. E giurista è stato, Satta, tra i più grandi del secolo scorso, allievo di grandi maestri e a sua volta maestro di molti studiosi. Come giurista, si è occupato, prevalentemente, di diritto processuale civile, ma come un altro grande suo contemporaneo, Piero Calamandrei, egli è stato anche un “letterato”, capace di una accuratezza di linguaggio che, più che esser figlia di un certo modo di studiare o di abitudini di lettura ormai quasi scomparse, sembra, più radicalmente, figlia di un modo di vivere e di un mondo che, rassegnamoci, non c’è più.
Salvatore Satta
Di Satta ho sentito parlare, per la prima volta, nel 2001, dal Prof. Ferdinando Mazzarella, allora titolare della cattedra di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Palermo. Mazzarella, quell’anno, avviò il ciclo di lezioni con un suggerimento letterario ed esso riguardava il piccolo volumetto di Satta, edito da Adelphi, Il mistero del processo. «Potete studiare la materia su qualsiasi libro – ci disse – perché questa materia si studia sul codice, ma questo libro, se potete, leggetelo». Lo comprai e confesso che, sulle prime, non fu una lettura facile. Dopo alcuni anni, dopo la laurea, quando il processo mi era diventato più familiare, per quotidiana frequentazione delle aule di giustizia, sentii il desiderio di ritornare a quel suggerimento. A quel punto, la lettura mi rivelò, non solo e non tanto un contenuto che, la prima volta, non avevo colto, ma la grandezza stessa dell’autore; decisi, così, di procurarmi altre opere. Comprai La veranda (Ilisso 2002), De Profundis (Ilisso 2003, riedizione di una precedente uscita CEDAM del 1948) e con l’aiuto di un amico libraio, riuscii a procurarmi anche Soliloqui e colloqui di un giurista. La veranda è un romanzo di grande intensità, tratto da una esperienza personale dell’autore di soggiorno in un sanatorio. Descrivendolo farei un torto all’opera, ma voglio accennare ad una particolarità di questo libro, perché esso risale al 1927, epoca in cui il giovane Satta non era ancora il grande studioso che poi sarebbe divenuto e coltivava, forse, ambizioni di scrittore come, probabilmente, molti di noi a quell’età. De profundis è un libro scomodo, tutt’altro che allineato, che tratta dell’ultimo quarto di secolo della nostra storia patria, rivelando la grande capacità dell’autore di guardare la realtà nel suo concreto estrinsecarsi, fuggendo al fascino ed alla convenienza che certi inquadramenti formali, certe entificazioni, esercitano.
Da frequentatore del diritto, però, la lettura più formativa è stata proprio quella dei diversi “pezzi” da cui è composto Soliloqui e colloqui di un giurista. La selezione di articoli comparsi su riviste specializzate, di prolusioni, discorsi commemorativi ed altro ancora, è stata fatta dallo stesso Satta che, in questo modo, mette il lettore nelle condizioni di cogliere, leggendo tra le righe di specifici soliloqui o colloqui, il senso stesso della sua natura «intranquilla» di studioso e prima ancora di uomo.
Trattandosi di una raccolta di scritti eterogenei, è necessario che il mio invito alla lettura manifesti subito la ratio della selezione che ho operato, scegliendo quelli in cui minore è il peso del linguaggio tecnico giuridico, anche se i Tuoi più attenti lettori non potranno non apprezzare, in Satta, una spiccata capacità a parlare delle cose della vita affrontando argomenti tecnici dimostrando, così, vere doti di docente, oltre che di studioso.
Il libro si compone di sei parti (Soliloqui, Il libro delle prefazioni, Confessioni e battaglie, Saggi critici, Colloqui, Res gestae) e di una Appendice sullo Spirito religioso dei Sardi. Il passo che segue, è tratto dai Soliloqui e tratta del «formalismo nel processo».
Spesso, il linguaggio, lo stile di scrittura e l’esistenza stessa (nella vita quotidiana extra lavorativa) di chi pratica il diritto nei tribunali è permeato, in modo più o meno voluto e ricercato, da un certo formalismo che inevitabilmente allontana “gli altri”. Il cittadino che “incappa” in questioni giuridiche che abbisognano di esser discusse nelle aule dei tribunali, incontra una realtà spesso incomprensibile fatta di particolari di assoluto rilievo ed evidenze irrilevanti. L’occasione, per Satta, è il quarto Convegno dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile, tenutosi il 4 ottobre del 1958
«Il formalismo comincia dove il diritto finisce. Esso rappresenta veramente una frattura dell’esperienza giuridica: al posto dell’esperienza e del suo libero movimento si pone una falsa esperienza, cioè l’immobile vuoto, che si tratta come cosa salda, modellandolo in forme che essendo forme del vuoto, hanno il pregio di essere infinite» (p. 72).
L’attaccamento al concreto che, da giurista, Satta manifesta in queste parole rappresenta un motivo conduttore, forse, della sua intera opera. Basta leggere il suo De profundis per cogliere la sua propensione al racconto ed alla analisi di una verità fatta di cose reali, anche a costo di omettere passaggi che, per molti, sono invece di essenziale importanza. Il formalismo di cui Satta parla «è unico e unitario, come l’esperienza della quale è in certo modo la scimmia», ma l’attenzione dell’autore è posta a ciò di cui il giurista “vive”.
«Nel suo profondo lavoro di astrazione il giurista elabora dei concetti, vale a dire, comprende, secondo l’etimologia della parola, la realtà, ne scopre e ne fissa l’essere, cioè la forma essenziale, l’ordine per cui essa è giuridica. Nulla è più legittimo di questa elaborazione, che costituisce il proprium della scienza giuridica, e la rende eccellente su tutte le altre, perché i concetti che essa elabora hanno un effettivo valore, sono la stessa realtà. Il grave pericolo di questa elaborazione, comune a tutto il pensiero speculativo, ma particolarmente sensibile per il giurista, è che a un certo punto le posizioni si capovolgano, come in quel singolare esperimento della topologia per cui dalla superficie dritta si passa invisibilmente alla superficie rovesciata, cioè si aboliscono le due superfici: e così i concetti acquistino una tale assolutezza da diventare generatori della realtà, in luogo di essere generati, un arcano immobile mondo al quale il concreto mutevole mondo dell’esperienza deve adeguarsi. È una sorta di teologismo o di donchisciottismo giuridico, una posizione diametralmente opposta a quella dell’empirismo, e di questa non meno pericolosa per la conoscenza. Nessuno dubita, ad es., della verità del concetto di ordinamento giuridico, e della sua adeguatezza a rappresentare la realtà stessa, in quanto appunto si presenta ordinata. Ma questo stesso concetto acquista a un certo punto tanta forza di suggestione che si stacca dalla realtà ordinata, della quale si presenta come ordinatrice, un Ordinamento con la o maiuscola, una personificazione o deificazione, del quale si dice che si attua, che si concreta, che si viola, che ha i suoi ministri, e al quale gli uomini sono soggetti ed estranei» (p. 76).
In questo passaggio, che prosegue con un altro esempio (che ometto per brevità), Satta sembra esprimere quello scollamento dalla realtà che, il più delle volte, rende il diritto qualcosa di estraneo ai membri della societas, di cui pure è espressione tra le più alte.
«Non vi è bisogno – prosegue l’Autore – di illustrare i guai che questa deformazione produce: e sarebbero guai sopportabili se restassero sul piano della conoscenza teorica. Alla fin fine, il mondo uno se lo concepisce come vuole. Ma purtroppo nel diritto la conoscenza è esperienza; e non esiste dualismo tra teoria e pratica».
Le conclusioni cui Satta giunge in questa sua riflessione, sono in linea con il suo sentire, tenacemente attaccato alla concretezza delle cose, in una prospettiva profondamente “umanistica”:
«[…] non esiste una ricetta, non esiste una formula che, operando dall’esterno, elimini il formalismo. Non leggi, non ordinamenti, non costituzioni, non soprattutto riforme imposte dall’alto, nulla vale a distruggere questo singolare atteggiamento dello spirito umano: anzi, come ho detto, la storia ci insegna che ogni tentativo fatalmente conduce ad esasperarlo. Per raggiungere qualche risultato bisogna operare dall’interno, cioè da noi stessi, compiere quel profondo atto di umiltà di fronte alla vita che è stato espresso per i medici, ma che vale per tutti: cura te ipsum. Riconoscere che la scienza nasce dalla vita e non la vita dalla scienza; ammettere che tutte le nostre costruzioni, i nostri sistemi sono relativi; o se si vuole, che il concreto, cioè la vita nel suo continuo mutamento, richiede un’adesione spirituale che trascende i limiti della scienza» (p. 82).
Il costante richiamo al “concreto”, secondo me, è uno dei più grandi insegnamenti che Satta lascia agli studiosi del diritto e credo che il nostro Paese – attraversato da continui, ma sempre deboli e poco ispirati, venti di riforme, promosse da una classe politica incapace di correggersi, per la quale la “riforma” è pura velleità – il nostro Paese, dicevo, sarebbe un posto più semplice in cui vivere, se i costruttori di leggi realizzassero quale è il compito del giurista:
«Ogni giorno di più acquistavo coscienza di quello che era il mio compito, e il compito di ogni giurista: non costruire, ma vedere, ma leggere con semplicità nei fenomeni, e descriverli nella loro genesi e nella loro funzione. La costruzione non è opera del giurista, sia esso legislatore o interprete, che non è e non deve essere creatore. Sotto questo angolo visuale, tutto acquistava concretezza e chiarezza, perché concreta e chiara è la realtà dei rapporti sociali» (p. 137).
Il passo è tratto dalla prefazione al volume Esecuzione forzata del 1937. Sono parole che, se poste idealmente al cospetto delle ardite costruzioni, proceduralizzazioni, astrazioni di cui il nostro ordinamento è saturo (e che lo rendono altamente inefficace sia sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra privati, che sotto quello delle norme che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione), fanno emergere la violenta “presunzione” di molti operatori del diritto.
Voglio avviarmi a concludere questo mio piccolo scritto, su un autore che meriterebbe migliore e maggiore attenzione di quella che le mie risorse e la pazienza di chi vorrà leggere permettono, virando il discorso su un profilo più strettamente “umano” che traspare nell’opera di Satta continuamente, ma che egli, di tanto in tanto, permette a se stesso, indugiando in ricordi, malinconie e – perché no – qualche sana arrabbiatura. A tal proposito, la prefazione del volume sull’Esecuzione forzata, del 1937, chiude con una dedica al fratello Filippo, preferito, per questo scopo, al padre morto da anni, proprio perché vivo ed in grado di apprezzare la dedica di un libro giuridico che, come egli stesso afferma non può e non deve appartenere alla vita interiore di chi lo scrive (p. 138). Alla voce malinconie, colloco il riferimento, carico di suggestioni, a Francesco Carnelutti, grande antagonista scientifico di Satta, da questi definito «grande uomo». La presentazione della settima edizione del Manuale di diritto processuale del 1967 così recita:
«Nel 1948 mi lanciavo con questo libro verso gli anni a venire; oggi mi par di procedere come gli indovini di Dante, col capo voltato sul dorso. Gli ultimi grandi esponenti della scienza postchiovendiana, Calamandrei, Redenti, Carnelutti, se ne sono andati, se ne è andato Capograssi, se ne è andato Ascarelli, precursori di una scienza nuova. (Io sono rimasto. Ma non ne sono tanto sicuro. Forse sono ibernato.) C’era, in quegli anni, un’atmosfera da grandi colloqui, e nei colloqui si rifletteva una terra sconvolta dalle più dure esperienze, la paura di queste esperienze, il coraggio di volerle comprendere, anche a costo di ricominciare da capo. Dove sono le male parole che Carnelutti scagliava contro ogni mio libro, a cominciare da questo: dove le mie irriverenti risposte? Non ho mai capito il principio del contraddittorio come da quando il grande uomo non c’è più» (p. 151).
Quando leggo queste parole, il confronto con il livello attuale dello scontro tra portatori di pensieri differenti è impietoso. L’atmosfera di «grandi colloqui» a cui Satta fa riferimento è certamente, almeno nell’immediato, circoscritta all’ambito del diritto, così come erano certamente circoscritte ad esso le «male parole» che egli riceveva, ricambiando con «irriverenti risposte», da Carnelutti, ma quanta differenza, quanta distanza tra quei colloqui e quelli a cui oggi siamo abituati!
Sul finale della stessa presentazione, Satta rivolge al lettore altre parole di grande suggestione:
«Bisogna che il pensiero rinasca, e imponga la sua legge. E questo non può avvenire in un giorno o in un anno, o forse in cento anni, né può essere opera collettiva, poiché i tempi della follia collettiva sono passati, e la speranza è ormai riposta nella follia individuale. Bisogna che ognuno, nel suo piccolo, riconosca per sé e per gli altri l’esigenza del pensiero nihil inde sperans. O meglio, avendo come sola remunerazione la speranza» (p. 154).
Se avesse voluto dirlo in inglese, forse, avrebbe scritto “stay foolish”, come qualcun altro, molti anni dopo, avrebbe detto.
Nella presentazione al primo volume del Commentario al codice di procedura civile, anno 1959, Satta spiega «come ha studiato» e lo fa con queste parole:
«Di solito, lo studio evoca l’idea di una biblioteca, e di un signore che legge e legge col proposito e col risultato di aggiungere, negli scaffali e nel catalogo, un altro volume. Ci possono essere, nelle scienze così dette sperimentali, alambicchi e storte, ma la cosa non muta gran che. Dico subito, a scanso di equivoci, che questo studio è non solo legittimo, ma assolutamente essenziale. Nessuno può pensare di avere una voce viva se non ha ascoltato le grandi voci morte, se non ha vissuto in comunione coi padri, se non ha ripercorso le loro vie, oserei affermare se non ha creduto più che nelle loro verità, nei loro errori. Al di fuori di questo, tutto è sterile dilettantismo. Personalmente aggiungo, ho trascorso coi libri gli anni più belli della mia vita, e se di una cosa mi dolgo è di non aver potuto, per pochezza di forze e per private vicende, abbracciare tutto il pensiero di quelli che mi hanno preceduto» (p. 155).
Nella prefazione al secondo volume del medesimo Commentario, pubblicato un anno dopo, l’Autore sembra voler precisare:
«Ma se noi possiamo capire il linguaggio dei padri, non possiamo, non dobbiamo più parlarlo. Insistendo a farlo, ci riduciamo, nel migliore dei casi, a puristi del diritto, usiamo veramente parole che sono un mero suono, concetti che non hanno più alcun contenuto, non ‘comprendono’ più nulla» (p. 162).
Chiudo con alcuni passi tratti da una polemica che coinvolse Satta, nel 1967. Mazzarella aveva pubblicato un libro dal titolo “Contributo allo studio del titolo esecutivo” e la Rivista di diritto processuale, già diretta da Carnelutti, lo recensisce in un modo che provoca in Satta una vivace, nostalgica, reazione:
«Quando osservo la nuova copertina della Rivista di diritto processuale, e al posto di Carnelutti e della sua imponente solitudine vedo una sfilza di nomi, allineati in bell’ordine come consiglieri di amministrazione, mi vien fatto di pensare a quel mitico drago, cui, dopo la morte, furono strappati i denti, e dai denti seminati vennero fuori tanti soldatini, che si misero a costruire le mura di una città. Il mito, se non erro, è quello di Cadmo, la regione dove il mito nacque fu chiamata Beozia, e fu la patria di Esiodo e Pindaro.
È stata davvero un’idea curiosa quella di credere che la sede vacante potesse essere riempita da un governo di massa, come a dire che la quantità potesse sopperire alla qualità. E pazienza se gli uomini di quantità si fossero assunti il compito devoto quanto assurdo di mantenere nel tempo un’opera che col suo creatore usciva fuori dal tempo: ma essi si sono presi sul serio, hanno creduto di essere, per il solo fatto della inscriptio, figli del drago, draghi essi stessi, nove draghi al posto di uno. È di ieri una recensione di V.D. (trasparente sigla di uno dei dragonetti) a un libro di Massa che comincia così: ‘Il Massa appartiene alla schiera (per fortuna non troppo numerosa) di coloro che credono che il pensiero di Capograssi non solo esprima una personale e irripetibile esperienza, ma possa anche fornire un metodo valido per gli studi giuridici in genere e per quelli processualistici in particolare’. Avete capito? V.D. e Capograssi, quel Capograssi davanti al quale Carnelutti si faceva, e si diceva piccolo piccolo, il cui metodo è tanto poco valido (meglio si direbbe tanto poco metodo) che ricreò Carnelutti, e ricreò la sua stessa rivista, come può agevolmente vedersi scorrendo le annate dalla fine della guerra fino all’avvento di V.D.
È di oggi un’altra recensione, stavolta del dragonetto E.G., che mi ispira queste note. Ma prima voglio sottolineare che i successori a titolo originario di Carnelutti hanno avuto l’imprudenza di conservare la famosa rubrica delle recensioni, dalla quale il drago ha dominato a suo modo per quarant’anni giusti la scena della vita giuridica italiana. Non hanno inteso che questa sì era una esperienza irripetibile, perché Carnelutti capiva i libri senza leggerli, mentre essi li leggono senza capirli. Questo è appunto il torto che io faccio a E.G.: di aver letto il libro di Mazzarella, Contributo allo studio del titolo esecutivo» (p. 268).
Poco più avanti, prima di addentrarsi nel merito, l’affondo:
«È chiaro che io non intendo qui fare una controrecensione: ci penserà M., se crederà, a difendersi nella stessa rivista, come ne ha anche giuridicamente diritto. A me interessa parlare del libro unicamente perché E.G., dopo averlo bistrattato, mi ha tirato imprudentemente in causa, rendendomi praticamente responsabile del fatto che il libro (come a dire la mia opera) confonda, più di quanto non chiarisca, le idee agli studiosi del titolo esecutivo.
Come un libro possa confondere le idee ‘agli studiosi’ mi pare difficile capire a meno che E.G. non identifichi gli studiosi con se stesso, o con gli intangibili professori di ruolo in generale. Comunque dimentichiamoci di avere davanti E.G. anziché Carnelutti, e vediamo di dire qualcosa che possa tornare utile alla scienza».
Il seguito alla pubblicazione di questo scritto, la Rivista di diritto processuale pubblicò, a firma della direzione, un trafiletto nel quale additavano Satta come «un cattivo esempio ‘per aver offeso il diritto fondamentale che ha ogni studioso, al pari di ogni uomo, al rispetto della sua dignità’». La risposta di Satta, pubblicata nella postilla alla ristampa del medesimo articolo, rivela la profondità e la sagacia dell’uomo:
«La Rivista di diritto processuale è padrona di abbrunare la sua bandiera. Ma l’equivoco è evidente. È incontestabile che ogni uomo possiede bergsonianamente la sua dignità, per il solo fatto di essere uomo, né io credo di aver mai offeso la dignità di nessuno. Ma lo studioso non ha una sua dignità, cioè per lui il problema non si pone in termini di dignità, ma di valore. Sulla sussistenza di questo valore il giudizio è libero, né costituisce mai, salvo assurdi privilegi, offesa. Pertanto io non solo non ho dato un cattivo esempio, ma ne ho dato uno ottimo, e i giovani farebbero bene a seguirlo in ogni occasione» (p. 274).
Con queste parole, davvero, concludo, ringraziando te per l’occasione che mi hai dato di riaprire Soliloqui e colloqui di un giurista ed i tuoi lettori, per la pazienza e per l’attenzione.
Fabio Pecoraro