Guillaume De Lorris (1200-1238), Jean de Meun (1250-1305) – La vera nobiltà nasce dal buon cuore e nella capacità e volontà di vivere i valori che a parole si propugnano. Chiunque vi aspiri si guardi dall’orgoglio e dall’ignavia, si dedichi allo studio, si liberi da ogni villania. Gli amori muoiono quando gli amanti vogliono imporsi come signori.

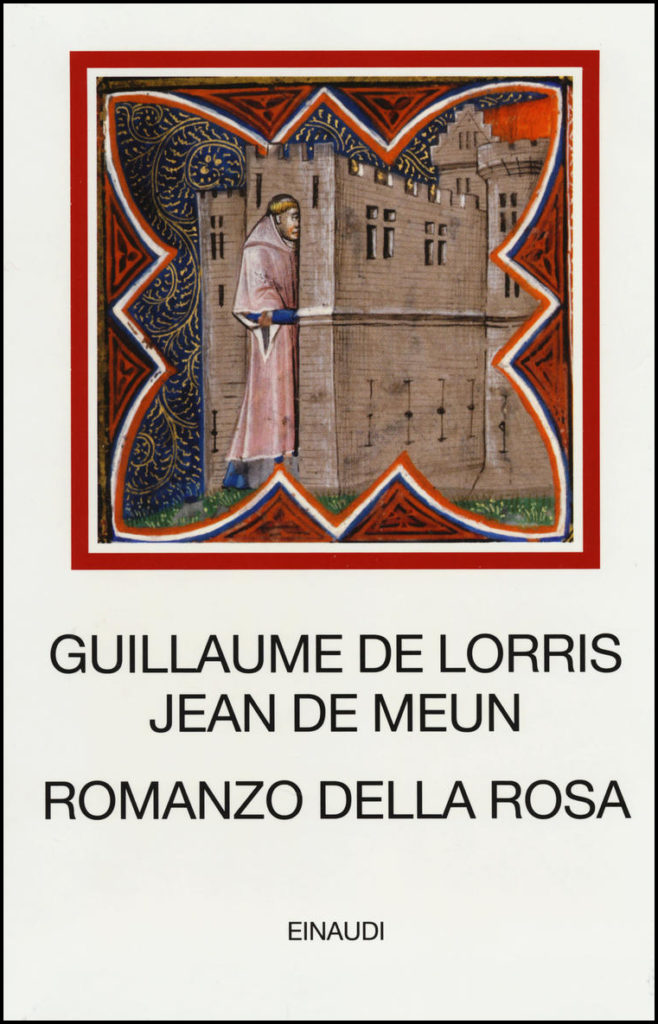
La vera nobiltà nasce dal buon cuore, perché la nobiltà ereditaria non è una nobiltà di valore quando le manca la nobiltà del cuore; per questo vi si deve mostrare il valore degli antenati che la conquistarono con le grandi opere che seppero compiere. La nobiltà degli intellettuali si misura sulla loro capacità e volontà di vivere i valori che a parole si propugnano. La nobiltà nell’intellettuale si nutre dello spirito dell’antico per trasformarla in carne vissuta. Non vi è nobiltà nel chierico corrotto come nello studioso che lascia i grandi del passato tra le righe del manuale e non li rende attuali.
La nobiltà dell’intellettuale vive nello studio, nella gioia che sospende l’utile per la contemplazione attiva del sapere.
Salvatore Bravo
Leggere «Il Romanzo della Rosa»
La verità vive nelle opere degli esseri umani: emerge improvvisa dopo il suo andamento carsico. Il Romanzo della Rosa (1237) poema allegorico di 21.780 ottosillabe di Guillaume De Lorins e Jean De Meun ne è un esempio. È l’odissea della verità nelle sue disavventure, è l’affrontamento tra verità e opinione, tra processi di umanizzazione ed entificazione dell’essere umano. Dominio e suo smascheramento. Ipostatizzare, rappresentare i rapporti di potere come immutabili, sclerotizzare i processi di conoscenza per impedire alla verità di riemergere e riavviare il cammino dell’uomo nella storia è sempre un risultato parziale e momentaneo. La verità in forme inaspettate nel tempo riemerge, smaschera, accusa l’ideologia e la falsa coscienza. Nel Medioevo – perennemente posto sotto accusa dalla ragione illuministica e tecnocratica – il Romanzo della Rosa rivela una verità eterna degli esseri umani: la relazione di potere aliena, nega la naturale disposizione alla condivisione, al dono. La relazione di coppia è il luogo emotivo nel quale la prassi comunitaria si concretizza nel governo delle passioni duali che divengono modello per una giusta comunità. La relazione si umanizza nella libertà dell’uguaglianza, dei bisogni autentici ascoltati. Se la sovrastruttura di potere rende disomogenee le geometrie delle relazioni, se le fissa in ruoli predeterminati dalle gerarchie di potere, senza la condivisione, si disperde l’essenza umana, e resta solo uno scheletro formale privo di linfa vitale. Nel regno del potere l’essere umano è solo un atomo chiuso in se stesso, incapace di elaborare relazioni ontologicamente fondate, e si attua la morte dello spirito nella cecità da cui siamo avviluppati nel pensare e sentire l’altro:
«Compagno, ecco lo stupido villano geloso, sia gettata ai lupi la sua carne! Che io vi porgo come esempio: egli è gonfio di gelosia e vuole essere il padrone della donna; ma anche lei non deve far da sola padrona, ma essere sua pari e sua compagna, come loro consiglia la legge. E anche lui deve essere il suo compagno senza farsene signore e padrone; e quando lui la sottopone a quei tormenti e non la considera come sua eguale, e anzi la fa vivere in un tale disagio, credete che questo a lei non dispiaccia e che l’amore tra di loro non fallisca, checché ne possa lei dire? Sì senza dubbio. Mai sarà amato dalla sua donna colui che vuole esserne chiamato il signore, perché è normale che gli amori muoiano quando gli amanti vogliono imporsi come signori».[1]
Le gerarchizzazioni sono innaturali, costringono in ruoli, disegnano emotività che impediscono il naturale fluire delle passioni, della comunicazione. Al loro posto la struttura sociale costringe il corpo vissuto in un’armatura innaturale. Le donne – come ogni essere umano – non nascono nel segno delle catene. Non esistono oppressioni ed oppressori per natura. È la cultura delle civiltà che elabora i codici dell’oppressione, che cade nella trappola di Tucidide, ovvero della paura, del bisogno di controllo acquisitivo; solo con la violenza perpetua ed il controllo continuo può tenere salda l’armatura del potere. La verità non può essere scalfita dalle sovrastrutture, per cui silenziosa riemerge: la natura oppressa, rimossa, calcificata nelle abitudini del cattivo potere riprende il suo territorio:
«D’altra parte le donne sono nate libere; la legge le opprime, togliendo loro la libertà in cui erano state messe da Natura; perché Natura non è così sciocca, se ci pensiamo bene, da aver fatto nascere Mariotta soltanto per Robin, né Robin per Marietta, o per Agnese o per Pierina, ma ci ha fatto caro figliolo, non dubitarne, tutte per tutti e tutti per tutte, ognuno in comune per ognuno, e ognuno in comune per ognuna; e anche quando loro sono fidanzate, prese legalmente e maritate per evitare le separazioni, le contese e le uccisioni, e per favorire la buona crescita dei figli dei quali insieme hanno cura, le signore e le signorine, siano brutte o siano belle, si danno da fare in tutti i modi per ritrovare la loro libertà».[2]
La vera nobiltà
La nobiltà non è di ordine acquisitivo, non è un possesso del blasone o genetico. Ogniqualvolta un gruppo sociale o culturale si dichiara nobile per natura, ponendo un confine tra sé e gli altri, costruisce la trama ideologica del potere. La nobiltà è potenzialmente in ogni essere umano, prescinde le condizioni materiali di provenienza. Ciò smentisce ogni sistema di esclusione che si autorappresenta come legittimo referente della natura e della nobiltà. La nobiltà è “nel buon cuore”, nella capacità di ascoltare ed accogliere. Solo tali attitudini sono degne di dare la patente di nobiltà, perché universalizzano, favoriscono il passaggio dal singolare all’universale. Ci si rende piccoli per poter aprirsi all’alterità, l’intero corpo vissuto diviene intenzionalità dell’ascolto:
«La vera nobiltà nasce dal buon cuore, perché la nobiltà ereditaria non è una nobiltà di valore quando le manca la nobiltà del cuore; per questo vi si deve mostrare il valore degli antenati che la conquistarono con le grandi opere che seppero compiere, perché quando essi lasciarono questo mondo portarono via con sè tutte le loro virtù, e lasciarono agli eredi gli averi, senza che quelli potessero da loro ricevere di più. Hanno gli averi, ma senza nulla di più, né nobiltà di valore, a meno che non facciano in modo di essere nobili in grazia della loro intelligenza o delle loro virtù. I chierici sono in maggior vantaggio in fatto di cortesia, nobiltà e saggezza, rispetto ai principi e ai re che sono privi di cultura letteraria, e ora ve ne dico la ragione: perché il chierico vede nelle scritture […] tutte le malvagità da cui ci si deve allontanare e tutte le bontà che si devono praticare. Vede nelle vite degli antichi le villanie di tutti i villani e tutti gli atti degli uomini cortesi e la somma delle cortesie; insomma, egli vede scritto nei libri tutto ciò che si deve evitare o seguire […]. E quelli che non sono di cuore nobile, sappiano che ciò avviene perché hanno il cuore malvagio, […]. Per questo i chierici che non hanno cuore nobile e generoso valgono meno di tutti, perché schivano il bene che conoscono e inseguono i vizi che vedono; e davanti all’imperatore celeste i chierici che s’abbandonano ai vizi dovrebbero essere puniti più severamente dei laici sciocchi e ignoranti, che non vedono nelle scritture le virtù che quelli disdegnano e disprezzano. […] Chiunque aspiri alla nobiltà si guardi dall’orgoglio e dall’ignavia, si dedichi […] allo studio, e si liberi da ogni villania. Abbia cuore umile, cortese e gentile, in ogni luogo e verso ogni persona, tranne soltanto verso i suoi nemici, quando non si può fare pace con loro».[3]
La nobiltà degli intellettuali si misura sulla loro capacità e volontà di vivere i valori che a parole si propugnano. La nobiltà nell’intellettuale si nutre dello spirito dell’antico per trasformarla in carne vissuta. Non vi è nobiltà nel chierico corrotto come nello studioso che lascia i grandi del passato tra le righe del manuale e non li rende attuali.
La nobiltà dell’intellettuale vive nello studio, nella gioia che sospende l’utile per la contemplazione attiva del sapere.
Il Romanzo della Rosa ci narra di un Medioevo sconosciuto che parla a tutta l’umanità, travalica i confini del tempo per ricongiungersi all’eterno radicarsi della verità nella storia.
Salvatore Bravo
[1] Guillaume De Lorris, Jean De Meun, Il Romanzo della Rosa, Feltrinelli, Milano 2016, p. 188.
[2] Ibidem, p. 260.
[3] Ibidem, pp. 336-337.




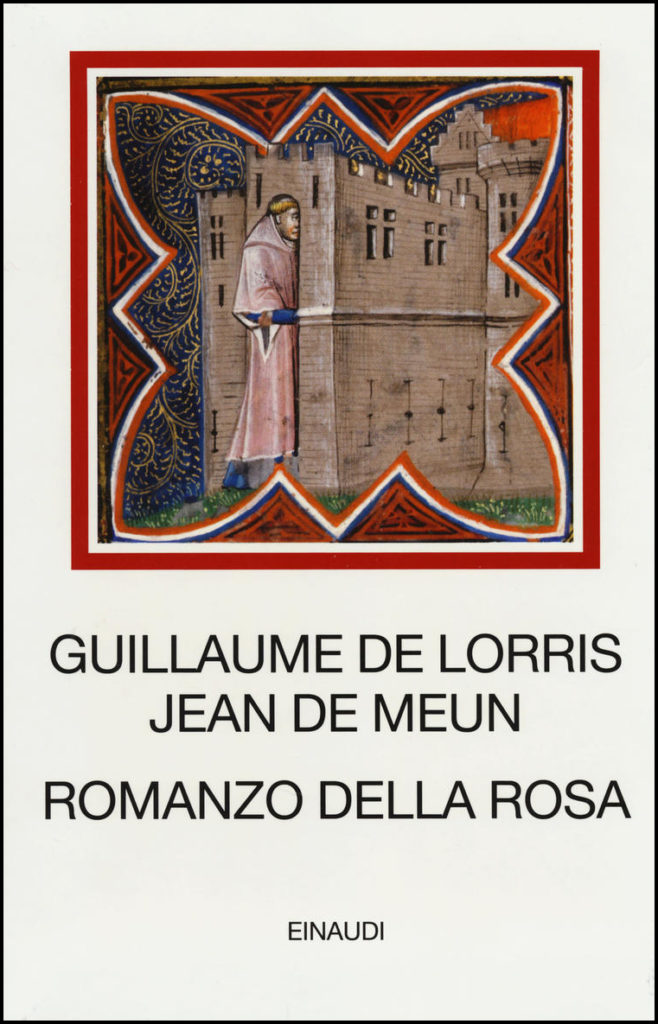
Due testi e molti misteri. Il “Romanzo della Rosa” è costituito da due parti scritte da autori diversi a distanza di una quarantina di anni. Due parti molto diverse e la seconda sembra essere la palinodia della prima. I dubbi sull’identità degli autori, su eventuali interpolazioni di Jean de Meun nella prima parte, sul senso del poema come opera complessiva sono ripercorsi nell’introduzione di Mariantonia Liborio. Quello che sembra sicuro è che il “collage” dei due testi mostra come in quel mezzo secolo di iato fra la prima e la seconda metà del XIII secolo fossero profondamente cambiati i modelli culturali: dagli ideali e dalle forme letterarie cortesi del Roman di Guillaume de Lorris all’approccio filosofico-enciclopedico di Jean de Meun. E un passaggio che si verifica, in forme diverse, anche nella letteratura del sì fra i poeti siciliani e Dante. È dunque importante rileggere il “Romanzo della Rosa” nella sua diversificata completezza. Al di là dei problemi filologici e narratologici, il poema è davvero uno dei fondamenti della cultura europea: una rilettura dell’ars amandi ovidiana che diventa una fenomenologia della conquista amorosa e del desiderio; una perfetta compenetrazione di allegoria e narrazione che anticipa la Commedia dantesca.
