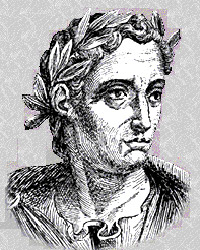Giorgio Penzo – Recensione a «DUEL» di Steven Spielberg, U.S.A., 1971
David, piccolo borghese con moglie, figli e casetta con giardino, possessore di una brillante “compact-car” rosso fiamma, si reca a trovare un superiore.
Mentre si srotolano le miglia dell’autostrada e David (Dennis Weaver) ascolta comunicati commerciali a raffica e si sorbisce musichetta “Country and Western” di bassa lega, supera un colossale camion piuttosto vecchiotto, ma con numerosi cavalli nel motore (come vedremo). Un breve suono di clacson per chiedere strada, un veloce sorpasso, ed incomincia l’incubo: il banale diviene tragedia, il reale irreale; l’incubo si concluderà negli ultimi fotogrammi quando il protagonista, ormai in salvo, inizierà di fronte al sole un rito di ringraziamento che lo ricolloca nuovamente nella vita reale.
- – La Caccia
Nel lungo sogno appare chiaro il motivo della caccia, come osserva giustamente Giuliano Giuricin, in una lettera a Cinema Nuovo: «Al centro dell’opera di Spielberg si trova il motivo della caccia, come la polarità di cacciatore e cacciato che Wright Mills caratterizza la struttura mentale dell’uomo contemporaneo».
Non a caso appare qui il nome di Mills, autore di Colletti bianchi: La classe media Americana che descrive impietosamente vita e miserie dei tanti David da cui è composta la classe media U.S.A.
Ma la caccia non è una caccia libera e spietata, bensì soggiace a certe regole che riportano alla mente il codice della caccia alla volpe o, ancor meglio, la caccia con i falconi: un testo come il De Arte Venandi Cum Avibus di Federico II, con le regole minuziose e con l’indicazione delle prede possibili per un animale nobile come il falcone, è il riferimento più preciso che mi venga alla mente.
Regola prima del binomio camion-camionista (quasi invisibile) è considerare come preda il binomio David-macchina. Fofi: «In Duel è il camion ad imporre la regola: non attacca l’uomo fuori dalla macchina o la macchina priva dell’uomo, ce l’ha con l’insieme uomo-macchina». Dimostrazione abbastanza evidente di questo è il momento in cui il camion distrugge completamente la stazione di servizio quando David cerca di chiamare la polizia: in effetti è la cabina telefonica il suo bersaglio, poiché David non rispetta una regola base cercando di far intervenire in questo duello un altro elemento, la polizia appunto; il tema del rispetto delle regole si ritrova quando David cerca di convincere due vecchietti a chiedere aiuto: la reazione del camion è pronta e decisa, mette fuori combattimento la macchina dei due ed attende pazientemente che David lo preceda, perché la preda deve sempre temere, fuggire dinanzi alla minaccia: solo alla fine, quando la macchina (senza David) impatta contro il camion, la regola è violata, il cacciato si ribella al cacciatore ed impone la sua legge.
E’ bene intendersi subito su due punti: quando dico “camion” alludo al duo camion-conducente invisibile (o quasi); la supposta lealtà dello scontro è mera finzione, poiché l’aspetto quantitativo, la grandezza del camion, chiude apparentemente ogni possibilità di scampo al duo David-macchina: in effetti, come prima ho ricordato, è ribaltando questo criterio quantitativo nello scontro, e sostituendovi un criterio qualitativo, cioè l’astuzia e l’intelligenza, che David “viola” le regole di partenza ed impone le sue: “taglia”, si direbbe in termine bridgistico.
Non mi sembra inoltre che “il gioco” divenga progressivamente “un gioco mortale”, ma anzi che l’incubo sia presente e letale fin dal famoso colpo di clacson che suscita la reazione del camion: il braccio che invita al sorpasso quando sulla corsia opposta passa un bus e il tentativo di schiacciare la macchina al passaggio a livello, sono sicuramente la prova che non è mai un gioco. C’è certamente l’impressione da parte dello spettatore di assistere ad una lotta del gatto col topo, ma è la dimensione innaturale, incubica, in cui si svolge il dramma che lo porta a ciò.
- – Il Gran Feticcio: L’Automobile
Un altro aspetto, forse marginale, ma utile per comprendere il film di Spielberg è il suo attentare ai sacri miti della way of life americana, per esempio l’automobile: la bellissima vettura rosso-fiamma di David passa attraverso numerose traversie e verso la fine del film la vediamo ridotta ad un ammasso di lamiere che ben poco ha dell’aggressivo aspetto di partenza: lo status symbol che essa è viene ridicolizzato, messo alla berlina e infine ridotto alla sua forma primigenia: “chalybs es et in chalybem reverteris”; alla fine, come una qualunque arma di poco prezzo, viene utilizzata per organizzare il trick ai danni del camion e mentre prima, lungo tutto il percorso era stata sbeffeggiata dal colosso inseguitore, proprio ridotta a quello che in partenza non doveva essere, strumento e basta, sasso gettato con violenza, adempie ad una funzione, salvare l’uomo, per la quale non era stata costruita.
Solo quando David “si libera” della sua macchina, è salvo: meglio, solo dopo il disastro finale, in cui sia il camion che la vettura “periscono”, l’uomo può innalzare quella specie di epinicio che esalta al tempo stesso la “liberazione” dal Male (ciò che è estraneo, alieno) e il rinnovato “piacere” di vivere.
Ma l’atteggiamento di Spielberg verso la macchina non è piattamente negativo, bensì dialettico, è un odio-amore: se in Duel sembrerebbe che solo con la distruzione di questo instrumentum regni americano l’uomo possa riprendere contatto con le forze visibili ma misteriose della Natura da cui nasce, nel successivo Sugarland Express la macchina è anche amica, è Libertà, è Fuga dalla costrizione, è mezzo per raggiungere uno scopo “nobile”, se vogliamo (il figlio perduto).
Si potrebbe aggiungere, occupandoci adesso del camion, che senza la visione fugace di un paio di stivaletti di cuoio e di un braccio sinistro mosso meccanicamente, sia il camion stesso che abbia preso vita, intelligenza, astuzia dal suo fantomatico guidatore e gli si sia sostituito: qui il riferimento letterario e cinematografico è più preciso, basterebbe pensare al Golem di Wegener, al Frankestein (quello di Mary Shelley, non quello di molti filmacci) e soprattutto ai Robots del premonitore R.U.R. di Čapek.
Convalida di questa ipotesi è il misterioso liquido che scorre fra i rottami del mostro ormai distrutto: sangue del guidatore o olio della coppa? L’uno e l’altro, forse, indistinguibili, tale è stata la simbiosi fra uomo (invisibile) e mezzo meccanico.
Un altro mito a cui attenta il film di Spielberg è lo stereotipato milieu di tante avventure western entrate nella leggenda, come Stagecoach o My darling Clementine, perché, non dimentichiamolo, è proprio attraverso il deserto, simile a quello della Monument Valley, che si svolge l’avventura di David: solo che invece delle maestose e dinoccolate figure di John Wayne o Henry Fonda caracollanti su mustangs in uno sfondo di rara bellezza, si presenta David con la macchina che i reiterati assalti del camion riducono sempre più simile ad un rottame; il cavallo diviene un ronzino di ferro, così come il superman che veste da cowboy diviene un ometto pazzo di paura (a proposito, quanti avranno riconosciuto nel Dennis Weaver di Duel il timido, nevrotico watchman pieno di tic del Motel Grandi in Infernale Quinlan?) che trova nella rabies esistenziale il mezzo per salvare la pelle.
III. – Analogie Col Mondo Medioevale
Innanzitutto il termine Duel che, per quanto sintetico ed efficace, non rende sufficientemente il senso del film, trattandosi, come si è visto, di uno scontro ineguale, dato che al camion sono dati tutti gli atouts, mentre solo in fondo David riesce a introdurre le sue regole qualitative.
Il duello, a mio avviso, sorge da quel sorpasso che apre l’incubo: visto in questo senso, non si tratta più di una semplice punizione, ma di un guidrigildo che David deve versare per il delitto commesso: non ha importanza se la penale è la vita stessa di David.
La regola del duello, il seguire scrupolosamente le norme del codice cavalleresco, è un impegno del camion,
anche a costo di procrastinare la punizione: infatti attende David e la macchina ai bordi della strada (per analogia una specie di tregua di Dio); aspetta che David risalga sulla macchina quando questi vorrebbe fuggire a piedi (per analogia il duellante che permette al rivale di riprendere la spada caduta); il volere lo scontro a due, senza nessuna interferenza da parte della polizia (scena della cabina telefonica) o di altri (i vecchi coniugi); riprende la caccia solo quando le parti di cacciato e cacciatore, inseguito ed inseguitore sono perfettamente definite, canoniche.
In un certo senso è come l’inseguimento di Achille a Ettore intorno alle mura di Troia, con un protagonista (Achille) già sicuro della vittoria, il deuteragonista (Ettore) presago della sconfitta, ma conscio che vi è una dignità da difendere e nel cui cuore alberga una “speranziella”: in Duel il finale è però capovolto, in primis perché manca una τύχη che abbia già predeterminato l’esito della lotta e poi perché è violando le regole dell’avversario, cioè scindendo il sinolo uomo-macchina e rinunciando al secondo termine per pensare a se stesso come animal, come soggetto all’istinto di conservazione che David riesce a cavarsela, evitando la resa dei conti, come un guerriero che si tolga l’armatura dinanzi ad un altro armato pesantemente e riesca a tendergli una trappola mortale (Orazii e Curiazii, o, per rimanere nel mondo medioevale, la scena dell’affondamento nei laghi Masuri dei Cavalieri Teutonici opposti ai contadini di Alexander Nevsky, entrambi esempi di insopportabile rottura delle regole belliche cavalleresche).
Se per esempio riprendiamo le pagine del tournoi che nell’Ivanhoe oppone il Cavaliere Nero alias Cavaliere Del Catenaccio alias Riccardo Cuor di Leone ai più prestigiosi rappresentanti dell’Ordine dei Templari, come Brian de Bois-Guilbert, vediamo che il rituale (quello eternato da Walter Scott…) viene rispettato; ma all’apparire di Locksley alias Robin Hood e dei suoi allegri compagni di Sherwood, è valendosi di regole “diverse” da quelle della cavalleria che questi riescono a mettere sotto i titolati Normanni (attacco al castello di Front-de Boeuf). Walter Scott redime peraltro gli allegri predoni facendone seduta stante dei supporters del re in incognito e reinserendoli nella legalità perbenista.
Un aspetto più figurativo che discorsivo è la possibilità di istituire un parallelo fra il camion e un drago, proprio uno di quei draghi che sembrano uscire dalle menti fervide di un Merlino o di un Cavaliere della Tavola Rotonda: questa notazione mi sembra valida appena ci si ricordi del lento procedere del camion lungo la galleria che lo riporta a David: i due fari, non so se per un fenomeno ottico o per un eccezionale esito fotografico, sembrano veramente occhi di un drago, fiammeggianti come le litografie del tempo andato amavano rappresentarcelo; occhi di un essere pronto a ghermire la vittima, ma lento e maestoso perché sicuro dell’esito dello scontro.
Nel Drago di Evghenij Schwarz il mostro è tanto sicuro della propria vittoria nel futuro duello col giovane eroe, che, per quanto dapprima tentato di usare qualche astuto accorgimento per sbarazzarsi del rivale, alla fine accetta, per dignità ed orgoglio, di combattere secondo le regole, e viene clamorosamente sconfitto ed ucciso (questo è un inciso, perché il dramma di Schwarz ha ben altre implicazioni).
- – Una Lotta Gatto-Topo Ribaltata
Il motivo dello scontro ineguale è pur esso fertile di riferimenti.
La natura ci dà esempi sconvolgenti di scontri apparentemente ineguali nei quali il piccolo prevale sul grosso valendosi di quel quid che è dato da una summa di astuzia, agilità, destrezza e riflessi pronti: pensiamo, ad esempio, allo scontro vespa-migale, che è per lo più risolto quando la vespa riesce a paralizzare i centri nervosi del rivale o, ancora meglio, alla classica lotta mangusta-cobra: in un ideale bookmaker, ben pochi punterebbero sulla mangusta, eppure, e non solo nei libri di Rudyard Kipling, quest’ultima spesso prevale.
Pensiamo all’incontro-scontro Ulisse-Polifemo: anche qui il banale diviene tragedia, ma, pur se con mezzi diversi, Ulisse, emblema della scaltrezza umana, gioca la montagna di carne che gli sta di fronte: ma l’esito dello scontro è talmente schiacciante in suo favore, che non si attaglia al film, in cui l’eroe (se di eroe si può parlare) se la cava per il rotto della cuffia.
Molto più preciso e puntuale è il confronto: David-vettura contro camion – David contro Golia, anche se valido soltanto nello scontro finale: in effetti David (che l’omonimia sia solo un caso?) utilizza la macchina come una pietra lanciata da una fionda contro il Golia del momento e, altrettanto inevitabilmente, lo abbatte: qui si ferma il paragone, perché il David Biblico è già un “Unto da Jahweh”, la sua impresa è baciata dalla “grazia soprannaturale”, mentre l’altro David deve fare tutto da solo.
- – Il Camion Come Simbolo – Melville
Un sogno quindi, o «tutto quello che lo spettatore vuole, a seconda delle paure notturne, basate sulle sue inadempienze e sulle sue frustrazioni» (Fofi): quindi, aldilà del primo piano di lettura, che è relentless thriller di solido intreccio, si colloca un gusto verso la tradizione letteraria che ha avuto in America grandi rappresentanti: l’allegoria e il simbolismo.
Cerchiamo di esemplificare i due termini e stabilire, con l’aiuto di Richard Chase, in quale direzione si immetta Spielberg: la famosa lettera scarlatta, protagonista, in un certo senso, dell’omonimo romanzo di Hawthorne, è un simbolo comune o segno, indica l’adulterio appunto, ma (secondo piano di lettura) è «anche il marchio impresso sopra ogni vita umana» (Chase).
La balena bianca, il Moby Dick di Melville è un simbolo poetico: il significato della balena non è univoco, può essere eventualmente unilaterale (per Achab Moby Dick è il Male, ma non necessariamente per Ismaele o per il lettore: Achab allegorizza la balena; concentra in una la molteplicità delle interpretazioni).
Lasciando da parte le differenze fissate da Coleridge per distinguere allegoria e simbolismo, cioè vederle come rampollanti rispettivamente dalla fantasia o dalla immaginazione, dando la palma della “facoltà poetica” all’immaginazione (come ogni buon romantico), Chase osserva che: «l’allegoria raggiunge il suo massimo splendore quando tutti sono d’accordo nel definire la verità, quando la letteratura è esposizione, mentre una letteratura simbolista nasce dal dissenso nel definire la verità».
Tenendo ben presente la lezione di Melville, del Melville maggiore di Moby Dick e Bartleby, Spielberg utilizza il Leviatano adattandolo ai suoi tempi e facendone un mostro da autostrada. Anche la analogia fra i protagonisti del dramma è puntuale, anche se il rapporto cacciatore-cacciato è inverso: nel romanzo Moby Dick è un simbolo, ma è pure ben presente, come attestano i poderosi colpi alle barche ed infine alla nave e, soprattutto, la gamba di legno di Achab – nel film il camion, fin dal suo apparire sullo schermo suscita un reverenziale timore ed una impressione di forza (le targhe dei vari stati collocate sul davanti sono riprese come se fossero trofei di guerra di un combattente invincibile); sia nel film che nel romanzo entrambi questi combattenti vigorosi sono “fuori della norma”, sono resti di un’epoca ormai passata che fronteggiano il “nuovo”: basti ricordare lo scontro fra l’imponente camion stile anni ’40 e la vettura di David e paragonarlo con la baleniera solida e funzionale degli anni 1840-1850 (funzionalità che ci viene descritta da Melville in pagine memorabili per perizia tecnica e commosso rispetto del lavoro umano) alla caccia di un qualcosa di selvaggiamente anomalo, come il capodoglio bianco che non sottostà alla logica mercantilistica dei Nantucketesi, primi ambasciatori del capitalismo U.S.A. sui mari (50 anni prima della guerra con la Spagna).
La necessità quasi biologica che un uomo sopravviva al dramma, qui David, là Ismaele, viene ad affermare vigorosamente che, nonostante tutto, la vita umana rimane al centro della Natura, anche dopo i più furibondi drammi esistenziali: a Ismaele, raccolto nella bara del suo amico Queequeg (supremo oltraggio alla morte in agguato) e a David (restituito alla vita quando la ruota del camion ha compiuto il suo ultimo giro) si apre una nuova pagina, la pagina dove si scrive la fine delle facili illusioni e l’invito alla vigilanza verso i mostri che l’uomo crea con le sue stesse mani: Moby Dick diventa nemico solo perché con la caccia si attenta al suo esistere fisico, alla sua animalità, mentre il camion reagisce solo perché provocato da un sorpasso.
Si potrebbe obbiettare che quello che in Moby Dick nasce da una feroce lotta per la sopravvivenza, viene provocato nel film da una ripicca, ma, a mio avviso, anche qui Spielberg coglie il segno, facendo vedere che nell’universo scentrato e disumanizzato dell’Occidente e del suo rampollo più forzuto, gli U.S.A., il banale può provocare il dramma: caduti gli elementi cosiddetti “sani” della giovane America, rimane il futile a determinare gli incontri-scontri.
Si può ora rispondere ad una domanda fondamentale per la comprensione del film: il camion è simbolo o allegoria, semplice segno o summa di molti significati che ne formano un simbolo poetico?
A mio avviso il camion è un simbolo, come appunto la balena bianca.
Riprendiamo un passo del Pierre di Melville: «Per quanto ne dicano certi poeti, la Natura non è tanto l’interprete eternamente soave di se stessa, quanto la semplice fornitrice di quell’astuto alfabeto per mezzo del quale, selezionando e combinando come crede, ciascun uomo legge la propria peculiare lezione secondo il proprio cervello e stato d’animo».
Ora, il camion non è parto della Natura, anzi lo si direbbe soltanto un prodotto artificiale che serve; tuttavia, il fatto che Spielberg ignora la presenza del conducente induce lo spettatore a credere il camion come un qualcosa che sia divenuto da inorganico organico e da organico essere pensante.
In questa riuscita nel rendere naturale il camion, nel dargli una dimensione ed istinti naturali (quale istinto è più naturale della caccia?) sta una parte del successo di Spielberg.
Quindi il camion, integrato in una realtà come quella “Naturale”, che si può leggere ma non definire in assoluto (per dirla con Melville), è per ognuno ciò che ognuno lo crede. «Ambiguo come la natura, splendido ed orribile, benigno e malvagio» (Nemi D’Agostino). Riguardo all’ultimo punto non dimentichiamo infatti il momento in cui il camion trae d’impaccio uno scuolabus, quasi a far sembrare parole di un pazzo le affermazioni di David sulla persecuzione di cui è vittima e le sue invocazioni d’aiuto.
«Il camion può essere tutto: la violenza del sistema americano, certamente, ma soprattutto, nella costruzione incubo del film, un concentrato di ciò che popola gli incubi dell’uomo medio: dunque anche, magari, la rivoluzione e il proletariato, oppure l’irrazionale e la morte» (Fofi).
- – Dovuto A Kafka
Mi sembra che sia necessario fare i conti con un altro autore, la cui influenza è determinante per il film, e cioè Kafka.
Diario di Franz Kafka, 20 Dicembre 1910: «Con che cosa posso giustificare il fatto che oggi non ho scritto ancora nulla? Con nulla. Tanto più che la mia disposizione di spirito oggi non è delle peggiori. Ho sempre nell’orecchio una invocazione: “Potessi tu venire, Tribunale invisibile!”».
Ecco in nuce uno dei poli di sviluppo de Il Processo. Anche David ha commesso la sua infrazione (il sorpasso), che rimanda evidentemente a ben altre colpe, al limite alla colpa di vivere: egli deve essere punito; addetto alla esecuzione il camion.
David tuttavia non sa o finge di non sapere il perché dell’inseguimento, cerca una risposta nel razionale (ricordiamo il breve processo mentale che sviluppa durante la colazione allo snack-bar) e non la trova.
E’ lo stesso tentativo di Josef K. ne Il Processo, trovare il motivo del suo arresto: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché, senza che avesse fatto nulla di male, una bella mattina lo arrestarono». Da qui il protestare continuamente la propria innocenza.
Ma nello stesso capitolo de Il Processo, uno dei guardiani spiega molto chiaramente che: «l’autorità non cerca la colpa» ma «com’è detto nella legge, è attratta dalla colpa»; e alla risposta di K. «Questa legge non la conosco», l’altro guardiano pronunzia le parole che spiegano la problematica più profonda del romanzo: «Vedi, Willem, ammette di non conoscere la legge e nello stesso tempo afferma di essere innocente».
Aggiunge Mittner: «Mentre ancora nella Colonia Penale (1914) il mondo della giustizia si svela subito nella sua struttura concreta, visibilissima: detenuti, ufficiali, impiegati, celle di punizione e una valle in cui da tempi immemorabili si eseguono le sentenze capitali con una macchina che lentamente incide nel corpo del reo i segni misteriosi della Legge disprezzata, nel frammento del 1910 vi è già embrionalmente quella che sarà la grande innovazione del Processo: l’imputato non può mai vedere i suoi giudici, non è mai ammesso al loro cospetto», non conosce la sua colpa.
In America Carlo Rossmann ha appena ritrovato lo zio, “sostituto freudiano del padre”, ed incomincia a conoscerlo, quando un invito per una serata lo porta lontano da casa: la violazione di un appuntamento che Carlo non può conoscere (e quindi rispettare) lo fa ridiventare orfano. In un certo senso, la colpa e la condanna di Carlo sono già predeterminate, le sue obiezioni sono chiacchere, come dice Mr. Green.
Ne Il Processo, quando Josef K. si incontra, nella sala affollata, col giudice istruttore, cerca, seguendo un filo logico, di spiegare l’arbitrio del suo arresto e la nullità della decisione a suo riguardo: ma sia le reazioni della folla sia quelle dei singoli sono totalmente anomale rispetto alle sue parole; il giudice istruttore dicendo: «Volevo farle presente che Lei – senza averne coscienza – rinuncia al privilegio che costituisce per un arrestato l’interrogatorio», afferma una volta di più che il processo è una macchina che funziona irreversibilmente e le obiezioni di K. sono inconsistenti.
Vi sono molti punti di contatto, nel film, con le affermazioni che Orson Welles ha fatto relativamente al “suo” Josef K. in una intervista: «Josef K. è anche un piccolo burocrate. Io lo considero colpevole». Alla domanda perché è colpevole Welles ha risposto: «Egli appartiene a qualcosa che rappresenta il male e che, al tempo stesso, fa parte di lui. Non è colpevole di quanto gli viene rimproverato, ma è colpevole lo stesso; appartiene ad una società colpevole, collabora con questa. K. collabora per tutto il tempo. Io gli permetto soltanto di sconfiggere i suoi carnefici».
Più avanti Welles ha affermato: «Non sono assolutamente d’accordo con queste opere d’arte, questi romanzi, questi films che oggigiorno parlano di disperazione. Non penso che un artista possa prendere come soggetto la disperazione totale: le siamo troppo vicini nella vita quotidiana. Questo genere di soggetto può essere utilizzato quando la vita è meno pericolosa e decisamente positiva».
Se prendiamo alla lettera le “affermazioni” di Welles, e le confrontiamo con i “fatti” di Duel, anche Spielberg dà prima una dimensione incubica al film, ma poi “rassicura” lo spettatore (che ha avuto tutto il tempo di immedesimarsi con David). In questo senso è esatta la affermazione di Giuliano Giuricin che dice: «Il finale di Duel non sembra coerente col resto del film, rassicura invece di allarmare lo spettatore, non ne sovverte insomma le categorie mentali e gli schemi ideologici», operazione questa che esegue invece, ad esempio, Kafka ne Il Processo: la frase finale «”Come un cane!” mormorò, e gli parve che la sua vergogna gli sarebbe sopravvissuta», si sintonizza perfettamente con una vicenda, quella di Josef K., che non si chiude, ma viene soltanto sospesa, per riprendere con altre forme espressive e con personaggi più asciutti, ne Il Castello.
Welles non accetta questo finale: i due esecutori non riescono a servirsi del coltello e devono utilizzare un mezzo molto più impersonale come la dinamite; Josef K. riesce, in un gesto di ribellione (il primo, forse) a rilanciare la dinamite: è un finale aperto, nel senso che K. può salvarsi, e comunque non si lascia agire.
Anche il David di Duel è passivo durante tutto l’arco del film ed attivo solo nel finale: ma la sua ribellione è più fruttuosa, riesce addirittura a distruggere il nemico.
VII. – Conclusioni
E’ chiaro che né lo Josef K. di Welles né tantomeno il David di Duel rispettano la coerenza del discorso iniziato ed infatti il finale risulta “strano” rispetto al resto del film, ma mi sembra che non si tratti necessariamente di un ricorso al tradizionale happy-end del cinema americano: la vita di David è salva, ma è chiaro che le sue “categorie mentali” sono sconvolte e di tutto il suo bagaglio di fiducia nel “sistema” americano è rimasto il sine qua non, la pelle.
Il film di Spielberg si chiude con David inginocchiato sulla terra e accecato dal sole, mentre, come già osservavo, effettua una specie di rito di ringraziamento: in questo ricongiungimento con la Natura può vedersi un apologo sulla necessità della difesa dell’Umanità dai mostri che essa stessa costruisce e che, resisi indipendenti, si ribellano.
Quali sono i limiti dell’operazione di Spielberg? Pur tenendo conto che il film rappresenta un fatto nuovo nel panorama del cinema americano, perché usa un modello letterario (il simbolismo) derivato dalle avanguardie europee, ma risalente ad un maestro tipicamente americano come Melville, riconosciuto che è possibile dare al film un significato di difesa dell’Uomo contro le macchine che lo estraniano da se stesso, è doveroso riconoscere che Spielberg non ha (o non ha ancora) la consapevolezza che «i suoi problemi, il suo senso di disagio, di essere in trappola, sono legati a mutamenti storici di struttura, a fasi di conflitto nell’interno delle istituzioni sociali» (Mills).
In sostanza Spielberg non riconosce che la realtà del mondo, e quindi la via per fuggire agli incubi che assillano David e Spielberg stesso, nasce dallo scontro diretto fra chi accetta la realtà così com’è e la ratifica, e chi invece vuole cambiarla; il che non significa limitarsi a cambiare la struttura economica, ma attuare un rivolgimento che porti appunto a quel “uomo nuovo” che è al centro della visuale di Marx e che un certo tipo di economicismo (come osserva Paul Sweezy sulla Monthly Review) ha spesso posto in secondo piano.
“Dal regno della necessità” (attraverso la ribellione) “al regno della libertà”. Spielberg riconosce la necessità della ribellione e la necessità un “uomo nuovo”, ma non lo identifica con quello derivante dall’analisi e dalla lotta marxista: la sua posizione è quella di chi ricerca isolatamente una terza via in uno scontro che pone direttamente di fronte due concezioni di pensiero e di vita. Ed è una lotta, questa, in cui tertium non datur.
Giorgio Penzo
Articolo già pubblicato come lettera nella parte riguardante il rapporto tra Duel e Moby Dick nella rivista di cinema «CINEMA NUOVO».
Giorgio Penzo – nato a Trieste nel 1948, diplomato presso il Liceo Classico “F. Petrarca” di Trieste e laureato presso la facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università di Trieste (summa cum laude), si dedica con passione allo studio della storia del cinema.