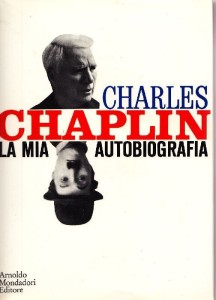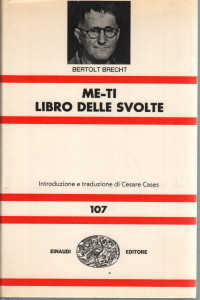Charles Spencer Chaplin (1889-1977) – «La mia autobiografia», Mondadori
« Con un fischietto? Con una filosofia? Chaplin ha fatto quel che ha fatto lavorando con un fischietto; ma dentro il fischietto c’era anche una filosofia. Di ceppo ebraico, cittadino di Kennington Road, Londra, Chaplin nasce nel 1889 da un “magnifico” attore-amatore, sempre ubriaco e in bolletta, e da una geniale soubrettina per un mucchio di ragioni (non ultima la denutrizione) predisposta alla debolezza di nervi e alla follia. La prima volta che Charlie mette piede sul palcoscenico ha cinque anni. Canta e mima (Tutti quanti conoscono Jack Jones…). Così incomincia, tra un crampo (da fame) e una capriola, la storia di un ragazzo, poi uomo, poi grand’uomo, che tiene sempre sulla corda un ometto da tre soldi, piccolo-borghese fallito, a suo modo inappuntabile, che però ha scelto di vivere aiutando a vivere monelli, fioraie cieche, vagabondi, sfruttati, perdigiorno, aspiranti-suicidi, ecc. E’ Charlot: Don Chisciotte in sedicesimo, senza nessun Sancio Panza che lo tiri per le maniche e che, invece di trovarsi addosso la Spagna dei mulini a vento, si trova addosso l’America dei grattacieli, dei piedipiatti, dei magnati del petrolio e dello stagno. I suoi gusti? Non gli piace, per esempio, Shakespeare (eppure gli ha insegnato un mucchio di cose): gli preferisce forse Schopenhauer; tuttavia con uno sgambetto si ritrova a credere nella felicità, nella vitalità, nella gioia di vivere. Può mettersi a piangere davanti a u fiore e scrollare le spalle davanti a una catastrofe. Ama le donne, ma è felicissimo quando riesce a far scivolare un gelato nella scollatura di una matrona. Può tener prediche per ore (ed è un predicatore di razza), ma poi fa finire tutto in una risata. Eccetera. E’ Charlot? E’ Chaplin? Distinguere quel che c’è di Charlot in Chaplin e di Chaplin in Charlot è assurdo. L’America e il mondo, li conquistano tutti e due. Il comico cinematografico (ma con dentro lame e lame di tragico) lo inventano tutti e due. La sfida, ai benpensanti da un lato e al potere dall’altro, la lanciano tutti e due. Quando si tratta di presentarsi davanti alla commissione per le attività antiamericane in tempi di feroce maccartismo, sono ancora insieme (anche se l’America ufficiale non lo intuisce). Poi lascia gli Stati Uniti e si ritira in Svizzera. Da allora – salvo le notizie di Un re a New York – non ne sappiamo più nulla. È anche questo nulla che la sua Autobiografia viene a popolare di cose, fatti, notizie. Chaplin non è più “Sua Maestà il Bambino” (la definizione è di S.M.Ejzenstein); è venuto per lui il momento della riflessione e della confessione. L’ Autobiografia è, in fondo, l’opera che ci si aspettava da lui dopo Luci della ribalta. Tutt’altro che una filippica, tutt’altro che un quaderno di doléances, c’è dentro quel che aspettavamo di sapere da almeno vent’anni. Le sue idee anzitutto e il senso di tutto il suo lavoro, i suoi scontri e incontri, le sue donne (mogli e no, compresi i cosiddetti scandali), i suoi nemici, i suoi amici, le sue avventure in un’America divorata dalla propria crescita, i suoi affetti. E infine una ricchissima galleria di personaggi: uomini politici, comici del tempo eroico del cinema americano, registi, eccetera: dall’ormai leggendario Mack Sennett a Gandhi, da Einstein a Roosvelt, da Krusciov a Stravinskij… E sempre con quell’aria di lotta contro i guasti della morte nella vita che è la punta di diamante di tutto ciò che chiamiamo chapliniano».
(dalla nota editoriale presente ai risvolti di questa edizione)
Charles Spencer Chaplin, La mia autobiografia, traduzione di Vincenzo Mantovani, Mondadori, 1964.