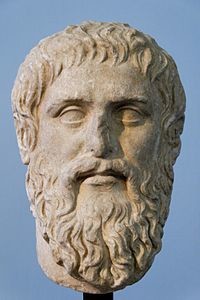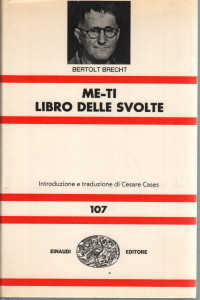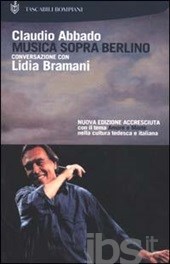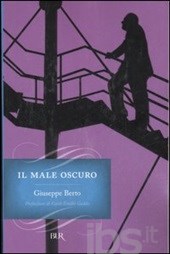Salvatore Satta
Carissimo Carmine,
raccolgo il tuo invito a dare un piccolo contributo al blog Petite Plaisance. Ci siamo conosciuti in occasione del mio lavoro, più volte abbiamo parlato di giustizia e di diritto ed è per questo, ma non solo per questo, che rivolgo ai lettori, un invito alla lettura certamente ardito, per il tecnicismo di alcuni contenuti, ma di grande spessore umano. Si tratta, peraltro, di una lettura quasi impossibile anche dal punto di vista del reperimento del volume ed è per questo che trascriverò alcuni passaggi che ho particolarmente apprezzato, procurando, se non altro, beneficio a coloro i quali avrebbero, comunque, saltato i passaggi più strettamente giuridici. Il libro è una raccolta di scritti di Salvatore Satta, edita da Ilisso nel 2004, intitolato Soliloqui e colloqui di un giurista. E giurista è stato, Satta, tra i più grandi del secolo scorso, allievo di grandi maestri e a sua volta maestro di molti studiosi. Come giurista, si è occupato, prevalentemente, di diritto processuale civile, ma come un altro grande suo contemporaneo, Piero Calamandrei, egli è stato anche un “letterato”, capace di una accuratezza di linguaggio che, più che esser figlia di un certo modo di studiare o di abitudini di lettura ormai quasi scomparse, sembra, più radicalmente, figlia di un modo di vivere e di un mondo che, rassegnamoci, non c’è più.

Salvatore Satta
Di Satta ho sentito parlare, per la prima volta, nel 2001, dal Prof. Ferdinando Mazzarella, allora titolare della cattedra di diritto processuale civile presso l’Università degli studi di Palermo. Mazzarella, quell’anno, avviò il ciclo di lezioni con un suggerimento letterario ed esso riguardava il piccolo volumetto di Satta, edito da Adelphi, Il mistero del processo. «Potete studiare la materia su qualsiasi libro – ci disse – perché questa materia si studia sul codice, ma questo libro, se potete, leggetelo». Lo comprai e confesso che, sulle prime, non fu una lettura facile. Dopo alcuni anni, dopo la laurea, quando il processo mi era diventato più familiare, per quotidiana frequentazione delle aule di giustizia, sentii il desiderio di ritornare a quel suggerimento. A quel punto, la lettura mi rivelò, non solo e non tanto un contenuto che, la prima volta, non avevo colto, ma la grandezza stessa dell’autore; decisi, così, di procurarmi altre opere. Comprai La veranda (Ilisso 2002), De Profundis (Ilisso 2003, riedizione di una precedente uscita CEDAM del 1948) e con l’aiuto di un amico libraio, riuscii a procurarmi anche Soliloqui e colloqui di un giurista. La veranda è un romanzo di grande intensità, tratto da una esperienza personale dell’autore di soggiorno in un sanatorio. Descrivendolo farei un torto all’opera, ma voglio accennare ad una particolarità di questo libro, perché esso risale al 1927, epoca in cui il giovane Satta non era ancora il grande studioso che poi sarebbe divenuto e coltivava, forse, ambizioni di scrittore come, probabilmente, molti di noi a quell’età. De profundis è un libro scomodo, tutt’altro che allineato, che tratta dell’ultimo quarto di secolo della nostra storia patria, rivelando la grande capacità dell’autore di guardare la realtà nel suo concreto estrinsecarsi, fuggendo al fascino ed alla convenienza che certi inquadramenti formali, certe entificazioni, esercitano.

Da frequentatore del diritto, però, la lettura più formativa è stata proprio quella dei diversi “pezzi” da cui è composto Soliloqui e colloqui di un giurista. La selezione di articoli comparsi su riviste specializzate, di prolusioni, discorsi commemorativi ed altro ancora, è stata fatta dallo stesso Satta che, in questo modo, mette il lettore nelle condizioni di cogliere, leggendo tra le righe di specifici soliloqui o colloqui, il senso stesso della sua natura «intranquilla» di studioso e prima ancora di uomo.
Trattandosi di una raccolta di scritti eterogenei, è necessario che il mio invito alla lettura manifesti subito la ratio della selezione che ho operato, scegliendo quelli in cui minore è il peso del linguaggio tecnico giuridico, anche se i Tuoi più attenti lettori non potranno non apprezzare, in Satta, una spiccata capacità a parlare delle cose della vita affrontando argomenti tecnici dimostrando, così, vere doti di docente, oltre che di studioso.
Il libro si compone di sei parti (Soliloqui, Il libro delle prefazioni, Confessioni e battaglie, Saggi critici, Colloqui, Res gestae) e di una Appendice sullo Spirito religioso dei Sardi. Il passo che segue, è tratto dai Soliloqui e tratta del «formalismo nel processo».
Spesso, il linguaggio, lo stile di scrittura e l’esistenza stessa (nella vita quotidiana extra lavorativa) di chi pratica il diritto nei tribunali è permeato, in modo più o meno voluto e ricercato, da un certo formalismo che inevitabilmente allontana “gli altri”. Il cittadino che “incappa” in questioni giuridiche che abbisognano di esser discusse nelle aule dei tribunali, incontra una realtà spesso incomprensibile fatta di particolari di assoluto rilievo ed evidenze irrilevanti. L’occasione, per Satta, è il quarto Convegno dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile, tenutosi il 4 ottobre del 1958
«Il formalismo comincia dove il diritto finisce. Esso rappresenta veramente una frattura dell’esperienza giuridica: al posto dell’esperienza e del suo libero movimento si pone una falsa esperienza, cioè l’immobile vuoto, che si tratta come cosa salda, modellandolo in forme che essendo forme del vuoto, hanno il pregio di essere infinite» (p. 72).
L’attaccamento al concreto che, da giurista, Satta manifesta in queste parole rappresenta un motivo conduttore, forse, della sua intera opera. Basta leggere il suo De profundis per cogliere la sua propensione al racconto ed alla analisi di una verità fatta di cose reali, anche a costo di omettere passaggi che, per molti, sono invece di essenziale importanza. Il formalismo di cui Satta parla «è unico e unitario, come l’esperienza della quale è in certo modo la scimmia», ma l’attenzione dell’autore è posta a ciò di cui il giurista “vive”.
«Nel suo profondo lavoro di astrazione il giurista elabora dei concetti, vale a dire, comprende, secondo l’etimologia della parola, la realtà, ne scopre e ne fissa l’essere, cioè la forma essenziale, l’ordine per cui essa è giuridica. Nulla è più legittimo di questa elaborazione, che costituisce il proprium della scienza giuridica, e la rende eccellente su tutte le altre, perché i concetti che essa elabora hanno un effettivo valore, sono la stessa realtà. Il grave pericolo di questa elaborazione, comune a tutto il pensiero speculativo, ma particolarmente sensibile per il giurista, è che a un certo punto le posizioni si capovolgano, come in quel singolare esperimento della topologia per cui dalla superficie dritta si passa invisibilmente alla superficie rovesciata, cioè si aboliscono le due superfici: e così i concetti acquistino una tale assolutezza da diventare generatori della realtà, in luogo di essere generati, un arcano immobile mondo al quale il concreto mutevole mondo dell’esperienza deve adeguarsi. È una sorta di teologismo o di donchisciottismo giuridico, una posizione diametralmente opposta a quella dell’empirismo, e di questa non meno pericolosa per la conoscenza. Nessuno dubita, ad es., della verità del concetto di ordinamento giuridico, e della sua adeguatezza a rappresentare la realtà stessa, in quanto appunto si presenta ordinata. Ma questo stesso concetto acquista a un certo punto tanta forza di suggestione che si stacca dalla realtà ordinata, della quale si presenta come ordinatrice, un Ordinamento con la o maiuscola, una personificazione o deificazione, del quale si dice che si attua, che si concreta, che si viola, che ha i suoi ministri, e al quale gli uomini sono soggetti ed estranei» (p. 76).
In questo passaggio, che prosegue con un altro esempio (che ometto per brevità), Satta sembra esprimere quello scollamento dalla realtà che, il più delle volte, rende il diritto qualcosa di estraneo ai membri della societas, di cui pure è espressione tra le più alte.
«Non vi è bisogno – prosegue l’Autore – di illustrare i guai che questa deformazione produce: e sarebbero guai sopportabili se restassero sul piano della conoscenza teorica. Alla fin fine, il mondo uno se lo concepisce come vuole. Ma purtroppo nel diritto la conoscenza è esperienza; e non esiste dualismo tra teoria e pratica».
Le conclusioni cui Satta giunge in questa sua riflessione, sono in linea con il suo sentire, tenacemente attaccato alla concretezza delle cose, in una prospettiva profondamente “umanistica”:
«[…] non esiste una ricetta, non esiste una formula che, operando dall’esterno, elimini il formalismo. Non leggi, non ordinamenti, non costituzioni, non soprattutto riforme imposte dall’alto, nulla vale a distruggere questo singolare atteggiamento dello spirito umano: anzi, come ho detto, la storia ci insegna che ogni tentativo fatalmente conduce ad esasperarlo. Per raggiungere qualche risultato bisogna operare dall’interno, cioè da noi stessi, compiere quel profondo atto di umiltà di fronte alla vita che è stato espresso per i medici, ma che vale per tutti: cura te ipsum. Riconoscere che la scienza nasce dalla vita e non la vita dalla scienza; ammettere che tutte le nostre costruzioni, i nostri sistemi sono relativi; o se si vuole, che il concreto, cioè la vita nel suo continuo mutamento, richiede un’adesione spirituale che trascende i limiti della scienza» (p. 82).
Il costante richiamo al “concreto”, secondo me, è uno dei più grandi insegnamenti che Satta lascia agli studiosi del diritto e credo che il nostro Paese – attraversato da continui, ma sempre deboli e poco ispirati, venti di riforme, promosse da una classe politica incapace di correggersi, per la quale la “riforma” è pura velleità – il nostro Paese, dicevo, sarebbe un posto più semplice in cui vivere, se i costruttori di leggi realizzassero quale è il compito del giurista:
«Ogni giorno di più acquistavo coscienza di quello che era il mio compito, e il compito di ogni giurista: non costruire, ma vedere, ma leggere con semplicità nei fenomeni, e descriverli nella loro genesi e nella loro funzione. La costruzione non è opera del giurista, sia esso legislatore o interprete, che non è e non deve essere creatore. Sotto questo angolo visuale, tutto acquistava concretezza e chiarezza, perché concreta e chiara è la realtà dei rapporti sociali» (p. 137).
Il passo è tratto dalla prefazione al volume Esecuzione forzata del 1937. Sono parole che, se poste idealmente al cospetto delle ardite costruzioni, proceduralizzazioni, astrazioni di cui il nostro ordinamento è saturo (e che lo rendono altamente inefficace sia sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra privati, che sotto quello delle norme che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione), fanno emergere la violenta “presunzione” di molti operatori del diritto.
Voglio avviarmi a concludere questo mio piccolo scritto, su un autore che meriterebbe migliore e maggiore attenzione di quella che le mie risorse e la pazienza di chi vorrà leggere permettono, virando il discorso su un profilo più strettamente “umano” che traspare nell’opera di Satta continuamente, ma che egli, di tanto in tanto, permette a se stesso, indugiando in ricordi, malinconie e – perché no – qualche sana arrabbiatura. A tal proposito, la prefazione del volume sull’Esecuzione forzata, del 1937, chiude con una dedica al fratello Filippo, preferito, per questo scopo, al padre morto da anni, proprio perché vivo ed in grado di apprezzare la dedica di un libro giuridico che, come egli stesso afferma non può e non deve appartenere alla vita interiore di chi lo scrive (p. 138). Alla voce malinconie, colloco il riferimento, carico di suggestioni, a Francesco Carnelutti, grande antagonista scientifico di Satta, da questi definito «grande uomo». La presentazione della settima edizione del Manuale di diritto processuale del 1967 così recita:
 Francesco Carnelutti
Francesco Carnelutti
 Piero Calamandrei
Piero Calamandrei
 Giuseppe Capograssi
Giuseppe Capograssi
«Nel 1948 mi lanciavo con questo libro verso gli anni a venire; oggi mi par di procedere come gli indovini di Dante, col capo voltato sul dorso. Gli ultimi grandi esponenti della scienza postchiovendiana, Calamandrei, Redenti, Carnelutti, se ne sono andati, se ne è andato Capograssi, se ne è andato Ascarelli, precursori di una scienza nuova. (Io sono rimasto. Ma non ne sono tanto sicuro. Forse sono ibernato.) C’era, in quegli anni, un’atmosfera da grandi colloqui, e nei colloqui si rifletteva una terra sconvolta dalle più dure esperienze, la paura di queste esperienze, il coraggio di volerle comprendere, anche a costo di ricominciare da capo. Dove sono le male parole che Carnelutti scagliava contro ogni mio libro, a cominciare da questo: dove le mie irriverenti risposte? Non ho mai capito il principio del contraddittorio come da quando il grande uomo non c’è più» (p. 151).
Quando leggo queste parole, il confronto con il livello attuale dello scontro tra portatori di pensieri differenti è impietoso. L’atmosfera di «grandi colloqui» a cui Satta fa riferimento è certamente, almeno nell’immediato, circoscritta all’ambito del diritto, così come erano certamente circoscritte ad esso le «male parole» che egli riceveva, ricambiando con «irriverenti risposte», da Carnelutti, ma quanta differenza, quanta distanza tra quei colloqui e quelli a cui oggi siamo abituati!
Sul finale della stessa presentazione, Satta rivolge al lettore altre parole di grande suggestione:
«Bisogna che il pensiero rinasca, e imponga la sua legge. E questo non può avvenire in un giorno o in un anno, o forse in cento anni, né può essere opera collettiva, poiché i tempi della follia collettiva sono passati, e la speranza è ormai riposta nella follia individuale. Bisogna che ognuno, nel suo piccolo, riconosca per sé e per gli altri l’esigenza del pensiero nihil inde sperans. O meglio, avendo come sola remunerazione la speranza» (p. 154).
Se avesse voluto dirlo in inglese, forse, avrebbe scritto “stay foolish”, come qualcun altro, molti anni dopo, avrebbe detto.
Nella presentazione al primo volume del Commentario al codice di procedura civile, anno 1959, Satta spiega «come ha studiato» e lo fa con queste parole:
«Di solito, lo studio evoca l’idea di una biblioteca, e di un signore che legge e legge col proposito e col risultato di aggiungere, negli scaffali e nel catalogo, un altro volume. Ci possono essere, nelle scienze così dette sperimentali, alambicchi e storte, ma la cosa non muta gran che. Dico subito, a scanso di equivoci, che questo studio è non solo legittimo, ma assolutamente essenziale. Nessuno può pensare di avere una voce viva se non ha ascoltato le grandi voci morte, se non ha vissuto in comunione coi padri, se non ha ripercorso le loro vie, oserei affermare se non ha creduto più che nelle loro verità, nei loro errori. Al di fuori di questo, tutto è sterile dilettantismo. Personalmente aggiungo, ho trascorso coi libri gli anni più belli della mia vita, e se di una cosa mi dolgo è di non aver potuto, per pochezza di forze e per private vicende, abbracciare tutto il pensiero di quelli che mi hanno preceduto» (p. 155).
Nella prefazione al secondo volume del medesimo Commentario, pubblicato un anno dopo, l’Autore sembra voler precisare:
«Ma se noi possiamo capire il linguaggio dei padri, non possiamo, non dobbiamo più parlarlo. Insistendo a farlo, ci riduciamo, nel migliore dei casi, a puristi del diritto, usiamo veramente parole che sono un mero suono, concetti che non hanno più alcun contenuto, non ‘comprendono’ più nulla» (p. 162).

Chiudo con alcuni passi tratti da una polemica che coinvolse Satta, nel 1967. Mazzarella aveva pubblicato un libro dal titolo “Contributo allo studio del titolo esecutivo” e la Rivista di diritto processuale, già diretta da Carnelutti, lo recensisce in un modo che provoca in Satta una vivace, nostalgica, reazione:
«Quando osservo la nuova copertina della Rivista di diritto processuale, e al posto di Carnelutti e della sua imponente solitudine vedo una sfilza di nomi, allineati in bell’ordine come consiglieri di amministrazione, mi vien fatto di pensare a quel mitico drago, cui, dopo la morte, furono strappati i denti, e dai denti seminati vennero fuori tanti soldatini, che si misero a costruire le mura di una città. Il mito, se non erro, è quello di Cadmo, la regione dove il mito nacque fu chiamata Beozia, e fu la patria di Esiodo e Pindaro.
È stata davvero un’idea curiosa quella di credere che la sede vacante potesse essere riempita da un governo di massa, come a dire che la quantità potesse sopperire alla qualità. E pazienza se gli uomini di quantità si fossero assunti il compito devoto quanto assurdo di mantenere nel tempo un’opera che col suo creatore usciva fuori dal tempo: ma essi si sono presi sul serio, hanno creduto di essere, per il solo fatto della inscriptio, figli del drago, draghi essi stessi, nove draghi al posto di uno. È di ieri una recensione di V.D. (trasparente sigla di uno dei dragonetti) a un libro di Massa che comincia così: ‘Il Massa appartiene alla schiera (per fortuna non troppo numerosa) di coloro che credono che il pensiero di Capograssi non solo esprima una personale e irripetibile esperienza, ma possa anche fornire un metodo valido per gli studi giuridici in genere e per quelli processualistici in particolare’. Avete capito? V.D. e Capograssi, quel Capograssi davanti al quale Carnelutti si faceva, e si diceva piccolo piccolo, il cui metodo è tanto poco valido (meglio si direbbe tanto poco metodo) che ricreò Carnelutti, e ricreò la sua stessa rivista, come può agevolmente vedersi scorrendo le annate dalla fine della guerra fino all’avvento di V.D.
È di oggi un’altra recensione, stavolta del dragonetto E.G., che mi ispira queste note. Ma prima voglio sottolineare che i successori a titolo originario di Carnelutti hanno avuto l’imprudenza di conservare la famosa rubrica delle recensioni, dalla quale il drago ha dominato a suo modo per quarant’anni giusti la scena della vita giuridica italiana. Non hanno inteso che questa sì era una esperienza irripetibile, perché Carnelutti capiva i libri senza leggerli, mentre essi li leggono senza capirli. Questo è appunto il torto che io faccio a E.G.: di aver letto il libro di Mazzarella, Contributo allo studio del titolo esecutivo» (p. 268).
Poco più avanti, prima di addentrarsi nel merito, l’affondo:
«È chiaro che io non intendo qui fare una controrecensione: ci penserà M., se crederà, a difendersi nella stessa rivista, come ne ha anche giuridicamente diritto. A me interessa parlare del libro unicamente perché E.G., dopo averlo bistrattato, mi ha tirato imprudentemente in causa, rendendomi praticamente responsabile del fatto che il libro (come a dire la mia opera) confonda, più di quanto non chiarisca, le idee agli studiosi del titolo esecutivo.
Come un libro possa confondere le idee ‘agli studiosi’ mi pare difficile capire a meno che E.G. non identifichi gli studiosi con se stesso, o con gli intangibili professori di ruolo in generale. Comunque dimentichiamoci di avere davanti E.G. anziché Carnelutti, e vediamo di dire qualcosa che possa tornare utile alla scienza».
Il seguito alla pubblicazione di questo scritto, la Rivista di diritto processuale pubblicò, a firma della direzione, un trafiletto nel quale additavano Satta come «un cattivo esempio ‘per aver offeso il diritto fondamentale che ha ogni studioso, al pari di ogni uomo, al rispetto della sua dignità’». La risposta di Satta, pubblicata nella postilla alla ristampa del medesimo articolo, rivela la profondità e la sagacia dell’uomo:
«La Rivista di diritto processuale è padrona di abbrunare la sua bandiera. Ma l’equivoco è evidente. È incontestabile che ogni uomo possiede bergsonianamente la sua dignità, per il solo fatto di essere uomo, né io credo di aver mai offeso la dignità di nessuno. Ma lo studioso non ha una sua dignità, cioè per lui il problema non si pone in termini di dignità, ma di valore. Sulla sussistenza di questo valore il giudizio è libero, né costituisce mai, salvo assurdi privilegi, offesa. Pertanto io non solo non ho dato un cattivo esempio, ma ne ho dato uno ottimo, e i giovani farebbero bene a seguirlo in ogni occasione» (p. 274).
Con queste parole, davvero, concludo, ringraziando te per l’occasione che mi hai dato di riaprire Soliloqui e colloqui di un giurista ed i tuoi lettori, per la pazienza e per l’attenzione.
Fabio Pecoraro