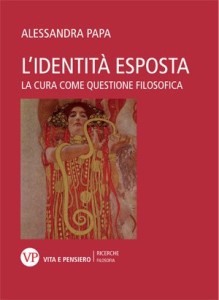Nei nuovi scenari culturali della tecnobiomedicina, la salute diviene infatti suscettibile di continue forzature, con pretese miglioristiche e di potenziamento: si compie un’aggressione sistematica dell’uomo nella sua forma originaria, aggressione che passa attraverso nuovi criteri di liceitàe interventi profondi di alterazione strutturale della persona stessae della sua identità biologica.
«[…] La sofferenza è, con la gioia, il rifugio ultimo della singolarità […] Considero precetto primo della saggezza pratica, esercitata sul piano medico, il riconoscimento del carattere singolare di cura, innanzi tutto di quella del paziente stesso. Questa singolarità implica il carattere non sostituibile di una persona con un’altra […]; la diversità delle persone umane fa sì che non sia la specie ad essere curata, ma ogni volta un esemplare unico del genere umano» (P. Ricoeur, Il giudizio medico, 206, pp. 31-35).
Se quindi la scienza medica procede, mediante l’utilizzo di modelli epistemologici, per investigazioni universali, la medicina come téchne, invece, si realizza proprio in quanto pratica particolare. Per usare un lessico aristotelico, in effetti, corre una differenza fondamentale tra la conoscenza degli universali e il giudizio pratico.
Da qui il distinguo tra la medicina come conoscenza dell’universale, dove per universale ci si riferisce alla malattia come morbo nei suoi aspetti causali che colpisce tutti gli esseri umani e che in quanto tale va indagata, e la medicina come conoscenza del particolare, per cui a essere colpita dalla malattia è la persona con nome e cognome. Nel primo scenario, infatti, si investigano soltanto i principi che costituiscono nei tratti generali una teoria, per cui per esempio rispetto alla medicina in quanto scienza si ricercano le sole cause della malattia, deducendone poi l’andamento secondo regole. All’opposto, in un secondo contesto di indagine battesimale, vale a dire quello più artistico e narrativo, la medicina come tecnica rinvia a una speciale forma di conoscenza che inerisce il singolo nella sua specificità. Così appunto accade in ambito medico quando la cura, all’interno della relazione medico-paziente, è pur sempre necessariamente riferita a quell’unicum che e la persona umana.
C’è, dunque, uno scarto tra la dimensione della, medicina come conoscenza delle cause e che, in quanto tale, è perciò trasmissibile come sapere universale e, viceversa, la medicina come render conto in termini esperienziali. Quest’ultima, infatti, comporta l’obbligo precipuo non semplicemente di riconoscere la malattia, ma anche quello di orientare la terapia, individuando cioè la cura che possa giovare a questa persona, nella sua unicità. Tuttavia, non si tratta di realizzare un mero scarto produttivo, bensì ancora di riconoscere una peculiarità ontologica, che fa sì che lo scientifico debba comunque sempre rassegnarsi a una perdita di autonomia radicale, là dove l’uomo da se stesso si ponga come limite conoscitivo.
A segnare la differenza tra la cura dell’impersonale scientifico e la cura come terapia orientata fortemente sulla persona umana è anzitutto, perciò, la richiesta d’aiuto, il pathos, quella che Ricoeur chiama sofferenza. È, infatti, proprio l’appello patetico del malato a costringere il medico a uscire dai modelli della causalità e dai quadri di comprensione meramente eziologici della malattia. Ci si ammala tutti dello stesso morbo, ma si soffre in modo differente in quanto persone e perciò insostituibili nel soffrire. Cosicché la richiesta d’aiuto è diversa da uomo a uomo.
Ne risulta, allora, che il patologico è fortemente condizionato dall’esperienza concreta del vivere della persona malata e non potrebbe essere altrimenti, perché se per un verso, per usare un’espressione di Georges Canguilhem, sono i malati che «chiamano il medico» (Il morale e il patologico, Torino, 1998, p. 171), dall’altra il medico non può esimersi dal rispondere all’appello che viene dal malato, superando la curiosità dei principi patogeni e guardando oltre il mero fisiologico. Scrive, infatti, Canguilhem a questo proposito: «È stato per primo il malato che un giorno ha constatato che ‘qualcosa non andava’, ha notato certe modificazioni sconvolgenti o dolorose della struttura morfologica o del comportamento. Ha attirato su di esse, a torto o a ragione, l’attenzione del medico. Questi, avvertito dal malato, ha proceduto all’esplorazione metodica dei sintomi evidenti e più ancora dei sintomi latenti. […] Ora vi è qui un oblio professionale […]. Il medico ha la tendenza a dimenticare che sono i malati a chiamare il medico […]. La vita non si innalza alla coscienza e alla scienza di se stessa se non tramite […] il dolore» (ibidem).
Un mutamento di paradigma Il malato, in quanto persona vulnerabile, è dunque uno stilema ontologico complesso. È la persona umana messa a nudo dalla malattia, sguarnita di “vita buona” in senso aristotelico (Aristotele, Metafisica, Z 7, 1032 a 12-1034 a8), che richiede solidarietà e assistenza, a causa di una sopravvenuta condizione di squilibrio; circostanza che la espone tanto all’incertezza quanto alla necessità di stabilire relazioni improntate su schemi e modelli di cura complessi. In particolare, il concetto di vulnerabilità, inteso appunto come nudità, rimanda per contenuti e semantiche ai ruoli riflessivi della biopolitica liberale di matrice anglosassone, allorquando è artificialmente parametrato su modelli sociali competitivi ed è inteso come mancanza di bene, secondo sistemi di azione utilitaristici.
In simili scenari, in tempi in cui si assiste a una medicina che sembra aver perso la grammatica ippocratica della beneficialità, ci si chiede se proprio l’homo vulnerabilis – icona fragile bandita dalla modernità – non sia sottoposto, con un forzato impoverimento ontologico, a pressioni utilitariste e funzionaliste, per essere tragicamente isolato e svincolato dal legame comunitario. Quanto poi è andato evidentemente perduto nei dogmatismi della medicina scientifica ancorata a parametri statistici è anzitutto l’antica idea di salute come equilibrio di natura, che si è trasformata in un’idea-forza dell’umano in grado di sostituire la ragione medica con una sorta di ragione progettante che ha smarrito la visione originaria, carnale, dell’uomo nel suo aspetto di fragilità creaturale, immaginandolo come un mero organismo tessutale e facendone un antifragile: un Über-Mensch della modernità di segno negativo.
Detto in altri termini, la salus come virtù naturale è andata oramai perduta nelle sue implicazioni semantiche antiche e va rapidamente dissolvendosi in un concetto artificiale di salute post-umana. Nei nuovi scenari culturali, la salute diviene infatti suscettibile di continue forzature, con pretese miglioristiche e perciò soggetta a lecite modificazioni, non solo rispetto alla patologia, ma anche rispetto a una condizione di normatività naturale, o meglio di normalità. Da qui è derivata un’aggressione sistematica dell’uomo nella sua forma originaria che passa attraverso nuovi criteri di liceità e interventi profondi di alterazione strutturale della persona stessa e della sua identità biologica, accampando sovente giustificazioni che, se pure oramai gradite al senso comune, non sono sempre accettabili rispetto alla grammatica etica di composizione profonda della soggettività.
La questione delle trasformazioni pratico-teoriche della condizione umana sul piano filosofico pone, dunque, un problema di gittata antropologica riguardo all’identità e alla comprensione stessa dell’uomo. In un’ottica funzionalista ed efficientista, l’introduzione di un fine esterno artificiale, che riduce l’essere umano alle sue capacità e alla sua portata qualitativa, autorizza a ritenere l’uomo mera natura biologica, comunque estraneo alla sua nascita, e pertanto non più temporaneo e finito, ma temporaneo e suscettibile di modificazioni successive e continue.
Con la medicina miglioristica e del potenziamento è, dunque, cambiato il paradigma di cura della modernità. Il gesto di cura, non solo come soccorso samaritano, ma anche inteso come il tentativo del medico di ristabilire un equilibrio tra la persona umana e il suo ambiente, è definitivamente collassato sotto gli urti di una medicina che da una parte ha forzato in modo lineare i propri aspetti scientifici in modo autoreferenziale, e dall’altra ha sormontato la sua stessa natura artistica travisandola nei compiti in un fare progettante che stressa continuamente la natura umana nelle sue forme originarie.
Se, infatti, l’antica idea di cura aveva ancora a che fare con il limite normativo del secundum naturae, con la medicina moderna invece la normatività naturale è stata messa in crisi dalle tecnologie avanzate che hanno prodotto una corporeità multi-buttons. In particolare, la cura affidata sempre più spesso all’imago della tecnologia, sposta continuamente, negli aspetti applicativi, il limite stesso della natura, oramai smarginalizzata.
Sotto i colpi dei bisogni e dei desideri individuali, è, infatti, il concetto di salute a diventare sempre più divaricato dal naturale in sé, proprio a causa di quella nuova capacità di lettura profonda che è propria della tecnobiomedicina. Da qui poi anche la torsione del concetto di ‘normalità’ della vita umana nella prospettiva di un utile contrattualistico e del soddisfacimento di aspettative sociali che, nei fatti, minimalizzano e riducono la corporeità al modello funzionalistico della performance e a criteri di efficienza sociale e di potenziamento artificiale, oltrepassando il modello della terapia e legittimando un nuovo ideale normativo, povero di semantizzazioni etiche.
Nata dal connubio tutto moderno tra biologia, medicina e tecnologia, la tecnobiomedicina ha deformato la relazione ippocratica, stravolgendola nei suoi principi fondamentali, e ha inaugurato una sorta di crisi dell’etica in cui la persona umana è divenuta oramai una vera e propria emergenza. Cosicché, in ambito bioetico, ne è scaturito un effetto domino che apre oggi un fronte di riflessione molto problematico: dalla medicalizzazione della nascita, all’interesse riabilitativo, al fine vita, alla salute a tutti i costi e al migliorismo. In questo senso ciò che oramai sembra essere messo definitivamente a rischio è allora proprio la persona umana.
A seguito di una sovraesposizione del personale e dell’identitario all’alta tecnologia e al biologisrno sono, infatti, venute meno quelle tutele che custodivano la persona ippocratica oltre l’uscio di casa (“In quante case entrerò – ammonisce Ippocrate nel suo Giuramento –, andrò per aiutare i malati, astenendomi dal recar volontariamente ingiustizia e danno […]”): l’erosione della sua dimensione privata, la violazione di quegli assetti strutturali della personalità che hanno sempre fatto rimando alla nominazione, hanno stravolto l’antica pratica medico-assistenziale, così come Ippocrate l’aveva per primo teorizzata.
Sul piano culturale ha poi fatto da cassa di risonanza l’idea della malattia come condizione difettiva, legittimando peraltro solo la natura umana come integrum e mettendo al bando quella corporeità ferita che entra in relazione proprio in quanto vulnus, poiché ferito-tra-gli-altri. In tal modo la medicina come ‘semplice’ scienza ha portato alle estreme conseguenze l’idea organicista dell’umano, ignorandone il pathos e anzi isolandolo come fatto a sé stante. L’appello patetico è oggi sottoposto a esame secondo logiche deterministiche e valori artificiali che lo condizionano nella loro nuova normatività: il normale diviene così il patologico rispetto al desiderio della perfezione immaginata. Al contempo la medicina come arte – sempre più decisa dalle ambizioni prometeiche di un degenere homo pictor (Hans Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, 1999, pp. 204-223) – sembra avere pure essa completamente frainteso il suo compito originario, quando ha assunto storicamente come oggetto di trasmissione artistica l’uomo quale bios progettabile e oggetto puramente estetico.
Una zona sempre più consistente della medicina, esacerbata nei suoi compiti e radicalizzata nelle sue fisionomie di scienza e di arte, oscillando in maniera schizofrenica tra la spiegazione razionale e quella estetica, ha così cominciato a pensare l’uomo, ma affrancandosi dalla filosofia. E lo ha pensato come l’antifragile appunto, a partire cioè dalla malattia considerata non più come condizione umana, ma come comportamento di segno negativo, se non persino polarizzando biologicamente la differenza tra pathos e male, dunque interrompendo lo scarto ontologico tra la sofferenza (non più compresa come rivelatore universale dell’umano) e la malattia (oramai intesa come peccato biologico), per farne una distanza organica.
Da qui pure la distorsione del telos metafisico. L’uomo – che è un essere teleologico – con il suo cascame di materialità è oramai teorizzato come essere puramente casuale, un prodotto occasionale che ha totalmente deviato dalla finalità metafisica. I nuovi mezzi biotecnologici hanno generato, infatti, una nuova finalità dell’uomo: il miglioramento della natura umana, telos che risulta evidentemente più adeguato a un progetto solo provvisorio di natura umana. Gli aspetti puramente conoscitivi della medicina rischiano, in questi progetti, di sopraffare quelli artistici, forzati pure essi, in una formidabile volontà riedificativa dell’umano.
Ciò che si sta smarrendo, in questo processo di razionalizzazione della pratica di cura, è allora l’autocomprensione del soggetto stesso. Da qui il rischio inevitabile di una perdita valoriale del soggetto di cura come soggetto morale: trasformato in un individuo normato secondo canoni artificiali e oramai configurato secondo modelli teorici prestazionali preordinati.
In un’angolatura biopolitica, pertanto, l’uso crescente e potenziato delle tecnologie traccia oggi nuovi scenari rispetto alla relazione fra tecnoscienze e natura umana, ma anche rispetto alla stessa pratica medica.
La tecnica, infatti, in quanto oramai ‘cultura’ – che ha generato un linguaggio con cui pensare e progettare una nuova e artificiale identità umana, in nome del progresso e del miglioramento stimati come conquiste sociali – rischia, in effetti, di sovraordinare le categorie della salute, raffigurando l’uomo nella sua forma originaria come antico e ormai facile da superare.
Alessandra Papa, L’identità esposta. La cura come questione filosofica, Vita e Pensiero, 2014, pp. 118-124.