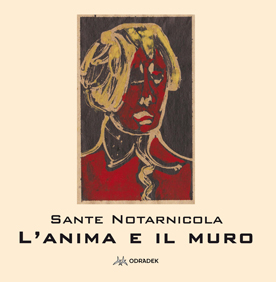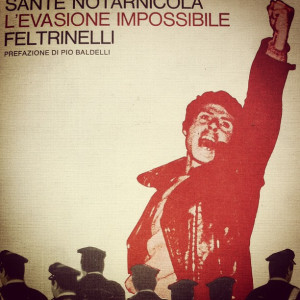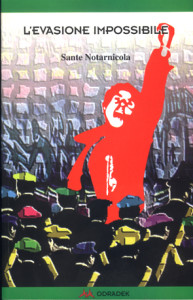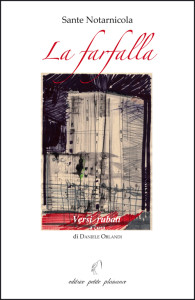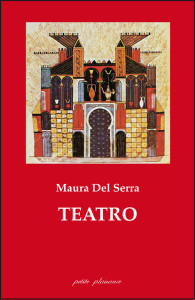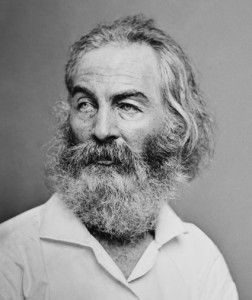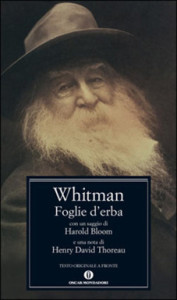Intervista a Maura Del Serra
di Pierluigi Sassetti e Giuseppina Pagliafora
Stampa il testo in versione PDF: Maura Del Serra, Il lavoro impossibile dell’artigiano di parole
“Nòcciolo di saggezza
in polpa di follia:
la vitapoesia”
Maura Del Serra, Microepigrafe
Non so perché, ma lei mi intimorisce un poco.
«Spesso incuto soggezione, sa che me lo dicevano anche quando ero ragazzina? Eppure sono geneticamente una timida, un’introversa».
Scorrendo tra le sue pagine nel sito Nuovo Rinascimento la cosa che salta subito all’occhio è che il suo lavoro di poetessa e traduttrice è imponente …
«Sì, se pensa a Kavafis e alle sue cento poesie. Diciamo che sono poliedrica; comunque quello che sostanzialmente ricerco è una sola cosa, andare verso la mia origine, la mia sorgente espressiva. Anche Pasolini, di cui stavamo parlando poco fa, cercava questo, no? Un anelito a tornare nel grembo materno e della lingua. Nel caso suo era un grembo tragico, con le ben note scissioni (quelle ideologiche e quelle fra l’eros e l’onestà, come diceva). Però è importante la sua identificazione con la madre, la “madre fanciulla”, e in generale l’elemento materno del poeta che è allo stesso tempo cristologico: un groviglio, nel suo caso, istintivamente e volutamente “eretico”, scandaloso. Per me l’elemento materno è fondamentale, non in senso personale soltanto, ma perché, come diceva Saba, il poeta è sempre madre anche se uomo, perché etimologicamente “comprende”; Saba diceva questo facendo l’esempio del Petrarca, e affermava giustamente che il Petrarca era anche Laura. Questa croce degli opposti credo sia una forma di nutrimento, anche nei termini di maieutica pedagogica, del lavoro che svolgete voi mediante l’educazione».
Certo, di lavoro sulla forza soggettiva.
«Cioè scoprire le proprie radici, le proprie linfe, scoprire che la forza umana si nutre di debolezze, quindi è importante sapere come cercare una catarsi per trascenderle, non fingere una forza che non si ha, magari di tipo superuomistico, wagneriano, “falso sublime” come lo chiamo io. Bisogna cercare nelle proprie radici quello che ci nutre, anche se è quello che ci ferisce. Tornando a Pasolini, potrei ricordare quella sua bella espressione “Casa della ragione sorella della pietà”. Questo è il vero cercare: la “casa della ragione”, però che sia una ragione nutrita dalla pietas, altrimenti ritorneremmo ai limiti, alle strettoie ideologiche dell’illuminismo, e mi pare che non abbiamo bisogno di questo, in un’epoca così drammatica per la sua deriva etica, associata all’oltranza tecnologica: questa comunicazione globale, che è anche alienazione, ha bisogno di trovare forme semplici e complesse insieme, ma non complicate, di far scendere la mente nel cuore, come dicevano gli indiani d’America e i mistici di tutte le latitudini. Gli intellettuali in genere fanno il contrario, fanno salire il cuore nella mente, quindi, come si dice, tutto diventa cervellotico. Quello che invece cerchiamo di fare noi, dico un noi molto virgolettato – i poeti, gli artisti, ma anche le persone più impegnate in senso umano – è appunto far scendere la mente nel cuore, pensare con il cuore. Forse è l’unico lavoro degno che si possa fare, attraversso qualunque altro lavoro esteriore».
Come si può, da tutto questo, arrivare a tradurre?
«L’elemento base del tradurre, oltre che del fare poesia, lo dice la parola stessa, è un trans-ducere, un gettare ponti da una lingua all’altra, da una concezione del mondo all’altra, quindi è un’operazione teoricamente impossibile, ce lo ha già detto Dante tanti secoli fa nel Convivio: “Nulla cosa per legame mistico armonizzata… si pote in altra lingua transmutare senza perdere tutta sua dolcezza”, ed è vero. Però noi facciamo continuamente questa cosa impossibile, e quello che il lettore legge non è né l’autore né il traduttore, ma è un terzo autore in una terza lingua. Se Lei legge un libro di poesie con il testo a fronte, in realtà legge due poesie spesso molto diverse. Attraverso il traduttore, nei casi meno riusciti, si crea un pasticcio, un fallimento artistico; nei casi di traduzione congeniale, invece, si crea una terza presenza espressiva, come se in un duetto vi fosse una terza voce che le fonde tutte e due. È un’operazione essenzialmente musicale, che si fa per una specie di “medianità”, per vocazione, perché i traduttori purtroppo vengono pagati miseramente (ed è anche difficile definire “quanto” dovrebbero essere pagati). Ci sono delle difficoltà oggettive, intrinseche al tradurre; perciò affinché l’operazione riesca ci deve essere una vera vocazione. Io non ho paura ad usare questa parola tipica del Romanticismo, perché non ce n’è un’altra che possa sostituirla. Non c’è un sinonimo più “moderno”. Margherita Guidacci, di cui ho curato l’edizione di tutte le poesie, è una poetessa che amo molto, ed era una bravissima traduttrice da più lingue, e diceva: “Certi autori sento che mi vogliono” e allora c’è un’empatia, e la cosa riesce. “Se l’autore non mi vuole”, lei si esprimeva così in modo molto semplice, “ci posso provare anche molte volte, lo posso amare molto” – e faceva l’esempio di Keats – “però la traduzione non riesce, ci si sente come respinti. È come sbattere contro un muro”. Ed è una cosa che ho provato anch’io diverse volte, nei tentativi di traduzione da autori che “non mi volevano” (ad esempio Sylvia Plath). Allora bisogna lasciar perdere; ci deve essere un’empatia profonda in cui sommare e fondere questi due elementi che agiscono anche nella poesia in proprio: il miracolo (qui sto citando Ungaretti) e il mestiere; quindi diciamo che deve esserci “l’orecchio assoluto” per sapere come rendere certe forme e creare, nel caso della poesia, una nuova poesia – non una parafrasi, o una prosa, non un rifacimento piatto, magari anche onesto, ma una nuova poesia. E poi il mestiere, ovvero le risorse tecniche e linguistiche che abbiamo. Però se non c’è primariamente questo feeling (che è quello stesso dell’amore e dell’amicizia), tra due voci, tra due mondi interiori, tra due cosmi poetici, intellettuali ed umani, la traduzione non può riuscire, perché è come voler abitare su di un ponte: l’ho scritto in Tentativi di certezza il mio ultimo libro di poesie pubblicate, che ha nel finale una parte aforismatica, di poesie molto brevi».
Può capitare che non si riescano a tradurre proprio quegli autori che si amano particolarmente?
«Sì, può capitare, se si amano in maniera troppo viscerale, come nell’amore tra persone; cioè, se è più una passione possessiva che un amore maturo, può capitare che la passione blocchi e non si trovi la forma per esprimere, per traslare, far passare attraverso il ponte linguistico e mentale quello che deve diventare un’altra creatura. Sì, può succedere, certo. Però anche la passione può diventare amore maturo, come tra le persone: se davvero un autore lo si ama e non si è solo infatuati, se lo si ama, poi la passione si decanta come il mosto in vino e allora diventa possibile una buona traduzione.
Come ha scoperto questa sua vocazione, quando ha iniziato?
«Con la traduzione? Beh, nel lontano 1985, quando mio marito, che non conosce il tedesco, voleva conoscere Else Lasker Schüler della quale aveva letto, e gli erano piaciute, alcune poesie in un’antologia di poeti espressionisti; questa poetessa così straordinaria, che scriveva in tedesco e diceva di scrivere in ebraico era a sua volta un’ebrea piuttosto eretica. Diceva: “Io non sono ebrea per gli ebrei, ma sono ebrea per Dio”. E scriveva in un tedesco tutto particolare, molto fantasioso. Mi rammento che, vedendo le poche traduzioni italiane esistenti, che erano quelle (nemmeno brutte) della Mandalari, sentii che mancava qualcosa, erano “sedute”, non c’era quella vis, quella energia che in lei è fortissima, un phatos viscerale molto forte, perché è stata legata all’espressionismo, però in modi tutti suoi, fantasiosi, nostalgici e orientaleggianti. Allora provai a buttar giù qualcosa, a tentare una traduzione, ma solo per me e per mio marito: avevo molta riluttanza a pubblicare queste versioni poiché, essendo giovane, temevo le reazioni dei germanisti, quelli del mondo accademico di cui da poco facevo parte, a nche se molto indipendente, e di cui ho fatto parte fino a poco tempo fa; in quei settori abbastanza chiusi, non si deve invadere il territorio altrui. Però, devo dire, anche mio marito, mi incoraggiò, mi disse: “Perché no? Vedrai, saranno clementi”. Poi appunto ho realizzato l’antologia Ballate ebraiche e altre poesie, che peraltro mancava perché ce n’era una del 1962 con pochi testi, quella col disco della Proclemer, fatta da Baioni (che successivamente ho conosciuto anche personalmente, e dal quale ho riucevuto i complimenti, in occasione della discussione di una tesi sulla Lasker Schüler avvenuta a Firenze); dopo quella sua versione antologica non ce n’erano state altre, e allora feci questa antologia traducendo l’intero corpus delle Ballate ebraiche ed un’ampia scelta dalle altre raccolte per l’editrice Giuntina, e devo dire che il volume ha avuto molto successo, è andato benissimo anche dal punto di vista commerciale. Dieci anni dopo, nel 1995, in occasione di una ristampa, ho modificato alcuni punti della traduzione e ho rifatto l’introduzione, che nella prima versione era un po’ criptica, ed il libro è tuttora in catalogo. Dopo quello dei germanisti sono passata ad “invadere” il territorio degli anglisti e dei francesisti, con quache sporadica incursione anche fra gli ispanisti, ma ho sempre considerato il lavoro di traduzione com parte integrante del mio lavoro poetico».
Sarebbe corretto dire che lei approda alla traduzione partendo dalla poesia?
«Sì, è quel discorso che facevo prima sulla musica, sull’avere orecchio empatico. Non ci si può riuscire facendo solo un lavoro accademico. Ma ci sono dei poeti che io non oserei tradurre perché secondo me sono intraducibili come, in area francese Baudelaire, e in area tedesca, Rilke o Celan che sono stati tradotti diverse volte in modo (specialmente Celan) accademico, e risultano svuotati di aura e di segno, di quel senso tragico che li contraddistingue. In sintesi, per tradurre un poeta ci vuole un altro poeta, e che sia anche sulla stessa lunghezza d’onda. E’ una cosa effettivamente molto complessa, però è come la vita: estremamente complessa e inconcepibile, ma poi nel suo manifestarsi quotidiano è anche semplice, ci si lascia guidare da questa voce primigenia, da questa ispirazione – uso un’altra parolona romantica che non ha sostituti».
Questo vale solo per la poesia o anche per la prosa?
«Vale anche per la prosa, anche se il mio orecchio è sempre sintonizzato istintivamente sulla poesia. Ma anche nella prosa si deve ricercare il ritmo, che c’è sempre, e ricrearlo, senza fare un calco della lingua di partenza in quella di arrivo, tenendo conto che l’italiano è appunto, detto tra virgolette, una lingua “pesante”, nobile, petrarchesca, barocca, fronzuta, cioè “lunga”. E di questo, traducendo dall’inglese, bisogna tenerne conto, perché si appesantisce tanto. Risulta più facile tradurre da lingue altrettanto “pesanti” come il tedesco, perché la struttura nella sintassi è quella greco-latina, o dal francese e dallo spagnolo. Con l’inglese invece bisogna fare un salto interiore ed espressivo, camminare un po’ sulla fune; ho trovato questo tipo di difficoltà quando ho affrontato la Woolf. Della Woolf ho tradotto Orlando, Le onde, e Una stanza tutta per sé, il suo manifesto femminista. Ma è soprattutto Le onde ad essere scritto in maniera decisamente musicale, sono sei voci, sei personaggi incvarnati da sei voci musicali, un sestetto, e il ritmo nell’inglese è completamente diverso da quello italiano; quindi bisogna trovare una forma musicale italiana che non tradisca, o per meglio dire che tradisca bene, perché bisogna tradire, ma tradire in modo amorevole rispettoso dell’originale. A dirlo così, sembra un groviglio di ossimori, ma l’orecchio, sempre quello, ti guida, e ti guida l’autore (o l’autrice) come un Virgilio. L’autore va anche conosciuto, va studiato. È indispensabile conoscere la vita, la biografia, il background, perché il suo linguaggio è anche quello del suo tempo, quello della sua cerchia sociale e familiare, quindi c’è da tener conto di molti elementi. Però, se c’è l’amore, la passione di base, il consenso reciproco, se l’autore ti accetta, “ti vuole” come specchio, accetta di farsi tradurre, i risultati possono essere buoni. Non sono pienamente contenta delle mie traduzioni, ovviamente tutto è perfettibile, però si tratta di un’esperienza di arricchimento personale, che impone di mettersi al servizio dell’autore; il risultato poi dipende dai molti fattori di cui parlavo sopra. Nella poesia personale può prevalere, e spesso prevale, l’elemento del narcisismo, dell’io lirico, cosa che succede in misura maggiore o minore in tutti i poeti. Si impara molto dai bambini, per come sanno ascoltare e decifrare magicamente anche quello che c’è nei nostri silenzi, nel linguaggio non verbale. La traduzione è qualcosa di analogo, è un lavoro di artigianato, come quello del restauratore che riporta allo splendore i capolavori antichi e trascurati; in fondo il lavoro che fa il traduttore è analogo».
Lei è stata anche docente universitario. Come si concilia questa forma di artigianato e l’insegnamento accademico, che è distaccato, sterile, dà gli strumenti ma poi non li collega?
«E’ vero, l’insegnamento accademico tende a fornire degli strumenti non sempre in maniera adeguata al loro uso. A meno che non si tratti di docenti eccezionali, che sono i famosi maestri che noi tutti abbiamo cercato e cerchiamo, che tutti gli studenti cercano, ma sono rari… anch’io li ho molto cercati, ma non ne ho mai trovati in quell’ambiente.. In questo caso bisogna farsi maestri di se stessi. Parlavo prima, citando Ungaretti, del miracolo e del mestiere. Il mondo accademico lavora solo sul mestiere, tranne rarissime eccezioni. I traduttori migliori, anche se insegnano all’Università, magari fanno altre cose, sono anche scrittori, non sono accademici puri, perché il mondo accademico è sterile, come un laboratorio di analisi mediche. Proprio perché ero una voce fuori dal coro mi sono trovata sempre piuttosto emarginata, il che per me era anche una fortuna perché potevo lavorare per conto mio, potevo fare i miei corsi di poesia e gli studenti mi seguivano davvero con interesse».
Un esempio di forza soggettiva…
«Sì, cercavo di far capire anche cosa c’è dietro le rime, le cose che magari abitualmente in un corso non vengono prese in considerazione, e lo facevo usando un po’ tutti gli strumenti che anche la critica formalistica può usare, gli strumenti tecnici e la retorica, ma sottolineando la loro caratteristica di strumenti, che non vanno finalizzati a se stessi. Se si disseziona una poesia, come si faceva ai tempi dello strutturalismo, ci rimane solo il cadavere, non c’è più né l’autore né l’opera. Personalmente, pur avendo avuto delle amarezze durante la mia attività in ambito universitario, non me la sono mai presa troppo perché il poeta deve essere pronto a “pagare” per la sua vocazione; non si può avere tutto, in questa e nell’altra dimensione e io ho sempre fatto prevalere l’artigianato. Ovviamente, nell’artigianato vanno impiegate tutte le strutture del mestiere, si tratta sempre di conciliare, di trovare il logos, il dialogo con queste croci di opposti: il caos e l’ordine, l’intellettualismo e l’emotività; bisogna trovare e tessere il filo, la ragione, il logos che abbia in sé anche gli strumenti della pietas, quindi anche l’inconscio – ben venga dunque l’eredità della psicoanalisi, ma senza più il peso ideologico che ha avuto in origine, alleggerita da quel carico un po’ punitivo, per cui se si usciva da quelle forme dogmatiche si era “fuori strada”. Ora, in una società globale (almeno virtualmente, perché poi è sempre dominata dai nazionalismi, dai personalismi, da ferite e incomprensioni linguistiche nel senso interiore (perché le lingue sono mondi) tuttavia abbiamo gli strumenti per superare questi muri. Certo non si può negare che, come sentiva Pasolini, la storia è tragica. Anche Caproni, che era suo amico, scriveva con il suo humour nero: “Fa freddo nella storia. Voglio andarmene”. La violenza che vediamo continuamente all’opera nella storia e nel quotidiano, convive però e si mescola con l’aspirazione umana all’assoluto, quindi il metatemporale e il temporale; c’è sempre e dappertutto questa lotta tra il caos e l’ordine. Io non credo si possa superare questo dualismo, perché la condizione umana, la condizione nostra è costruita sul due (quando dico nostra, voglio dire anche quella degli animali, delle forme di vita complesse): il ritmo del cuore, il ritmo del tamburo, il ritmo primordiale, sono tutti scanditi sull’uno-due, uno-due, e quindi bisogna lavorare su questa dialettica. La filosofia poi l’ha concettualizzato, con Hegel, l’ha definito tesi, antitesi e sintesi. Può essere un lavoro filosofico, ma non deve essere un lavoro intellettualistico perché altrimenti la sintesi non passa nella vita, rimane nella testa: come scriveva Canetti, in una “testa senza mondo”.
Pasolini asseriva che gli intellettuali fanno un lavoro tra comodità e benessere.
«È vero, ma non sempre, adesso lo è diventato molto di più rispetto ai tempi di Pasolini che lo diceva in senso provocatorio e autopunitivo; credo che se vivesse oggi Pasolii sarebbe molto più tragicamente angosciato; quando nel dopoguerra lui si è formato, e faceva il suo lavoro pedagogico e poetico, così eclettico e ricco, così straordinario (penso al suo cinema più che al suo teatro e alla sua poesia) la società era ancora strutturata secondo un modello “classico”, a scuola c’era l’ordinamento umanistico gentiliniano, e nella società, pur pesantemente gerarchica, l’intellettuale aveva ancora una voce, specie se engagé o “militante”, come si diceva allora. È per questo che P.P.P: ha potuto creare scandalo, mentre oggi è scomparsa l’idea stessa di scandalo (sostituita da quella di provocazione furbesca). La deriva etica, e l’oscuramento della cultura umanistica hanno comportato la perdita del ruolo “di rispetto” dell’intellettuale e dell’artista come testimone (non come maître à penser, che se lo è, lo è senza volerlo) ma come testimone ed interprete della condizione umana. Pasolini, cattolico d’origine, aveva vivissimo questo senso, anche sacrificale, della testimonianza come etimologica martyrìa, ma rispetto agli anni ’50 e ’60, agli anni del boom, e anche ai ’70, quelli “di piombo”, è diventato tutto molto più difficile: allora lui poteva ancora vedere il nemico all’esterno (la corrota società borghese) e poteva costruire il mito e il rimpianto del mondo contadino primigenio in via di sparizione. Oggi la società cosiddetta post-moderna è un melting pot massmediatico, molto confuso, dominato dalla finanza e dalla tecnologia. I giovani, ovviamente, sono sempre assetati di verità, di bellezza e di valori, ma sono a loro volta confusi e delusi in una società dell’immagine che li emargina e ne rifiuta i doni creativi, che sono quelli del futuro stesso.
Quello che cercano di fare i poeti – almeno io nel mio hortus, ma credo tutti gli scrittori e gli artisti non asserviti – è cercare di dar vita ad una società della sostanza, opposta alla società dell’immagine e dei consumi. Certo una società simile è difficile da costruire; nella società attuale, dominata dai gruppi di potere (segnatamente da quello finnanziario), dalla forza che schiaccia e prosciuga l’anima e la realtà, i valori della persona tendono ad essere sacrificati o falsamente esaltati per gli scopi del potere stesso. In questo processo c’è un elemento veramente tragico, tragico e morale, come diceva Campana sulle orme di Nietzche. Campana è stato il mio primo amore poetico, e il suo destino “folle” è abbastanza emblematico del poète assassiné. Lui è un po’ il nostro Hölderlin, (certo, fatte le debite proporzioni); e anche Hölderlin è stupendo ma intraducibile, io non ho mai provato a tradurlo, anche se ho trovato insoddisfacenti le traduzioni italiane che ho letto; la migliore mi pare quella vecchia di Giorgio Vigolo che è arcaica, datata (è degli anni ’40) però Vigolo era un poeta, quindi l’orecchio epico e lirico che Hölderlin richiede c’era».
C’è una lingua che sente più affine a sé, una lingua da cui preferisce tradurre?
«Ultimamente ho tradotto molto dall’inglese ma…vede, io non parto dalla lingua, parto dall’autore, da un autore che amo, e solo di conseguenza dalla sua lingua . Ora è un periodo in cui mi dedico sll’inglese, perché amo molto Katherine Mansfield, e avendo già tradotto tutti i suoi racconti – un unico volume della Newton Compton recentemente ristampato – mi sono messa, veramente per amore, a tradurre tutte le sue poesie che erano state parzialmente antologizzate in diversi periodi e con differenti traduzioni che a mio aprere non le rendevano merito. Ho curato l’antologia Poesie e prose liriche, edita da “petite plaisance”, dove ci sono pressoché tutte le sue poesie, con l’aggiunta di un corpus di prose liriche giovanili, basandomi sul testo inglese di O’ Sullivan che era uscito già nel 1988.
Poi ho incontrato, o meglio riscoperto, la voce di Tagore, che avevo letto in gioventù, negli anni Settanta, quando c’era la moda un po’ hippie dell’Oriente, e ho visto che non c’era nessuna traduzione italiana moderna della sua autobiografia; ce n’era una del 1928 che però è uno stranissimo rifacimento, assai fantasioso, con aggiunte e divagazioni del traduttore. Allora ho tradotto questa sua autobiografia intellettuale, Ricordi di vita, che è uscita presso “Studium” di Roma (è il primo volume della nuova Biblioteca Universale di Studium). L’inglese di Tagore è ovviamente assai diverso da quello della Mansfield, che era sì una “coloniale” ma si era formata studiando a Londra. L’inglese di Tagore, invece, era quello un po’ “strano” dell’India soggetta all’Impero Britannico; tra l’altro la traduzione inglese dell’autobiografia – che in originale era scritta in Bengali – non l’ha curata lui stesso, ma un nipote con l’approvazione dell’illustre zio.
Lei dice che io ho scritto tanto, ma se all’opposto di Kavafis, considera quello che ha scritto Tagore: 2.400 poesie, 2.200 canzoni, trenta opere di teatro, romanzi, eccetera…
Quindi l’inglese…
«In questo periodo sì. Poi l’editrice “Archinto” di Milano mi ha proposto di tradurre il carteggio di Tagore con la Ocampo, non Sylvina Ocampo, l’amica di Borges, ma la sorella maggiore, Victoria Ocampo, che è nota elitariamente ma che è stata una donna di grande talento, un’argentina molto brillante, colta, ambiziosa e impegnata, una mecenate di artisti e una femminista individualista. È stata la fondatrice della rivista “Sur” che ha “lanciato” Borges. C’è dunque questo carteggio con Tagore che risale a quando lo scrittore nel 1924 è andato a Buenos Aires e la Ocampo lo ha ospitato e si è innamorata di lui (del resto si diceva che tutte le donne del Bengala fossero innamorate di lui). Questo rapporto con la Ocampo poi continua a distanza per quindici anni. Sono lettere molto belle, ricche e fervide
Curare questo volume, ora uscito, per me è stata una bella esperienza perché mi sono confrontata con un “altro” inglese: l’inglese di Tagore è sempre quello coloniale, ma la Ocampo, che è argentina, scrive un inglese diverso, perché il suo imprinting, la sua formazione straniera era francese, perché allora, negli anni ’20, era la lingua colta dominante, quindi a volte fa dei calchi dal francese e dallo spagnolo, delle forme ibride e degli errori; tuttavia non ho fatto non un’edizione critica, ma un’edizione “leggibile”, anche perché se avessi dovuto continuamente mettere la parentesi quadra e la spiegazione “qui c’è il probabile calco del francese”, ed altre specificazioni del genere, trattando una materia che invece è appassionante, tellurica, sarebbe diventa un lavoro troppo accademico, pesante. E il carattere del libro non lo avrebbe sopportato».
Giusto per capire, parla tutte le lingue da cui traduce?
«Be’ sono una traduttrice molto “a tavolino”. Le parlo prevalentemente nei viaggi, anche se sono consapevole che non facendone un uso frequente le lingue si perdono: il tedesco ad esempio ora l’ho abbastanza perso, ma tutte le lingue richiederebbero un uso assiduo; cerco di tenermi in esercizio leggendo i poeti».
Perché lei ha sempre letto in lingua originale?
«Certo, sempre! O meglio: nell’adolescenza, quando non conoscevo, il francese leggevo per esempio Baudelaire con il testo a fronte. Ero partita da Baudelaire che ha delle forme molto regolari, come i sonetti, per capire come era strutturata la lingua “alta”, poi naturalmente ho approfondito la grammatica, la sintassi ecc.. Certo se scrivo in una lingua strtaniera probabilmente faccio degli errori, però quando traduco in italiano sono quasi sicura di non farne, almeno non di rilevanti».
Si può cominciare a tradurre senza avere la sicurezza di sapere tutto?
«Sarebbe mostruoso avere la presunzione di sapere tutto. Pascoli ha fatto delle bellissime traduzioni da Tennyson, quasi dei rifacimenti, ma splendidi, e non credo che conoscesse bene l’inglese, quanto meno non ci sono prove che lo avesse studiato. È lecito e urile confrontarsi anche con le soluzioni di altri, ma che non siano copiature o calchi travestiti».
Le capita mai di leggere le traduzioni di altri autori prima di incominciare a tradurre?
«Certo, devo vedere in che modo è stato trattato l’autore e se la traduzione è buona può non valere la pena farne una nuova».
E nel caso di autori mai tradotti?
«Quella è una sfida “senza rete”. Per l’autobiografia di Tagore questo problema si è posto – come in passato per Barnes, per Herbert, per Segalen, per la Kolmar – perché la “traduzione” che c’era, quella del ’28, non era una traduzione, era una parafrasi moto fantasiosa. Del carteggio con la Ocampo non c’era nessuna traduzione, ma ha supplito l’esperienza, l’orecchio, l’amore, la tecnica, tutti “aiutanti magici”. Poi, certo, tutto è perfettibile e se dopo ne uscisse un’altra migliore della mia… non soffro particolarmente d’invidia, casomai posso dire a me stessa: “perbacco, vediamo cosa posso imparare per la prossima volta”».
Le è mai capitato di trovare una traduzione che le è piaciuta più della sua?
«Ora se le dico di no mi sembra di essere una megalomane…però sono un po’ imparagonabili le traduzioni, sono come le persone. Per esempio, quelle della Woolf fatte da Nadia Fusini non sono affatto male, ma il suo è un altro modo, è un altro approccio, in un’altra lingua. Lei traduce in una buona prosa, però secondo me le manca un po’ di ritmo, di “volo”. Ma è uin confronto veramente improbo e ingiusto da fare: ogni traduzione è unica, e per giudicare le proprie non si ha la distanza critica necessaria».
Sembra che stia parlando di brani musicali.
«Sì, perché la poesia è musica. È difficile dire se la musica provenzale sia migliore di quella indiana, o se Schubert sia meglio di Puccini, ognuno è veramente un “cosmo”. Diciamo che in passato ci sono state delle traduzioni da cui ho imparato molto, però non ho mai cercato di riprodurle, non sarebbe possibile né produttivo. Un lavoro “vero” deve trovare la sua voce e il suo stile. Ricevo tanti libri di poesie, specialmente di giovani, che chiedono un giudizio sincero, ma è molto difficile darglielo, perché se mi azzardo a fare una qualche riserva del tipo: “Lei si deve ancora formare” oppure: “si sente ancora molto l’impronta del tale poeta” di solito l’autore si offende, il che mi dispiace, così come mi dispiace mentire».
Invece sarebbe interessante avere un parere.
«Certo, tutti dovremmo imparare a migliorarci scambiandoci pareri anche molto critici, ma una critica sincera suona spesso difficile da sopportare per chi le riceve. C’è il “pianoforte della vanità”, come lo chiamava Panzini, che “non è mai così scordato e muto sì che non mandi alcun suono”. È proprio vero, non c’è modo di farlo tacere del tutto, però è possibile, col tempo, mettergli la sordina e usare il pedale. Oggi, ad esempio, vengono diffusi strumenti comunicativi “istantanei” e il tempo è così veloce che viene schiacciato, non lo si considera più. Penso alle e-mail e agli sms, al “tempo reale”, ma quale è il tempo reale della vera comunicazione? È come per il vino, il mosto si deve decantare con lentezza, e la lentezza ci vuole. Paul Valéry ha scritto L’elogio della lentezza, ora c’è la moda dello slow food, ma il tempo resta veramente parcellizzato e non olistico. Adesso, pare, hanno scoperto i neutrini ed è andato in crisi anche il limite della velocità della luce. Ho scritto una poesia sui neutrini, una metafora un po’ scherzosa e un po’ seria, però sentivo di affrontare questo argomento; è forte la nostra presunzione di toccare e superare la frontiera scientifica dello scibile. Pensavamo di aver capito tutto, o quasi dell’universo con la teoria della relatività … I neutrini per me sono la metafora dell’imponderabile, di quello che ci sorprende, ci meraviglia, ci spiazza, e li ho ritratti come i folletti delle fiabe romantiche. Forse i poeti sono rimasti meno sorpresi degli scienziati da questa scoperta. Poi c’è anche da dire che l’Italia possiede doni di straordinaria bellezza, specialmente nel campo dell’arte, che vengono dall’“anima fanciulla”, dalla meraviglia platonica, ma non ha mai raggiunto la maturità storico-politica, è anche un paese molto “dimenticone”, che rimuove la memoria storica; l’abbiamo persa troppo a lungo, adesso è necessaria una rinascita fondata sulla consapevolezza civile e interiore. Siamo un paese vecchio, come vecchia è l’Europa, per questo dovremmo essere dei nonni più saggi e credibili, invece che essere dei nonni farseschi, che si truccano e si comportano da adolescenti, da Pierini infatuati e menefreghisti».
Oggi va di moda l’adolescenzialità.
«Si tratta di un mito che viene da lontano, è il mito dell’eterna giovinezza e del ringiovanimento che dal Romanticismo europeo in poi, specialmente col Werchter e il Faust di Goethe, diventato dominante nella cultura europea soppiantando la figura classica e medievale del vecchio saggio, portatore di memoria personale e collettiva; ha prevalso il fascino dionisiaco della gioventù, del futuribile, del “blé en herbe” come lo chiamava Colette (e pensi poi alla Lolita di Nabokov). Negli ultimi decenni questo mito è degenerato nelle forme spicciole, omologanti e spesso grottesche, della chirurgia plastica».
La metafora di Pasolini, “vecchi ruderi di cui nessuno conosce …”, è proprio questo uno dei problemi. Il rudere è anche il vecchio artigiano?
«Il vecchio artigiano non è un rudere né un mito o una metafore romantica, è un basamento su cui continuare a costruire creativamente, unendo tradizione e invenzione. Io sono felice di provenire da una famiglia di artigiani. Mio padre era un artigiano del legno, un restauratore-artista del mobile, mio fratello è stato un famoso restauratore di quadri antichi: ha restaurato alcuni dei capolavori assoluti della pittura».
Lei è stata ragazza di bottega?
«Non non ne avevo l’attitudine, il mio centro di gravità è sempre stato nelle parole, ma ne sentivo il fascino estetico. Quando ero bambina andavo nella bottega di mio padre, un antico stanzone-falegnameria, guardavo quello che faceva e mi piacevano l’odore del legno, gli intarsi. Un lavoro paziente, silenzioso, creativo, che solo dopo decenni ho collegato alla scrittura e alla traduzione. Mio padre alcuni mobili non li vendeva proprio, “con tutto il tempo che ho impiegato per costrurli”, diceva, “che prezzo dovrei chiedere?” Erano come un libro di poesia, un pezzo musicale, una bella traduzione, un quadro riuscito, come tutte quelle cose che richiedono un tempo e un’abilità non quantificabile. Della bottega di mio padre ricordo con intensità i trucioli, le spirali leggere del legno piallato. Quando ero piccola, disegnavo sempre spirali. E anche quando mio padre mi portava dei pezzetti di legno, io ci disegnavo sopra spirali col lapis copiativo. Era proprio una forma cosmica, primordiale, dell’ inconscio collettivo direbbe Jung; una forma che mi affascinava e che nessuno mi aveva mai mostrato».
E il suono?
«Il suono è il fondamento del mondo, e le arti sono tutte sorelle, sono variazioni sul tema, personificate in età classica nelle nove Muse. Le Muse sono come altrettanti dialetti della stessa lingua primigenia. La pittura ha un ritmo, così come la musica ha un colore. Il suono primordiale ricordato anche nelle Sacre Scritture, l’Om, o il Logod, fa nascere il mondo, è il Big Bang fisico e simbolico che crea le forme dell’essere e le rifrange in variazioni innumerevoli».
È strano che lei, poetessa, scrittrice, traduttrice, ci stia parlando di suono. Abbiamo incontrato musicisti che per spiegarci il suono ci hanno fatto l’esempio di un libro. Dicono che suonare, imparare a suonare, è come leggere un libro perché anche il musicista si esprime per frasi.
«Il principio della traduzione di cui parlavamo, è appunto questo; trovare una frase, una musica equivalente all’originale, una musica verbale ed interiore. Lo stesso vale per la poesia, che nasce da una o più “voci di dentro” che si esprimono in immagini ritmiche. Il libro poi, è una metafora ricorrente in tutti i miti di creazione; penso in particolare al Corano islamico, ma anche al topos interculturale del “libro della vita”».
Difficilmente si incontrano professionisti che sentono l’esigenza di trarre ispirazione da altri contesti. Quando parlo di queste cose ai miei allievi è come se cadessero dalle nuvole, perché sono talmente standardizzati sul concetto di sapere scolastico che lasciano veramente poche vie all’imprevedibile.
«Certo, il sistema scolastico, come qualunque “indottrinamento” o acculturazione, può creare gabbie mentali, perdita di fantasia creativa e fissazione di stereotipi, di un’erudizione “a compartimenti stagni”, o frtettolosamente integrata da Internet e dal suo fast food planetario, dove inevitabilmente la quantità abbassa la qualità del sapere, una volta elitario. Anche l’Università è diventata una sorta di super-liceo per effetto della cultura tecnologica di massa. Ma gli allievi migliori – magari supportati dai punti di eccellenza ancora esistenti in Italia, e più all’estero, trovano e troveranno sempre in sé il desiderio e il bisogno di ampliare i loro orizzonti in senso multidisciplinare, interculturale. La realtà contemporane sembra drammatica, distruttiva ed autodistruttiva, ed in buona misura lo è, ma se si leggono i papiri egizi, le testimonianze degli scribi denunciavano la decadenza dei costumi etici e socili e la crescita della corruzione rispetto ai tempi antichi. Il sentimento della decadenza è una costante, perché nel profondo di noi vive il mito dell’età dell’oro, dell’Eden perduto. Per quanto mi riguarda, sento veri i cicli, i “corsi e ricorsi” di Vico, e poi di Nietzsche , per cui le realtà ritornano, anche se in una forma storica e con immagine diversa. Anche Pasolini percepiva questo. Il mito positivista dell’infinito progresso e possesso ha favorito le scoperte scientifiche, ma ci stà portando a distruggere la Madre Terra, il pianeta. Tuttavia stiamo assistendo ad una crescita della coscienza individuale. Stiamo lentamente acquisendo la consapevolezza, anche interiore, della nostra violenza distruttiva, ma è difficile acquisire un livello di coscienza globale, perché il nostro mondo è come un’eterna scuola con tante classi, e, a parte una certa quantità di analfabeti, refrattari agli input educativi, ci sono tante classi: gli studenti di prima elementare ci saranno sempre, ed ovviamente non hanno la stessa preparazione degli studenti di quinta liceo che pure ci saranno sempre, così come i professori cioè i maestri spirituali. Lo spirito delle nazioni, che i romantici avevano identificato, e lo spirito delle lingue indubbiamente esistono ed operano, come l’inconscio collettivo, ma non sono unitari, quindi non si può dire, in linea di massima, che una nazione sia più civile di un’altra, e poi anche nelle società più evolute ci sono sempre delle sacche di ignoranza e di pregiudizi, dei rigurgiti di barbarie, di “proiezioni sul nemico”, come ad esempio di razzismo, il nazionalismo intollerante e il sessismo, che si verificano continuamente in tutto il mondo. La democrazia, anche interiore, è un’acquisizione difficile e precaria, come la cima di una piramide».
Come si può sfuggire a questa forma di realtà che incasella, standardizza, che toglie il tempo, che impoverisce nella sua essenza ogni soggetto, anche se ovviamente il soggetto ci mette del suo?
«Penso che la capacità di sottrarsi alla standardizzazione sia un dono, oltre che una volontà. Ci sono molti giovani, e meno giovani, motivati e profondi, di ottima caratura morale. Il rischio comunque è quello di sfuggire ad uno stereotipo cadendo in un altro, magari quello dell’“alternativo” o del diversamente consumista. È sempre necessario, secondo me (cito ancora da Ungaretti) che “il vero poeta aneli a chiarezza”) e non solo il poeta e l’artista, ma ogni essere umano degno di chiamarsi tale: cercare di fare chiarezza dentro se stessi, di capire di che cosa si ha bisogno veramente, perché spesso si è ingannati da falsi desideri, “immagini di ben seguendo false” dice Dante; sono queste che l’omologazione incrementa e sfrutta».
Il desiderio confuso con il consumo …
«Sì, il desiderio indotto di cose, di oggetti che rassicurano, che fanno sognare i sogni degli altri, e non i propri, “distraggono” in senso etimologico, portano a smarrire l’identità, a “perdere l’anima” pur di identificarsi col gruppo socialmente prevalente. Ci vuole il coraggio di sentirsi “eretici”, e magari socialmente soli, ma uniti alle forze naturali e creaturali, e agli amici elettivamente affini; una condizione che personalmente, essendo introversa e nata sotto il segno dei Gemelli, ho accettato da quando è iniziata la mia vita cosciente, facendone un elemento portante della mia poetica: l’ho chiamata Solitudine corale.
“La solitudine corale, mia,
come l’aria mi nutre e mi traversa
senza vedermi – onda di creature
dai sonanti colori m’accompagna al mio seggio
di silenziosa fiamma necessaria:
dell’empirea rosa testimone dispersa,
ho l’unisono senza l’umana compagnia”[1].
Ma bisogna dire che ogni “creativo” (non nel senso corrente e modaiolo del termine), ognuno di noi è veramente molto isolato, considerando che oggi non ci sono più i salotti letterari, quelli deprecati da Pasolini, i salotti borghesi che però, quantomeno erano ancora una forma decaduta e familistica di agorà, di cenacolo, di incontro. Anche i caffè letterari adesso sono scomparsi e le chat non valgono a sostituirli. Ma la solitudine di cui parlavo non è mai tale, perché ha sempre una tensione all’ascolto, è collegata in senso etimologico. Come diceva la Mansfield, parafrasando Van Gogh: “[Voglio] inchiodare l’orecchio alla porta per sentire la voce di chi è fuori”».
Lei come è riuscita a sfuggire alla trappola dell’omologazione?
«Non è detto che sia sfuggita pienamente, i confini dell’omologazione sono sfuggenti; come le dicevo, ho cercato per istinto la compagnia e la voce dei grandi poeti. Sono stata sempre un po’ extravagante in senso sociale e scolastico. Al liceo leggevo Baudelaire e i Simbolisti russi sotto il banco, durante le ore di matematica o di trigonometria (il mio spauracchio!). Soltanto dopo, attraverso i pitagorici, ho capito qualcosa dei fondamenti fisosofici della matematica. Ero un po’ uno scandalo buffo per i miei compagni di classe, mi guardavano con una diffidenza ironica che mi faceva soffrire. Il mio professore di lettere, che amavo, quando lo incontro mi ricorda che talvolta scrivevo le mie poesie sul muro accanto al mio banco; avevo un amore smisurato per la poesia e la letteratura europea, e nelle vacanze estive spesso andavo in campagna in bicicletta, mi arrampicavo su un ulivo e leggevo per ore i poeti che via via scoprivo invece al mare, nell’estate del 1964, ho letto d’un fiato la Recherce di Proust. Allora ero letteralmente drogata di letteratura, quello per me era il mondo vero. Le altre droghe, quelle chimiche, per la mia generazione sono state una provocazione, una “contestazione” come si diceva allora, ma io non ne ho mai sentito il bisogno. Ora il consumo di sostanze stupefacenti mi pare più meccanico, più disperato, e non ideologico come accadeva allora; purtroppo è diventato ancora più precoce. A me pare impossibile che dei genitori pur alienati dal lavoro, non si accorgano che i figli fanno uso di sostanze stupefacenti. C’ un vuoto di ordine etico che dovrebbe essere colmato. So di usare paroloni: vocazione, ispirazione, etica! Anche Pasolini le usava, ed è andato ad insegnare ai ragazzini incolti del Friuli. Certo lui aveva delle motivazioni “romantiche”, vedeva il sottoproletariato come paradiso, anche sensuale; però la motivazione etica di un insegnante deve venire prima e nonostante tutto, altrimenti manca a se stesso. È vero che in Italia, specialmente nell’ultimo ventennio, si è fatto e si fa di tutto per demotivare i giovani e gli insegnanti col precariato, è stato screditato ogni valore e prestigio alla cultura, in particolare a quella umanistica, ma anche alla vera ricerca scientifica, togliendole i fondi necessari, e incoraggiando un iper-tecnologismo passivo, massificato, furbesco. Ma l’anima ha bisogno di nutrimento. Ha notato che anche i papi non parlano quasi più dell’anima? Quindi dell’anima parlano solo gli artisti con i loro strumenti, ed anche gli educatori: anche quella è tuttavia un’arte, difficile e socratica.
Lei ha detto prima di non aver mai incontrato un maestro. Pensa che sarebbe cambiata la sua vita se ne avesse avuto uno?
«Forse no. Probabilmente avrei avuto un imprinting più “personalizzato”, come l’hanno avuto ad esempio gli allievi di Longhi o di De Robertis; poi però, essendo parecchio individualista, anche per l’eredità familiare artigiana, penso che presto sarei andata per la mia strada, anche se devo ammettere di avere una certa nostalgia sentimentale per padri, madri e maestri, soprattutto spirituali».
E lei adesso, da maestro, ha discepoli?
«Non mi sento un maestro, mi sento un poeta-madre (e ormai felicemente nonna). Non credo di avere discepoli. Ho degli amici giovani, e degli ex allievi che ogni tanto vengono a trovarmi, mi scrivono. Qualcuno è diventato uno scrittore o uno studioso, mi manda i suoi lavori, ed ho vari amici artisti anche loro giovani, con cui ho molto feeling, la loro bravura, il loro entusiasmo ed affetto mi nutrono molto e con loro mi è più facile collaborare rispetto ai miei coetanei».
Ci parli ancora della sua spinta interiore quando era ragazzina. Il suo desiderio di leggere, di conoscere, la sua curiosità…
«Già da bambina, a tre anni, raccoglievo i fogli che trovavo per terra, dei pezzi di giornale, non sapevo leggere, però ne ero attratta, sentivo che lì c’era “qualcosa”. Era un amore istintivo, una passione per un regno che ancora non conoscevo, ma sapevo che c’era e che io dovevo entrare lì, nelle parole, dovevo leggerle e scriverle. Poi non ho più smesso di farlo, con qualunque testo mi capitasse. In casa mia non c’erano molti libri, ma c’era La divina Commedia, in una edizione degli anni Trenta, quindi a dieci anni mi misi a leggere Dante, non capendo quasi niente sul piano intellettuale, ma rimanendo incantata dalle immagini, dalle rime, dal suono. Insomma è stata subito una passione, io non la definirei curiosità, né ambizione. In un tema di quinta elementare scrissi – si trattava di uno dei temi allora obbligati del tipo “cosa volete fare da grandi” – io scrissi che volevo “fare la carriera della poetessa”; allora credevo ingenuamente che fosse una carriera, però era ciò che volevo e che sentivo di dover fare. Non avrei potuto fare nient’altro. Poi certamente mi sono resa conto che che carmina non dant panem e quindi c’è stato l’insegnamento, qualche supplenza alle superiori e poi l’Università.
Ora non sono più addicted ai libri, il vino si è decantato, a sua volta, e la vita mi è venuta incontro in tutti i suoi aspetti, ma quella vocazione, quel bisogno fisiologico è rimasto intatto, si è arricchito qualitativamente. Anche i vostri ragazzi, credo che troveranno la via per esprimere la loro personale “arte”».
Spesso questa sensibilità innata è anestetizzata anche da feticci tipo playstation, giochi virtuali, computer. Questi sono muri.
«È vero, possono essere droghe facili…Lo stesso uso del computer ha comportato la conseguenza che molti ragazzi non sanno più scrivere a mano oconversare. Io ho la sventura, che per me è stata la provvida sventura di Manzoni, di non poter usare il computer per ragioni di vista, ma questo handicap non nuoce all’ispirazione, anzi. Ho sempre scritto tutto a mano, e scrivere a mano le poesie comporta un contatto fisico, per me prezioso, con la penna e con la carta, quindi con l’albero e con la natura. L’uso del computer (certo utilissimo) ha comportato però anche la perdita della variantistica letteraria, che era preziosa per gli studiosi e per i lettori attenti: penso alle varianti molto significative delle poesie di Leopardi o di Montale, su cui si tenevano interi corsi. La grafia, le cancellature, tutto era significativo, come nelle vecchie lettere, sostituite dalle più sbrigative e mails. Dopo la versione a mano io copio e modifico ancora a macchina, ne ho una elettrica, ma ho dei problemi per trovare i nastri in via di esaurimento. Il mio è un lavoro di antico artigianato, di scriba arcaico in via di estinzione. Comunque non mi scoraggio. Anche Pasolini continuava a scrivere, sempre affermando che non c’era via d’uscita dalla morte della poesia… Poi mio marito, pazientemente scannerizza e digitalizza tutto.».
Mai arrendersi…
«Appunto. Penso a Gorgia e ai sofisti, che tenevano discorsi sulla necessità di non parlare. Tutto il nostro lavoro è paradossale, è basato sugli ossimori, come la vita. Un lavoro à rebours, in direzione contraria all’attuale “aziendalizzazione” e mercificazione di tutto, compresa l’Università e la scuola, dove fumosi giudizi avevano sostituito i voti, che ora hanno dovuto reintrodurre. È importantenon essere complici in questo processo , o esserlo il meno possibile. Simone Weil diceva :“Non mentire, non essere complici, non restare ciechi”. Certo questa fedeltà si paga, tutto questo si paga in termini di emarginazione mondana, di solitudine, come ho già detto, però il compenso è alto qualitativamente, sia per l’autostima e per la propria interiorità, per la propria libera “autocostruzione”, sia sul piano della stima e dell’affetto dei ragazzi, quando si è insegnanti».
Io vedo che le persone non si amano
«Spesso non riescono a farlo perché si disprezzano, non hanno autostima, provengono magari da famiglie anaffettive dove non c’è amore, né valori, né rispetto. Anche la nostra società non aiuta nel dare prospettive, nell’offrire un futuro, non solo ai giovani, ma anche a persone in età che magari perdono il lavoro e che si sentono “rottamati”, e comprensibilmente cadono nella disperazione. Ogni persona è un cosmo complesso, e le cause del non-amore possono avere molte e differenti configurazioni. La condizione umana è assai imperfetta, però Rita Levi Montalcini ha scritto il famoso e combattivo Elogio dell’imperfezione… Magari arriveremo a centodue anni come lei, elogiando l’imperfezione, ma amando la perfezione».
Una curiosità: la poesia su Wittgenstein?…
«Io non sono una filosofa, anche se la mia poesia è stata definita “pensante”, e non capisco granché di logica. La lirica su Wittgenstein cerca di restituire metaforicamente l’elemento ascetico che c’è nei suoi scritti, la sua forma filosofica di “misticismo” implicito, che io avverto fortmente e che mi affascina. Avverto che il Tractatus, al di là della sua importanza “tecnica”, è molto bello, anche se lo capisco poco più di quanto capivo Dante a dieci anni, è bello per la sua ricerca di verità e di assoluto, al di la della credenza, della doxa».
Se non ricordo male lo ha composto prevalentemente sul fronte, durante la prima Guerra Mondiale.
«Le cose fondamentali e importanti, spesso si scrivono in condizioni estreme, di pericolo, di precarietà assoluta. Anche Ungaretti ha scritto L’Allegria sul Carso».
E lei ha un autore preferito?
«Sarebbero troppi da elencare, è una scelta impossibile: da Platone a Dante, ai mistici sufi da Shakespeare e gli elisabettiani a tutti i classici, fino ai grandi del Novecento Proust e Kafka, un po’ meno Musil e Joyce, Oscar Wilde e i modernisti, i simbolisti russi… Anche gli scrittori mitteleuropei, Kraus e in particolare Canetti, che è stato uno degli autori della mia autoformazione: Massa e Potere, l’Autobiografia e il suo straordinario romanzo Die Wendlung, il cui titolo in italiano è stato tradotto malamente con Autodafé. Canetti è uno scrittore nutriente, quando morì fui molto colpita dalla notizia, mi ricordo che mi trovavo a Londra, sono andata a sedermi in un giardino ed ho scritto una poesia in sua memoria, Per Elias».
Non esiste solo il contemporaneo, è vero…
«Il concetto di contemporaneità è falso e contingente. Io Omero e Sofocle li sento molto contemporanei, contemporanei sono tutti i grandi, ma anche i meno grandi, tutti quelli che contribuiscono allo sviluppo della coscienza cosmica e personale. Il tempo è una dimensione interiore, come Agostino ci ha insegnato precedendo Einstein e il suo spazio curvo. Il nostro tempo umano è un atomo nel cosmo, quello degli animali un altro atomo, quello delle piante un altro ancora, per non parlare di quello dei sistemi stellari, e tutti insieme facciamo parte di un cosmo che è armonia e bellezza. Non dobbiamo sentirsi schiacciati dal presente storico: il “contemporaneo” passerà presto, come i secoli precedenti, come noi. Mitridate, re del Ponto, aveva un anello su cui era scritto “anche questo passerà”, è un aneddoto famoso. Certo nella nostra dimensione c’è il tempo specifico, e ci sono le occasioni, le scelte da fare , i dubbi… Però ce lo dice la voce interiore, il nostro daimon, qual è la nostra strada, la voce interiore magari incarnata in una persona. Non c’è da aver troppa paura, un po’ sì, ma ragionata. La vita stessa ci guida, la “madre vita” ci dà segnali, ci fa incontrare in un certo momento una certa persona, un messaggio, una situazione, un libro. I greci lo chiamavano il kairós. Ci vuole attenzione, bisogna essere ricettivi e contraccambiare, lavorando su se stessi, fino a diventare chi siamo e chi saremo».
E il cliché del poeta?
«Genio e follia? È un cliché romantico, uno stereotipo, e per crescere bisogna sgombrare la mente dagli stereotipi. Certo il più famoso dei maudits, Baudelaire, ha vissuto in un certo contesto, il decadentismo francese, ed è un grande poeta che faceva uso di droghe, come del resto Coleridge, De Quincey, e poi nel Novecento Artaud o Trakl… Fra l’altro Baudelaire , come molti grandi, come Rilke, è un poeta intraducibile, l’ho già detto. Le traduzioni delle sue poesie sono tutte insoddisfacenti: è impossibile riprodurre il ritmo solenne e le forme chiuse de Le Fleurs du Mal. Qualche traduttore ha usato la prosa ritmica, o i versi sciolti, i più coraggiosi hanno tentato di rifare il suo sonetto, ma secondo me non con grande resa. Io ho rinunciato a priori, ed anche questa è una forma di omaggio».
Trasgredire?
«Non c’è più nulla da trasgredire…nel senso che, come si è detto prima, nulla fa più scandalo; ormai si possono fare solo piccole variazioni sul tema per smania di protagonismo mediatico. La mia forma di trasgressione è sempre stata, per carattere, per destino, “lavorare zitti”, come diceva Giovanni Boine, uno scrittore legato al gruppo della “Riviera ligure”, morto tisico a trent’anni nel 1918, un critico di istinto e di stile formidabile, un modernista nostrano, come del resto molti dei cosiddetti “vociani”. Certo chi è estroverso, esibizionista ed è incline al protagonismo, non può lavorare zitto. Per me è naturale, caratteriale appunto. Ho insegnato per trentacinque anni, però ogni volta che salivo in cattedra dovevo fare una certa violenza a me stessa, e tuttora quando parlo in pubblico».
Che bello!
«No, non tanto. Il lavoro da fare diventa doppio».
I musicisti dicono che se la paura del palco andasse via, non avrebbero più motivo di salirci
«Il palco di un musicista o di un attore è un po’ diverso da una cattedra, o dal tavolo di un Convegno, però ti senti comunque osservato, pesato, sezionato. È una sfida continua, ma può diventare una prova di umiltà, un dono di sé. Io non sono incline alle apparizioni mediatiche e neppure alle conferenze, pur avendone fatte molte ed avendo ricevuto molti premi e riconoscimenti. Ogni volta che devo salire su un palco lo sforzo rimane, ma mi consola credere che la forza sia appunto una somma di debolezze ben usate, compattate e sublimate, come direbbe Freud. Molti attori ed artisti, com’è noto, sono dei timidi assoluti. Il narcisimo, la vanità, sono una grande debolezza, al di la dell’apparenza; rendono vulnerabili al ricatto, all’adulazione, alla prostituzione intellettuale, alle delusioni e alle manie di grandezza. Questo non significa che non si debba avere autostima: come sempre, in medio stat virtus».
[1]
[1] M. Del Serra, L’opera del vento. Poesie 1965 – 2005, Marsilio, Venezia 2006, p. 131.
MAURA DEL SERRA
È nata il 2 Giugno del 1948. Ha una figlia e due nipotini. Sostiene le cause per la difesa delle libertà della persona umana ed è attiva anche in iniziative ambientaliste e per la difesa degli animali. Ha pubblicato nove raccolte poetiche, l’antologia Corale. Ha dedicato volumi critici a Dino Campana, Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti, Clemente Rebora, Piero Jahier, Margherita Guidacci e saggi a numerosi poeti e scrittori italiani ed europei.
Ha curato alcune antologie, fra le quali: Kore. Iniziazioni femminili. Antologia di racconti contemporanei, Firenze, Le Lettere, 1997; Margherita Guidacci, Le poesie, Firenze, Le Lettere, 1999; Egle Marini. La parola scolpita, Pistoia; Artout, Maschietto e Musolino, 2001; Poesia e lavoro nella cultura occidentale, Roma, Edizione del Giano, 2007.
Ha pubblicato venti testi teatrali e fra gli autori da lei tradotti dal latino, tedesco, inglese, francese e spagnolo: Quinto Tullio Cicerone, William Shakespeare, George Herbert, Francis Thompson, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Dorothy Parker, Rabindranath Tagore, Marcel Proust, Simone Weil, Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges.
Per la sua attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, fra i quali: il premio “Montale” per la poesia, il premio “Flaiano” per il teatro e il premio “Betocchi” per la traduzione.
Nell’anno 2000 le è stato assegnato il premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri.


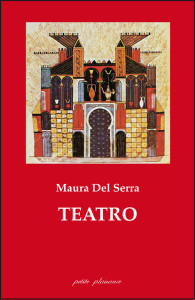
Il teatro di Maura Del Serra, qui riunito nella molteplice complessità del suo arco cronologico trentennale, abbraccia una pluralità di forme sceniche, ora corali ora dialogiche ora monologanti, che spaziano con incisiva e vivace profondità dall’“affresco” epocale alla fulminea microcellula drammatica e a forme singolari di teatro-danza sempre sorrette da un inventivo simbolismo di luci, colori, voci fuoriscena e suggestioni scenografiche. L’organon di questa scrittura – in versi e in prosa – fonde il nitore visionario con un senso vivace e concreto del phatos quotidiano, spesso nutrito da uno humour tipicamente affidato a personaggi “terrestri” fino al farsesco, secondo la tradizione della commedia antica. Il teatro decisamente anti-minimalista della Del Serra mostra infatti il suo grato debito creativo verso i classici della tradizione drammaturgica e poetico-letteraria europea, dai tragici e lirici greci al barocco inglese e ispanico, al decandentismo e alle avanguardie artistiche del Novecento.
I suoi personaggi, a vario titolo esemplari fino all’archetipo, sono scolpiti e dominati da una solitudine “eroica” non astratta bensì coerentemente testimoniale, tormentati e salvati dalla grandezza antistorica e metastorica del loro dono “eretico” che si oppone geneticamente alla forza oppressiva del potere nelle sue varie espressioni, da quelle canoniche politico-sociali a quelle suasive dell’intelletto, fino a quelle della “sapienza senza nome” della vita. Ed è perciò sempre agonico il rapporto fra la certezza di una verità ultima e inattingibile e l’illusione soggettiva, mediante l’utopia salvifica affidata all’ardore dei protagonisti. Motore e forma privilegiata di queste compresenze è l’eros generatore e multiforme, espresso in tutte le sue pulsioni, dall’amicizia alle polarità maschili e femminili, fino ad una complessa androginia psicologica e spirituale.
In questa straordinaria galleria evocativa di presenze, che spaziano dall’ellenismo alla contemporaneità al futuro, le voci interiori dell’autrice si incarnano di volta in volta, come la poesia ed ogni arte, per “sognare la verità del mondo”.
***********************************************
Seguici sul sito web
 ***********************************************
***********************************************