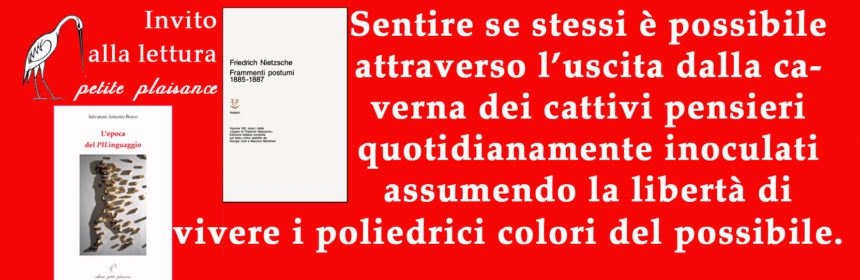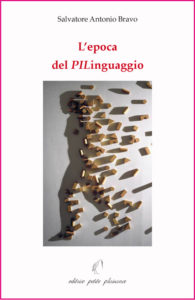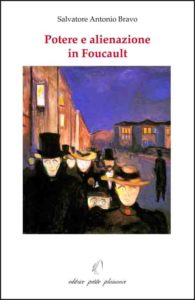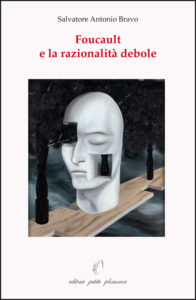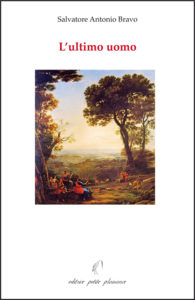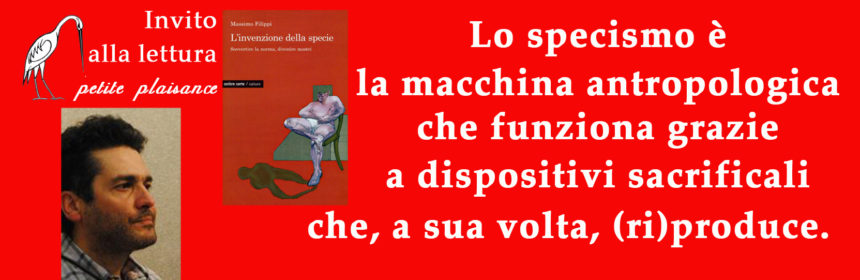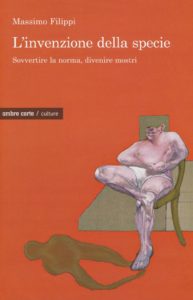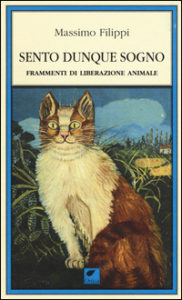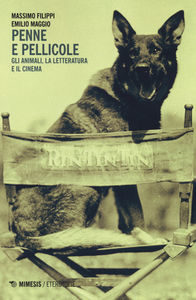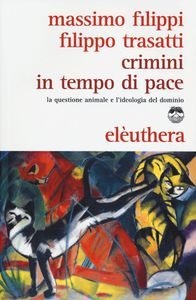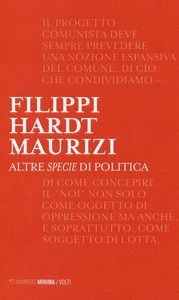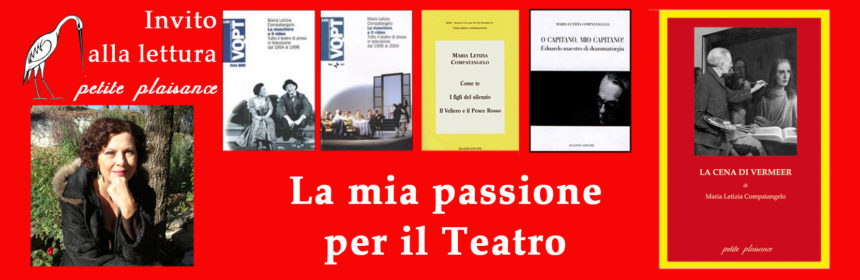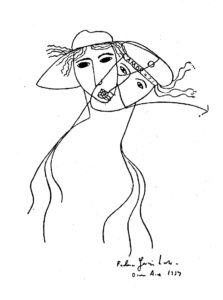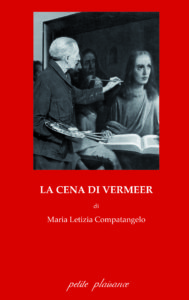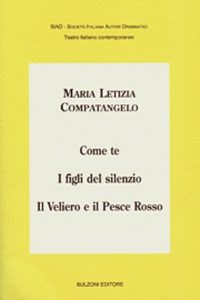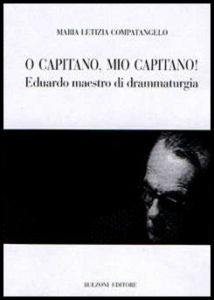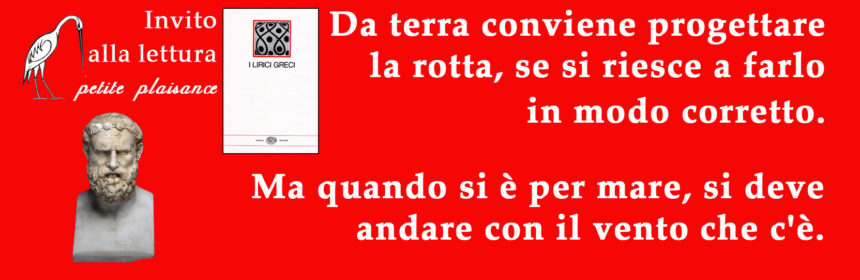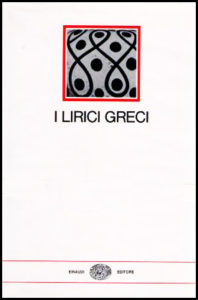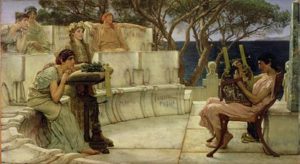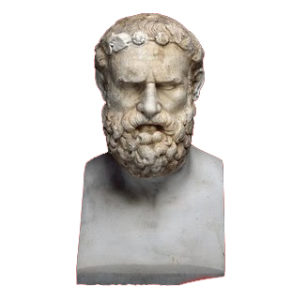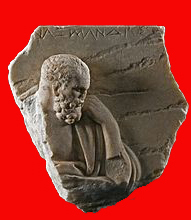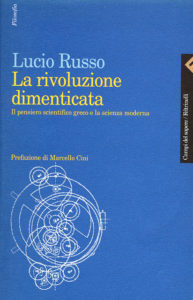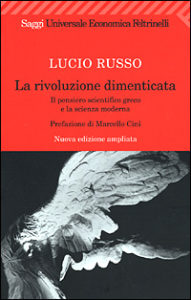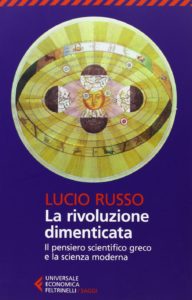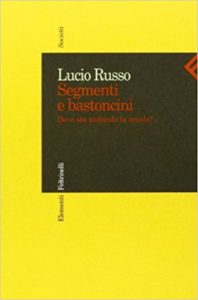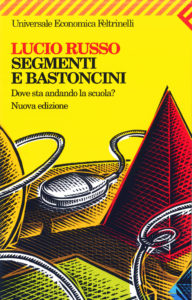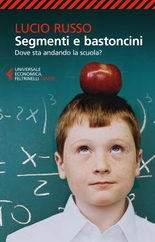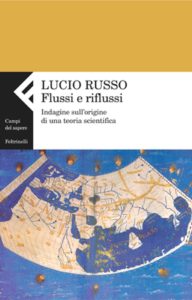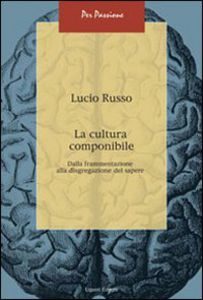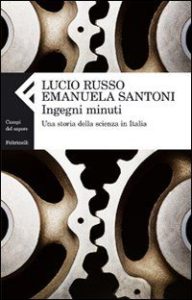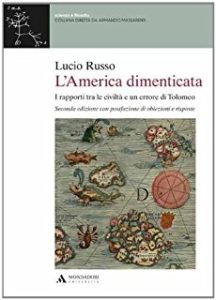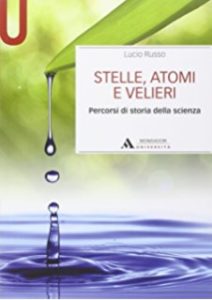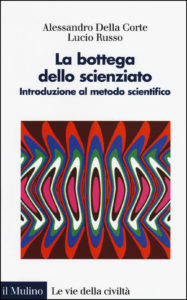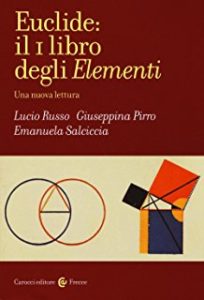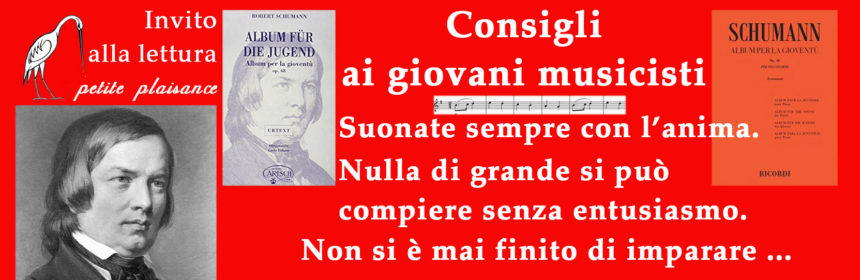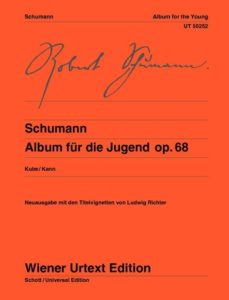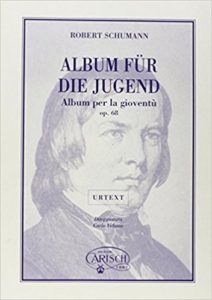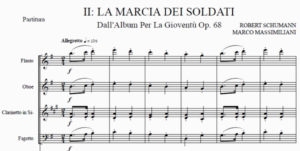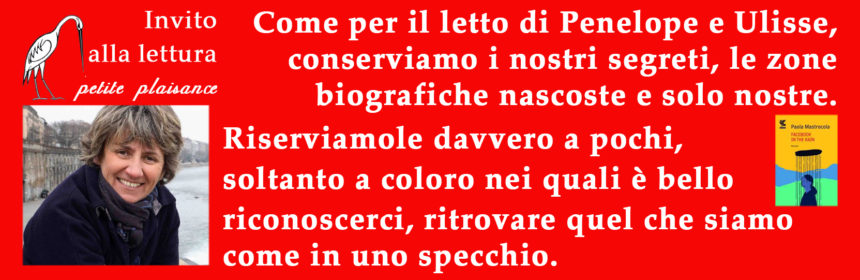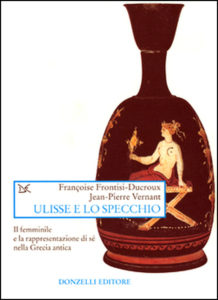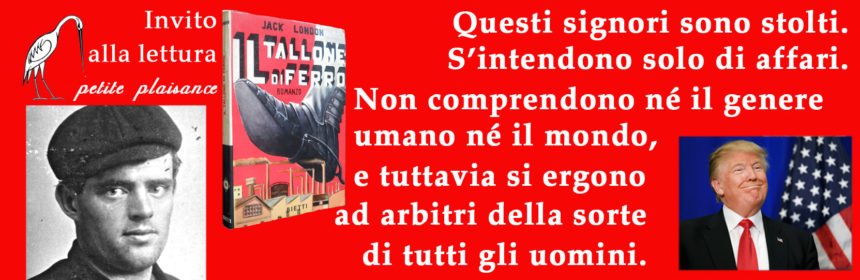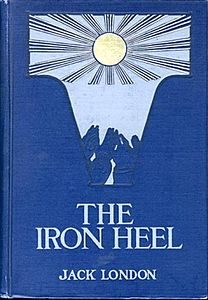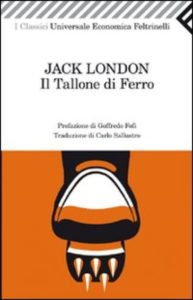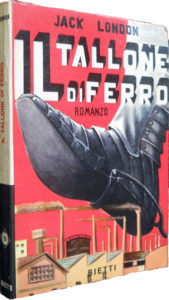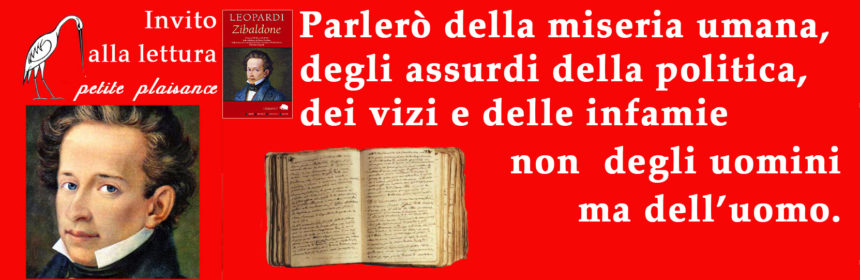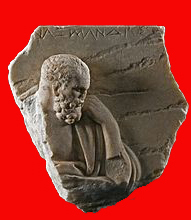
Anassimandro
«Il primo mito consiste nell’idea diffusa che la scienza nasca essenzialmente nel XVII secolo, come se i suoi precedenti nella cultura antica fossero trascurabili. Poiché la scienza rinacque in epoca moderna dallo studio degli antichi trattati recuperati, ignorare il rapporto tra gli scienziati della prima età moderna e le loro fonti ellenistiche impedisce di cogliere l’origine delle idee degli scienziati moderni, che appaiono misteriose e immotivate. Il secondo mito attribuisce gli sviluppi della scienza a una disinteressata ricerca della “Verità”, recidendo il rapporto, che è stato quasi sempre essenziale, tra gli sviluppi teorici e l’esigenza di risolvere problemi di interesse pratico. Il terzo consiste nell’attribuire a pochi geni isolati quasi tutti i risultati scientifici, che il più delle volte sono invece dovuti a un complesso lavoro collettivo. Da alcuni decenni è spesso citata una legge (attribuita a vari autori) secondo la quale, quando una scoperta scientifica è citata con il nome di uno scienziato, l’unica cosa certa è che non si tratta del vero scopritore».
Lucio Russo, intervista pubblicata in Math is in the air, 4 settembre, 2016.
I LIBRI DI LUCIO RUSSO
———————————————————
La rivoluzione dimenticata, Feltrinelli, 1996.
La scienza moderna non nasce con Galileo e Newton. Le sue origini vanno retrodatate di almeno 2000 anni, alla fine del IV sec. a.C. La Rivoluzione scientifica del XVIII sec. riscopre la Rivoluzione ellenistica di figure come Euclide, Archimede, Erarstotene, Aristarco di Samo e di tanti altri raffinati scienziati. Lo studio della “rivoluzione scientifica”, cioè della nascita dello sviluppo scientifico, è indispensabile per la comprensione della “civiltà classica”. Inoltre, l’esame del ruolo svolto dalla scienza nella civiltà ellenistica è essenziale per la valutazione di alcune questioni di capitale importanza per la storiografia, dal ruolo di Roma alla decadenza tecnologica medievale alla “rinascita scientifica” moderna.
****
Segmenti e bastoncini, Feltrinelli, 1998, 2000.
Agli insegnanti che sentono il loro ruolo fondamentale per la formazione di futuri cittadini liberi, ai genitori che sperano che i propri figli acquisiscano delle competenze nel lavoro scolastico, va detto chiaro e netto che la scuola come continua a essere immaginata nella riforma scolastica oggi in corso va in tutt’altra direzione. La riforma, secondo Lucio Russo, allinea la scuola italiana agli standard americani, abbassa i livelli di competenza reale, esclude la trasmissione degli strumenti essenziali alla creazione di nuovo sapere, rende l’insegnamento sempre più generico. Segmenti e bastoncini ha suscitato polemiche, consensi e condanne, ma soprattutto un largo dibattito che dalla stampa si è esteso nella scuola, ed è destinato a continuare.
***
Scienza, cultura, filosofia, CRT, 2002.
***
Flussi e riflussi: indagine sull’origine di una teoria scientifica, Feltrinelli, 2003.
Questo piccolo libro ricostruisce per la prima volta nella sua interezza la storia della scoperta della teoria astronomica delle maree. Si tratta di un caso esemplare di mancata trasmissione delle conoscenze, dovuto in gran parte a una comunità scientifica – quella romana e medievale – che, sotto l’influsso di una cultura dominante avversa, aveva finito col perdere le capacità di padroneggiare certi risultati scientifici. Oggi nei manuali standard la prima formulazione della teoria viene attribuita a Newton, il quale ne diede la versione completa nei Principia mathematica, unitamente alle leggi sulla gravitazione universale. Questa attribuzione però è errata, come dimostra Lucio Russo, non solo perché a essa avevano contribuito molti altri studiosi, che avevano preceduto Newton, ma soprattutto perché, già nella Grecia ellenistica, Eratostene e Seleuco, basandosi su una serie di osservazioni rese possibili dall’espandersi delle esplorazioni navali, ne avevano dato una descrizione completa e “moderna”. Ci troviamo dunque in presenza di una vicenda ricca di spunti di riflessione. Paradigmatico è il modo in cui la teoria greca era caduta nell’oblio, sopravvivendo in maniera frammentaria e dispersa. Paradigmatico il modo in cui da questi frammenti sparsi fu poi possibile rigenerarla. Paradigmatico il modo in cui più personalità vi lavorarono, aggiungendo tassello a tassello fino ad arrivare a quell’uno – Newton appunto – che poté apporre la sua firma alla scoperta. La ricostruzione di Russo è condotta attraverso l’esame di documenti originali e indiziari, incrociando testimonianze provenienti da ambiti diversi, con un metodo quasi “poliziesco” che partendo dal diciassettesimo secolo ripercorre a ritroso la vicenda fino alle sue lontante origini nel secondo e terzo secolo a.C.
***
La cultura componibile. Dalla frammentazione alla disgregazione del sapere, Liguori, 2008.
l libretto contiene una riflessione, basata anche su ricordi personali relativi a un complesso itinerario culturale, sulla necessità di superare lo specialismo per tentare di costruire un generalismo che eviti la superficialità e, allo stesso tempo, sulle difficoltà incontrate da chi si pone oggi un tale obiettivo. Il superamento dei confini disciplinari, che è spesso essenziale anche per risolvere problemi sorti all’interno di singoli settori ed è inevitabile da parte di chi svolge un lavoro intellettuale con passione, richiede infatti non solo l’impiego di molte energie intellettuali, ma anche il superamento di ostacoli, oggettivi e soggettivi, creati dalle attuali strutture teoriche e organizzative del mondo della conoscenza. Il problema è illustrato descrivendo i rapporti, essenziali ma difficili, tra fisici e matematici, matematici puri e matematici applicati, storici della scienza e scienziati, filologi classici e storici della scienza antica. Ci si sofferma in particolare sui danni prodotti dalla crescente divaricazione tra scienza pura e applicata e dall’indebolimento della memoria storica degli scienziati. Si argomenta contro la pseudo-soluzione, sempre riproposta, di creare nuove specializzazioni negli interstizi di quelle esistenti. Il superamento di un angusto specialismo è reso sempre più arduo non solo dalla crescita esponenziale delle informazioni disponibili non accompagnata da una crescita altrettanto veloce di nuove sintesi, ma anche dall’evoluzione del sistema educativo occidentale che, spostando la serietà degli studi a livelli sempre più elevati di età e di specializzazione, ha prodotto un continuo indebolimento della cultura generale condivisa. I problemi precedenti assumono particolari connotazioni (per lo più, ma non esclusivamente, negative) nella situazione italiana.
***
Archimede. Massimo genio dell’umanità, Canguro, 2009.
La collana “Gli iniziatori” è stata ideata per presentare i principali protagonisti della scienza a un pubblico di giovani lettori attraverso un appassionante racconto, nel quale s’intrecciano aspetti biografici, storici, letterari e autentici contenuti scientifici. Un modo semplice e accessibile a tutti per ripercorrere le principali tappe del progresso scientifico e comprendere la genesi di teorie innovative, destinate a cambiare per sempre la storia dell’umanità. Protagonista di questo volume è il genio poliedrico di Archimede, scienziato e inventore siracusano. Età di lettura: da 6 anni.
***
Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia, con E. Santoni, Feltrinelli, 2010.
Una sintesi dello sviluppo scientifico in Italia dal 1200 a oggi che propone tesi interpretative di carattere generale. La tradizione che a lungo ha emarginato la scienza da importanti settori della cultura italiana è bene esemplificata dall’epiteto “ingegni minuti”, attribuito ai cultori della scienza esatta da Giambattista Vico in un brano fatto proprio da Benedetto Croce. Quali sono le radici di questa tradizione e quali sono state le realtà culturali di diverso segno presenti nel paese? Qual è stato il contributo del Rinascimento italiano al sorgere della scienza europea? Perché, dopo i successi della scuola galileiana, la ricerca italiana entrò rapidamente in una profonda crisi? L’esame dei risultati degli scienziati risorgimentali può modificare, e come, il giudizio storico sul Risorgimento? Quali sono le cause della crisi in cui versa la ricerca scientifica italiana dagli anni ’70 del secolo scorso? La globalizzazione lascia spazio a politiche scientifiche nazionali o europee? Ecco alcune delle domande cui questo libro tenta di rispondere, intrecciando gli sviluppi scientifici con la storia economica e politica, oltre che culturale. È infatti convinzione degli autori non solo che la storia della scienza possa essere compresa solo esaminando i contesti che forniscono alle comunità scientifiche i problemi concreti da affrontare e le risorse, culturali e materiali, per risolverli, ma anche che la storia di un paese non possa prescindere dalla storia della sua ricerca scientifica.
***
L’America dimenticata. I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo, Mondadori, 2013.
La quasi totalità degli studiosi ha finora negato l’esistenza di antichi contatti tra l’America e il Vecchio Mondo, ma in questo libro, indagando su una questione apparentemente secondaria di storia della geografia (l’origine di un grossolano errore di Tolomeo), si dimostra che le fonti ellenistiche dell’antico geografo conoscevano latitudini e longitudini di località dell’America centrale. Questa scoperta costringe a rivedere sotto una nuova luce molti aspetti della storia. Da una parte mostra come il crollo delle conoscenze che investì il mondo mediterraneo all’atto della conquista romana sia stato ben più profondo di quanto in genere si creda. Dall’altra apre nuovi possibili scenari di lungo periodo, lasciando intravedere la possibilità di sostituire all’idea oggi dominante dell’evoluzione indipendente e parallela delle civiltà un’unica storia, connessa sin dalla remota antichità.
***
Stelle, atomi e velieri. Percorsi di storia della scienza, Mondadori, 2015.
La scienza è spesso vista come un metodo di indagine dei fenomeni naturali sviluppato per puri fini conoscitivi e tipico della modernità. In questo libro, ricostruendo la storia di lungo periodo di alcune idee scientifiche, si mostra come la storia della scienza sia comprensibile solo mettendo a fuoco la continuità tra scienza antica e moderna, e indagando il rapporto, spesso indiretto ma quasi sempre determinante, tra la ricerca “teorica” e l’esigenza di risolvere problemi concreti. Lo studio delle storie parallele di idee scientifiche di varia origine mostra non solo connessioni profonde e spesso sorprendenti, ma anche la ricorrenza di fenomeni tipici, come la periodica perdita di conoscenze e il sorgere di “miti di fondazione” che attribuiscono a singoli geni l’esito di complessi percorsi collettivi.
***
La bottega dello scienziato. Introduzione al metodo scientifico, con A. Della Corte, il Mulino, 2016.
Nel senso comune i risultati delle scoperte scientifiche suscitano stupore e meraviglia non meno che incomprensione, mentre verso gli scienziati che li hanno ottenuti si nutre una sorta di ammirata reverenza. Fuori dal mito, come lavorano gli scienziati? Qual è il loro metodo? È quanto ci fa capire il libro che, dopo aver introdotto il concetto di teoria scientifica attraverso pochi semplici esempi (uno fra tutti: la teoria eliocentrica), ci accompagna nella bottega dello scienziato, descrivendo non il suo prodotto finito, ma alcuni degli strumenti usati per costruirlo.
***
Euclide: il I libro degli Elementi, con E. Salciccia, G. Pirro, Carocci Editore 2017.
Gli Elementi di Euclide hanno costituito per più di due millenni il testo base dell’insegnamento scientifico. Già il titolo mostra come l’autore intendesse esporre conoscenze basilari, fornendo gli strumenti utili per raggiungere risultati più avanzati. La geometria – il principale argomento dell’opera – era infatti la base di tutta la scienza esatta dell’epoca e i problemi di astronomia, ottica, meccanica, idrostatica, geografia matematica, topografia e così via venivano risolti disegnandone la soluzione. Il i libro degli Elementi è qui ricostruito eliminandone alcuni brani, individuati come spuri per la loro incongruenza logica/con il contesto. Ne è risultato un teéto più coerente e didatticamente efficace di quello trasmesso dalla tradizione manoscritta, il cui studio può fornire ancora oggi una preziosa guida metodologica.
***
LE COPERTINE
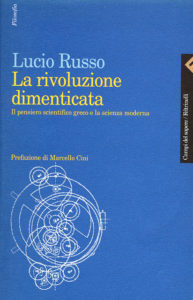
La rivoluzione dimenticata
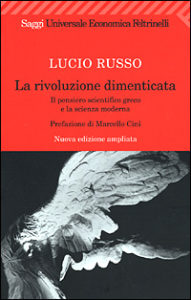
La rivoluzione dimenticata
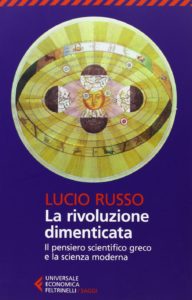
La rivoluzione dimenticata
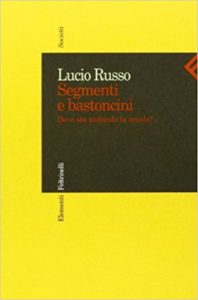
Segmenti e bastoncini
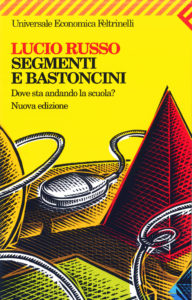
Segmenti e bastoncini
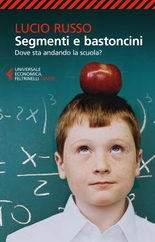
Segmenti e bastoncini
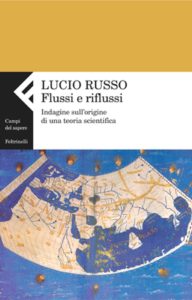
Flussi e riflussi
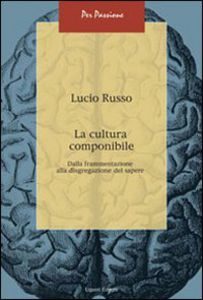
La cultura componibile

Archimede
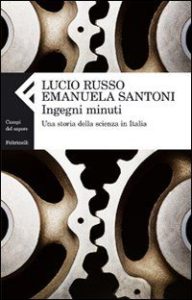
Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia
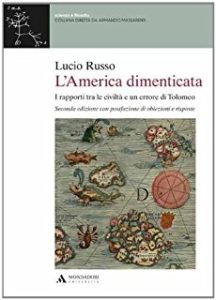
L’America dimenticata
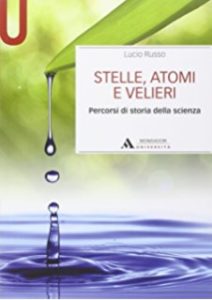
Stelle, atomi e velieri
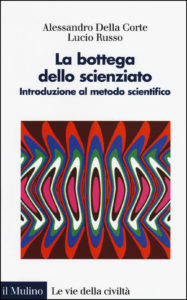
La bottega dello scienziato
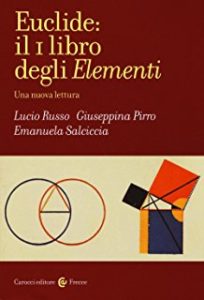
Euclide, il I libro degli Elementi
Su YouTube
Incontro con il Prof. Lucio Russo – YouTube
Interviste:
 |
| Lucio Russo |
|
|
| [Pubblicato su Koinè (Metamorfosi della scuola italiana), Anno VII, NN° 1-2 – Gennaio/Giugno 2000], pp. 20. |
|
| indice – presentazione – autore – sintesi |
|
«Se esiste un’idea guida nell’attuale processo di riforma della scuola italiana essa sembra consistere nella tendenza ad “alleggerire”, se non eliminare, i contenuti dell’insegnamento, riducendo le funzioni delle istituzioni scolastiche a quelle di accogliere i giovani, favorirne la socializzazione e guidarli nelle scelte di consumo. Una scuola ridotta a luogo di socializzazione e di assuefazione all’uso di prodotti rischia di produrre cittadini di seconda classe, privi di qualsiasi strumento critico verso il mondo che li circonda. Anche se forze potenti, cui sembra difficile opporsi, spingono in questa direzione, credo che sia essenziale salvare almeno spazi di riflessione e discussione critica che, se ben difficilmente possono sperare oggi di invertire la tendenza, potrebbero divenire essenziali domani. La situazione in cui ci troviamo oggi è infatti in larga misura conseguenza di un grave deficit culturale accumulato nell’arco di molti decenni. Non voglio certo negare le responsabilità dell’attuale governo nel perseguire l’obiettivo della distruzione di una scuola pubblica di qualità (anche se sono propenso a credere che si tratti di un obiettivo in larga misura inconsapevole), ma si sbaglierebbe individuando nell’attuale classe politica italiana l’origine, o anche solo un fattore rilevante, della crisi dell’istituzione scolastica e in particolare dei suoi contenuti disciplinari. Si tratta in realtà di una tendenza molto forte in tutto il mondo occidentale, anche se in Italia si presenta con varie aggravanti, tra le quali è certamente presente il provincialismo e l’insipienza. Credo che all’origine della crisi della scuola pubblica europea vi sia la convergenza di fattori di diversa natura, che comprendono fenomeni economici e politici, come la concentrazione produttiva e la globalizzazione, e allo stesso tempo importanti processi culturali che hanno posto in crisi i contenuti disciplinari tradizionali. Questo articolo contiene soprattutto alcune osservazioni su quest’ultimo punto. Una prima osservazione, completamente ovvia, è quella che l’attuale parcellizzazione del sapere è all’origine di due tendenze didattiche apparentemente opposte, ma in realtà convergenti. Da una parte si rivendica l’esigenza di un insegnamento che, variamente definito come “interdisciplinare”, “multidisciplinare” o in altri modi simili, è caratterizzato dall’evitare l’acquisizione di efficaci strumenti concettuali, privilegiando quel continuo vagare da un argomento all’altro a un livello di costante superficialità, che ha nella “navigazione” casuale e senza meta in Internet il suo principale strumento e il suo modello. Dall’altra si moltiplicano le proposte di inserire nella scuola discipline nuove: dall’ecologia alla psicologia, dall’economia alla storia del cinema, dall’antropologia alla sociologia. Entrambe le tendenze, insieme a una serie di fenomeni che riguardano le singole discipline, alcuni dei quali saranno accennati nel séguito, favoriscono l’abbandono di qualsiasi obiettivo formativo (necessariamente basato sull’individuazione di alcune discipline cardine), sostituendo allo studio la raccolta casuale di informazioni sparse (o, preferibilmente, qualche altra attività più gratificante)».
Lucio Russo
Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word
 Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 19-03-2017)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 19-03-2017)
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.
***********************************************
Seguici sul sito web
 ***********************************************
***********************************************
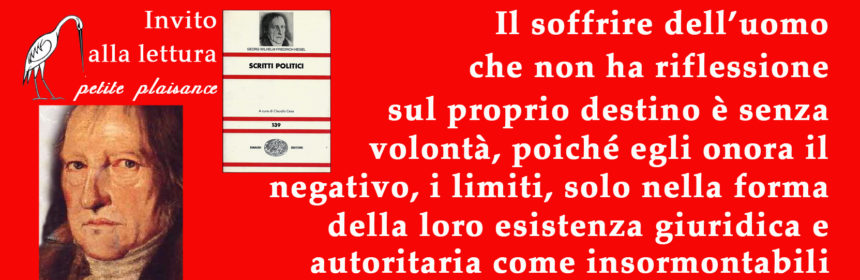
![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 22-03-2017)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 22-03-2017)