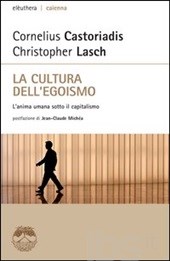Christopher Lasch (1932-1994) – Il capitalismo assoluto pone tutto sulla stessa linea d’orizzonte perché tutto dev’essere valore di scambio. La tolleranza diventa indifferenza, il pluralismo culturale, deprivato di giudizio etico, degenera in mero spettacolo estetico e rende inappropriato parlare di impegno etico in qualsiasi senso.

Salvatore Bravo
Recensione al libro di Christopher Lasch,
La ribellione delle élite
Il capitalismo assoluto è il regno dell’astratto, il regno del rigor mortis contrapposto alla vita. La concretezza è spirito vitale, prassi, trasformazione sociale e personale. Il concreto è pratica antinichilistica, poiché la concretezza è il concrescere dell’universale e del particolare. Il nichilismo è astratto, è la pratica atomistica dell’irrilevanza. L’astratto è separazione: ogni elemento, ogni ente, ogni essere umano è assunto nella sua cesura col mondo. Non può essere altrimenti. Per poter usare, bisogna separare, per poter ridurre tutto a semplice valore di scambio, tra l’usante e l’usato non deve intercorrere relazione alcuna. La violenza ha le sue leggi. La razionalità calcolante astrae il plusvalore, riduce a plusvalore ogni tocco, ogni sguardo. L’impero del valore di scambio, ha trasformato in realtà lo stato di natura posto come ipotesi da Hobbes. L’astratto ha cognizione dell’attività, ma non della prassi, in quanto la seconda implica un processo di trasformazione qualitativa e coscienziale. Nell’astratto non vi è che la riproduzione sempre uguale dei rapporti di produzione alienati, sotto il suo imperio annichiliscono le culture, le lingue, i paesaggi: è un buco nero che pare inarrestabile e minaccioso. La paura della desertificazione, dell’estinzione della vita viva, non è insuperabile. Le parole, il logos sono con noi, dunque possono porci in una condizione di consapevolezza, di distanza domandante, mentre la condizione astratta non ha parole per decodificare le circostanze in cui si è gettati. Il nichilismo è una pratica e non una teoria, affermava Costanzo Preve. Il nichilismo avanza con le sue ideologie, con la scomparsa del mondo autentico per il virtuale. Christopher Lasch, in La ribellione delle élite, descrive il ripiegamento delle classi dirigenti su se stesse, la loro fuga dagli spazi della democrazia e dunque dalle responsabilità sociali. L’astrazione si palesa nel loro dorato isolamento che rende il mondo incomprensibile e nemico. La borghesia scompare e con essa scompare la coscienza infelice, la pratica della contraddizione, del negativo che crea e trasforma; al suo posto solo la squallida difesa ideologica del proprio orticello economico dalle dimensioni globali. Interessi ovunque, ma il cuore come la testa in nessun luogo. L’attività nichilistica ha il suo epifenomeno in una tolleranza che diventa indifferenza, nel multiculturalismo che diviene spettacolo. La discesa agli inferi è lastricata come via del denaro, dello sfruttamento camuffato, dell’assenza di limiti. Il capitalismo assoluto non vuole limiti etici ed estetici, è il regno di una brutale indifferenza che vorrebbe realizzare anche l’impossibile. Esso deve desimbolizzare tradizioni nazionali come paradigmi etici, tutto dev’essere posto sulla stessa linea d’orizzonte perché tutto dev’essere valore di scambio. Non resta dunque che un multiculturalismo da spettacolo, da esibizione in nome della tolleranza, del regno dell’indifferenza:
«Ma in assenza di standard comuni la tolleranza diventa indifferenza e il pluralismo culturale degenera in una specie di spettacolo estetico in cui possiamo anche assaporare con il gusto del conoscitore le curiose costumanze dei nostri vicini, ma non ci prendiamo il disturbo di esprimere un qualsiasi giudizio sui nostri vicini in sé, in quanto individui. La sospensione del giudizio etico, secondo la versione corrente del pluralismo, quale che sia, rende inappropriato parlare di impegno etico in qualsiasi senso. Tutto quanto possiamo permetterci, stanti le definizioni correnti di diversità culturale è l’apprezzamento estetico». [1]
Il giudizio etico necessita di impegno, ha inevitabili implicazioni dialettiche. La fatica del negativo rende la persona partecipe e propositiva, disegna limiti e con essi pone un confine al mercato, al valore di scambio. La tolleranza che diviene indifferenza spinge invece verso il declino della cittadinanza attiva, motiva alla semplice curiosità senza coinvolgimento. Non ci si conosce che in modo fugace ed epidermico: in tal modo il pluralismo culturale diviene la giustapposizione di persone senza relazioni. L’assenza della comunità, della conoscenza dell’altro, rende lo sradicamento un’abitudine, un comportamento reso ipostasi. Il fine è rendere impossibile ogni concretezza, ogni prassi comunitaria. L’indifferenza non crea nulla, rafforza il valore di scambio, svuota le istituzioni democratiche del loro senso: il nichilismo avanza sostenuto dall’arretramento di ogni senso di civica solidarietà. Il timore di ogni valore comune, della ricerca argomentata della concretezza universale è neutralizzata con lo spauracchio del fascismo e del nazismo in assenza di essi:
«La nostra società è stretta dalla morsa di due grandi paure, entrambe paralizzanti: la paura del fanatismo e quella della guerra razziale. Proprio perché abbiamo scoperto in ritardo la contingenza di tutti i sistemi di credenze siamo ossessionati dai timori che nascono quando si considerano universali delle verità parziali. In un secolo dominato dal fascismo e dal comunismo, questo terrore è comprensibile, ma ormai si può sostenere, senza essere accusati compiacenza, che la minaccia totalitaria sta svanendo». [2]
La paura del fascismo e del nazismo è sventolata dinanzi a coloro che cercano ed affermano la possibilità dell’universale. Tacciare di intolleranza chiunque non si unisca al coro della facile indifferenza, mostruosizzandolo, è il nuovo mezzo con cui opera la censura. Si resta in una logica dicotomica, da una parte i fascisti dall’altra i buoni e giusti per i quali la condizione attuale è il migliore dei mondi possibili. Ogni dialettica si ritira dal mondo. Il logos – che per natura è comunicazione, dialogo –, nel suo tramonto allunga le ombre sulla democrazia. C. Lasch giudica la democrazia in pericolo in assenza dell’anima che dovrebbe renderla luogo di formazione e partecipazione. La borghesia sostituita dalla finanza è il veleno mortale che la democrazia beve quotidianamente. L’indifferenza diviene livellamento culturale. La finanza non produce classi dirigenti, ma solo servi fedeli. Il livellamento verso il basso rende l’elaborazione di nuovi progetti politici improbabili, il sistema si difende livellando, non chiedendo nulla ai suoi giovani, lascia che l’anomia li formi, che gli analfabeti mediatici possano lasciare ai padroni spazi di potere sempre più ampi:
«Ma se si concede a ogni impulso di venire pubblicamente espresso, se si afferma sfacciatamente che “è vietato vietare”, come suonava lo slogan rivoluzionario del ’68, non ci si limita a promuovere l’anarchia: si aboliscono quelle “sacre distanze” da cui dipende in definitiva, la categoria stessa di verità. Quando ogni espressione è egualmente lecita, nulla è vero. Con la creazione di opposti … ideali di verità militanti, si sanziona la terrificante capacità dell’uomo di esprimere qualsiasi cosa». [3]
Lasch dunque delinea il pericolo del vuoto creato dalle classi dirigenti, dal loro fanatico culto del nichilismo finalizzato alla sola economia. La verità vuole distanza. Ovvero, affinché la verità possa trovare le condizioni di emergenza è necessario il pensiero. Il cogitare necessita che il soggetto non sia continuamente preda del mercato, sottoposto ad una stimolazione ossessiva che lo riduce a semplice attività biologica. La democrazia esige spazi in cui il mercato non deve entrare altrimenti divora l’essenza stessa della democrazia: la parola, il logos, il pensiero. Il nichilismo avanza nella forma del mercato, non vi sono contrappesi al nuovo Leviatano. La famiglia, quale luogo formativo dove si impara la comunione dei beni e la solidarietà – dunque forma di resistenza critica alla privatizzazione – è invasa dal mercato, come accade per la scuola. In assenza di contrappesi la democrazia è in pericolo:
«Invece di fungere da contrappeso al mercato, in sostanza, la famiglia è stata invasa dal mercato, che ne ha minato le basi».[4]
Le piattaforme mediatiche non possono certo sostituire i corpi medi che formano il cittadino: la parola vuole vicinanza, concretezza, solo in tal modo la parola dinanzi allo sguardo dell’altro può assumersi la responsabilità del dialogo. Le forme alternative di comunicazione, la democrazia diretta in piattaforma, risponde allo scollamento tra parola, partecipazione e responsabilità. La distanza spaziale, la scomparsa della comunicazione viva, dei corpi viventi che si confrontano senza vie di fughe facili e comode è il volano dello svaporarsi della creatività e della resistenza. Il testo di Lasch è una difesa della democrazia contro il nichilismo che la divora, che svuota le sue istituzioni a favore del deserto che sembra avanzare inesorabile.
Salvatore Bravo
[1] C. Lasch, La ribellione delle élite, Feltrinelli, Milano, 2009, pag. 75.
[2] Ibidem, pag. 77.
[3] Ibidem, pag. 180.
[4] Ibidem, pag. 83.
Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word
![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-07-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 05-07-2018)
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.
Seguici sul sito web