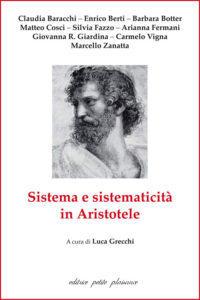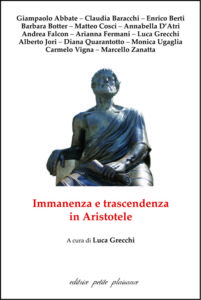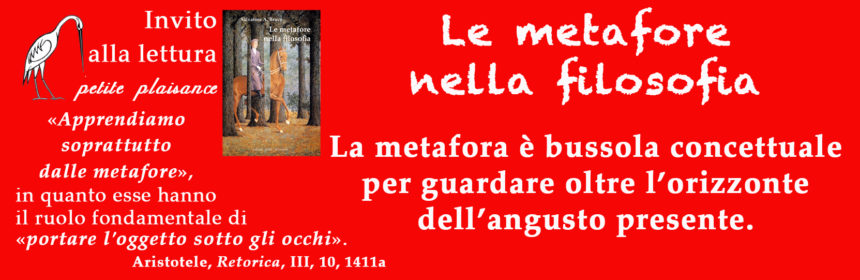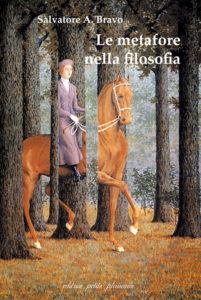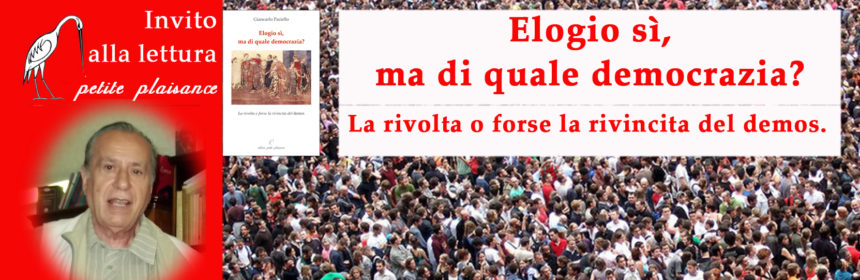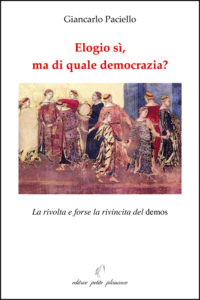Salvatore A. Bravo
Plebe e popolo: rivoluzione passiva e tecnologie
*
***
*
Vi è popolo solo dove vi è sovranità partecipata
La rivoluzione passiva delle tecnologie
Ecco l’inglese globale
Schiacciare la lingua sull’indicativo, riducendo a nulla il congiuntivo
Il popolo diventa plebe in assenza di pensiero e di linguaggio
Il popolo, per essere davvero tale, deve essere comunità
Il popolo è comunità manifesta, è progetto partecipato
Popolo e ragione (Vernunft)
La plebe intelletto (Verstand)
La plebe non ha agorà
Non possiamo sottrarci alla responsabilità del divertere
***
Vi è popolo solo dove vi è sovranità partecipata
Vi è popolo dove vi è sovranità partecipata, dove le politiche sociali ed economiche non cadono come un destino ineluttabile, come catene fatali sul popolo. Oggi siamo oltre la Rivoluzione passiva descritta da Cuoco e da Gramsci. La Rivoluzione passiva presuppone una borghesia affetta da coscienza infelice, capace di sentire l’universalità dei valori fondanti della Rivoluzione francese e dell’Umanesimo. Il popolo, ancora plebe, deve ancorarsi alla classe motrice della coscienza nazionale per poter essere protagonista, defilato, perché agito. La condizione attuale ha sostituito alla rivoluzione delle coscienze, dell’idea che diventa Spirito (Geist) nel movimento della storia, la sola rivoluzione permanente delle tecnologie, del mercato della produzione e del lavoro, una nuova trinità senza salvezza.
La rivoluzione passiva delle tecnologie
La rivoluzione tecnologica appare scissa dalla storia dell’umanità, essa avviene… È un evento che plana nella storia e modifica le esistenze. Rivoluzione anonima: la scienza – quale sostanza astratta dalla realtà contingenze – detta i suoi ordini, riconfigura le comunità, le travia fino a fessurare il loro essere, la loro identità culturale, per annientarle. Le comunità passivizzate perdono – con la coesione – sincronicamente anche le parole. La rivoluzione passiva delle tecnologie senza finalismo, smantellano non solo lo stato sociale, ma con esso anche il linguaggio.
Ecco l’inglese globale
Ed ecco l’inglese globale, lingua che ha la stessa funzione della materia omogenea, ovvero far scivolare le merci e gli scambi mercantili per il pianeta ed abbattere ogni limite linguistico e culturale, purchè l’economia – alleata delle tecnologie – possa trionfare senza limiti e confini. Le lingue nazionali – a parte pochissime eccezioni (Francia, Spagna) – sono gradualmente smantellate dalle nuove generazioni che, educate alla cultura imprenditoriale, corrono verso la rivoluzione che subiscono: il sistema scolastico asservito all’economia non consente senso critico e con esso lo sviluppo di empatica appartenenza “ruere in servitium”.[1]
Schiacciare la lingua sull’indicativo, riducendo a nulla il congiuntivo
Si corre verso l’asservimento, lo si abbraccia, si risponde all’appello della rivoluzione passiva dell’economia secondo logiche adattive: si amano le proprie catene. Affinchè il declino dello spirito critico, del pensiero connettente sia neutralizzato, si favorisce – con l’angloitaliano – la riduzione della lingua nazionale ad una manciata di parole pronte per l’uso. Ci si limita ad una lingua che deve limitarsi a soddisfare le esigenze individuali particolari ed immediate. Si schiaccia la lingua sull’indicativo riducendo a nulla il congiuntivo, il modo del dubbio, della possibilità, della complessità: non è un caso che si favorisca la lingua inglese, la quale praticamente ha il congiuntivo solo alla prima persona del verbo essere al passato, e spesso non è utilizzato, specie nell’americano. Devono esserci solo certezze e pensieri semplici per radicarsi nel presente. Pertanto bisogna congelare il congiuntivo, in quanto il dubbio introduce visioni critiche che rompono con l’atteggiamento adattivo al presente.
Il popolo diventa plebe in assenza di pensiero e di linguaggio
Il popolo diventa plebe non solo quando è minacciata la sua sopravvivenza materiale, quando lo si ricatta attraversa la precarietà. È plebe in assenza di pensiero, di linguaggio che eccede l’utile del tempo immediato. Senza il pensiero connettente e la ragione filosofica, non vi è che lo schiacciamento verso il basso, la riduzione del popolo a plebe consumante, brulicante a testa bassa. La plebe, non è una classe sociale, non si definisce mediante il censo: la plebe è la popolazione in cui prevale la condizione spaziale sulla condizione temporale. Il linguaggio è relazione, è memoria, esperienza riflessa, conoscenza di sé, dunque è movimento, temporalità concreta che riallaccia e trascende le divisioni.
Il popolo, per essere davvero tale, deve essere comunità
Ancora una volta la Filosofia ci è di ausilio per definire il popolo. Hegel, nella parte sesta della Fenomenologia dello Spirito, descrive il popolo come comunità. Il popolo è la comunità culturale di appartenenza, non tribale, che pensa se stesso come un tutto in cui convivono le parti. Il popolo è l’umanizzazione del singolo, che – non più atomo, non più astratto dal tutto – liberamente rinuncia al proprio egoismo per aprirsi all’altro, per riconoscere se stesso attraverso la relazione comunitaria.
Il popolo è tale se la condizione del tempo è vissuta nella pienezza della coscienza. Il popolo è storia, attività che pone progetti e dunque non vive scollato dalla sua contingenza storia, dal suo immediato, ma esso è il suo tempo pensato nell’estensione del pensiero che riannoda le fila del passato e del futuro passando per il presente:
«Nella misura in cui lo spirito è la verità immediata, esso è la vita etica d’un popolo: l’individuo che è un mondo. Lo spirito deve allora procedere fino alla coscienza di ciò che esso è immediatamente; deve levare la bella vita etica e raggiungere, attraverso una serie di figure, il sapere di se stesso. Queste figure però si differenziano dalle precedenti perché si tratta di spiriti reali, realtà effettive vere e proprie, e anziché essere figure solamente della coscienza, sono figure d’un mondo».[2]
Il popolo è comunità manifesta, è progetto partecipato
Il popolo è comunità manifesta, la coscienza di un popolo è progetto partecipato e di conseguenza palese. Dove vi è il popolo la politica ha la sua massima espressione nei corpi medi partecipati. Il linguaggio diventa così condizione imprescindibile della partecipazione, non è limitato al solo utile immediato, ma si declina ed arrichisce nei contesti della partecipazione. Un popolo senza linguaggio, senza cultura è solo plebe, è oggetto della storia. Popolo e etica coincidono, vi è etica dove vi è comunità consapeole che agisce nella storia, si fa storia trasformando in prassi le verità eterne che l’esperienza storica custodisce:
«La comunità – la legge suprema, la cui validità pubblica si manifesta alla luce del sole – ha la propria vitalità effettiva nel governo, inteso come ciò in cui essa è individuo. Il governo è lo spirito effettivo riflesso entro di sé, è il Sé semplice della sostanza etica nella sua totalità. Questa forza semplice consente certamente all’essenza di espandersi nell’articolazione dei suoi membri, e di dare a ogni parte una sussistenza e un proprio essere-per-sé. In ciò, lo spirito ha la propria realtà ossia il proprio esistere, e l’elemento di questa realtà è la famiglia».[3]
Popolo e ragione (Vernunft)
Nel popolo non vi sono atomi, individui separati, astratti dalla comunità, dalla storia, da se stessi e pertanto alienati. Nel popolo ogni individuo è parte consapevole di un comune e condiviso progetto politico, per cui il soggetto umano trova la sua ragion d’essere, il suo destino. Nella comunità non vi è che la vita della ragione che unisce i destini, pone limiti, struttura processi di autoriconoscimento mediato dalla relazione con l’alterità. La relazione non è solo l’incontro dello sguardo, l’empatia immediata, ma è specialmente linguaggio quale figura universale dell’incontro e dell’unione. La lingua patria non è nazionalismo escludente, ma è consapevolezza nella differenza. L’autoriconoscimento dei popoli avviene nell’incontro delle differenze:
«In un popolo libero, la ragione s’è perciò data vera effettuazione; essa è presenza dello spirito vivente, in cui l’individuo non soltanto trova la propria determinazione destinale – vale a dire, la propria essenza universale e singola – enunciata e data al modo della cosalità, ma anzi è egli stesso tale essenza, e ha anche raggiunto quella propria determinazione».[4]
La plebe intelletto (Verstand)
La plebe è il popolo animalizzato, non necessariamente ridotto in miseria, anzi vi può essere popolo e nel contempo deficienza di beni, perché la verità di un popolo è la sua consapevolezza comunitaria. La plebe è la pratica della specialistica, senza capacità di cogliere la totalità, è la pratica dell’intelletto (Verstand).
La plebe è anche la cultura specialistica senza struttura, e pertanto facilmente oggetto di manipolazione. La plebe è disinformata, o meglio la sua informazione è costituita dall’accettazione acritica delle fonti informative. È belante, ripetitiva, automatica nelle parole e nei comportamenti, ma specialmente difetta di coscienza di sé e di coscienza pubblica. La plebe non crede di poter cambiare il proprio tempo, per cui non lo pensa, lo subisce. Regredisce ad uno stato superstizioso, crede nel potere magico del grande leader, crede nella sua lingua, nelle sue parole, si deresponsabilizza dinanzi alla storia, dinanzi a se stessa, è carne da cannone per il consumo:
«Nella tradizione della filosofia politica occidentale, che è di origine greca, il “popolo” (demos) si distingue dalla mera aggregazione popolare (laos) proprio perché è “informato”, ed è informato nello spazio pubblico (demosion), spazio pubblico che è presupposto alla sua sovranità (kyriarchia) che del suo potere (exousia)».[5]
La plebe non ha agorà
La plebe dunque non ha agorà. Dove vigono le oligarchie finanziarie, non vi sono spazi pubblici, ma solo luoghi per l’ortopedia del consumo: ipermercati e luoghi del divertissiment. Tutto deve indurre alla fuga dal proprio tempo, non bisogna pensare, rappresentarsi il reale, il pensiero non deve porre l’essere, ma lo deve subire mediante l’esercizio e la pratica dell’ideocrazia.
Non si nasce servi, lo si diventa mediante l’addestramento quotidiano all’ideocrazia, al pensiero unico: poche parole tutte funzionali alla valorizzazione del capitale senza limiti. L’ideocrazia del mercato, del modello unico del pensiero e della lingua non è un destino. La storia è il luogo della vita degli esseri umani, del possibile. Nella storia le faglie liberano potenzialità impensabili. La condizione di plebe può ribaltarsi in popolo, se si mettono in atto pratiche virtuose del pensiero.
Non possiamo sottrarci alla responsabilità del divertere
La resistenza di un popolo non può che iniziare con il pensare il proprio tempo, con il rilevare il tragico non come un destino, ma come una circostanza posta da più soggetti responsabili popoli annessi: il riconoscimento delle proprie responsabilità dinanzi alla storia ed a se stessi è già prassi, uscita dalla caverna del nichilismo programmato da altri. La storia è Wirchliche Historie. Nessuna provvidenza verrà a salvarci. Ma, come l’Angelus Novus di Klee nel commento di Benjamin, non possiamo sottrarci alla responsabilità del divertere dal destino del Regno animale dello Spirito.
Salvatore A. Bravo
[1] «At Romae ruere in servitium consules, patres, eques» (A Roma intanto si precipitavano in gesti servili consoli, senatori, cavalieri), Tacito, Storie, I, 7.
[2] G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Einaudi, Torino, p. 293.
[3] Ibidem, p. 300.
[4] Ibidem, p. 239.
[5] Costanzo Preve, L’Ideocrazia Imperiale Americana, Roma, p. 58.
Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word
 Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 04-12-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 04-12-2018)
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.
***********************************************
Seguici sul sito web
 ***********************************************
***********************************************
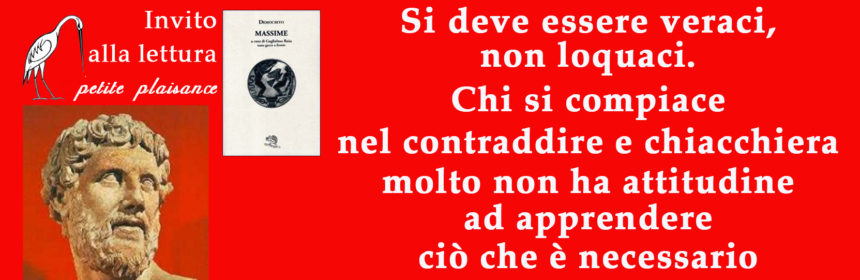
![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 10-12-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 10-12-2018)


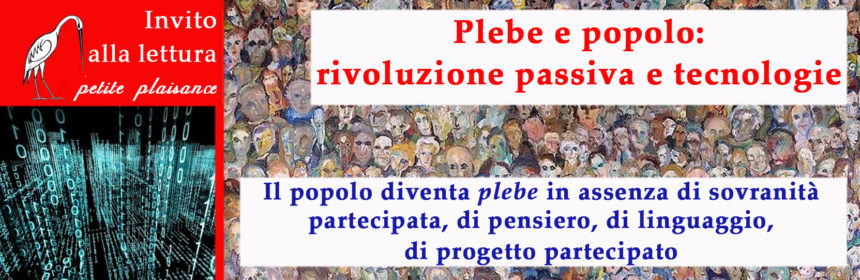
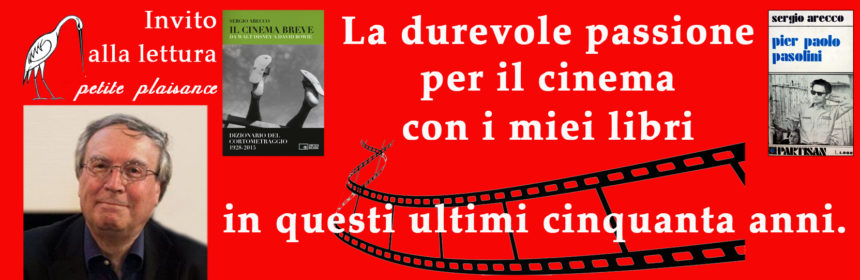

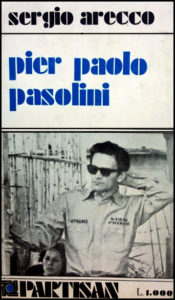
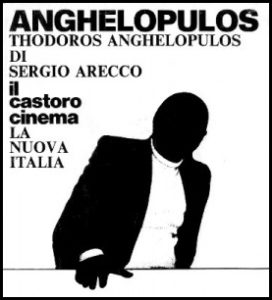
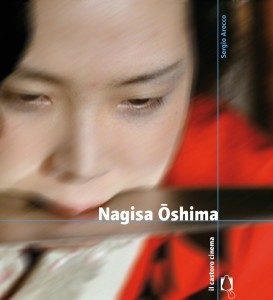
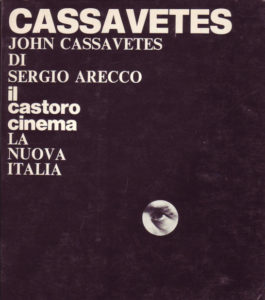
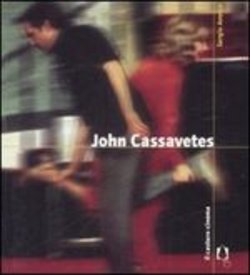
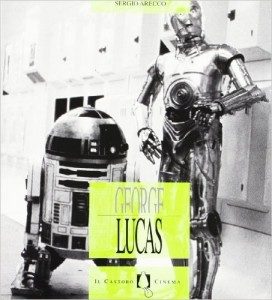

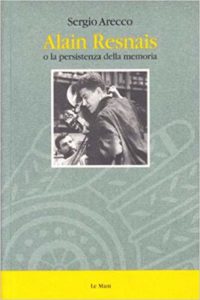

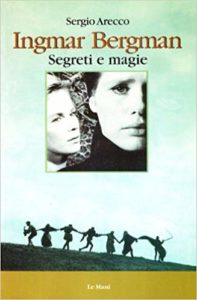
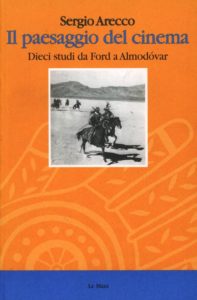
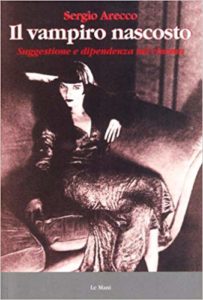
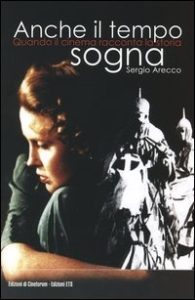
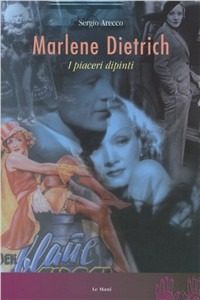
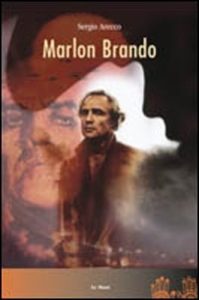
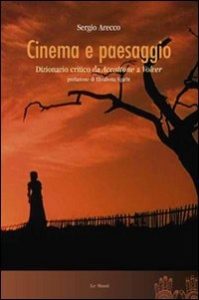

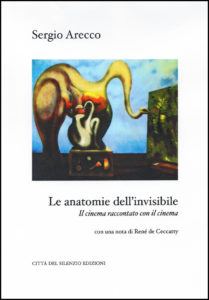
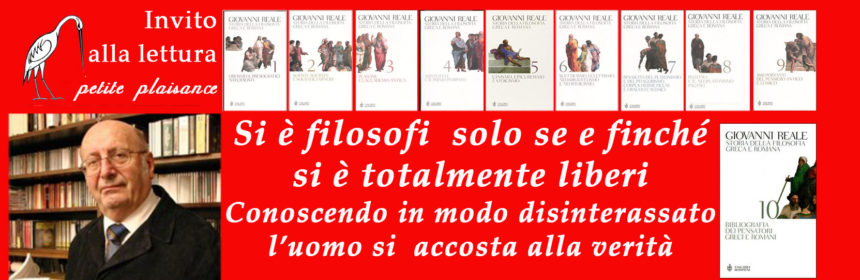


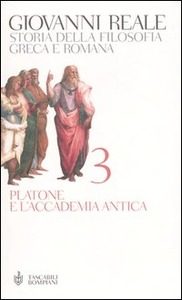
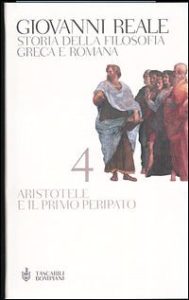
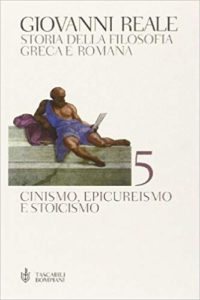
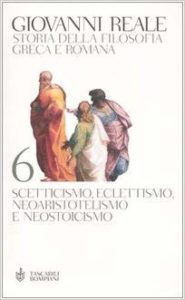
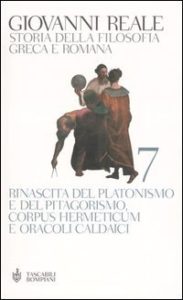
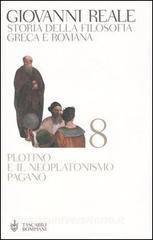
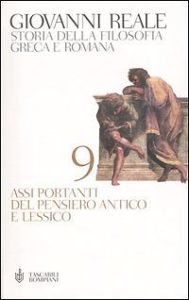
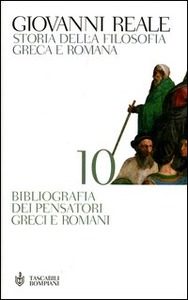
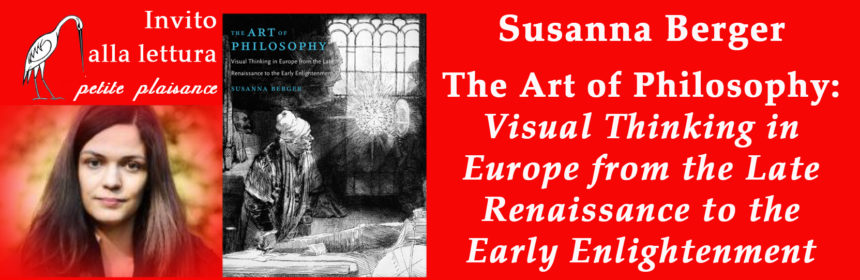
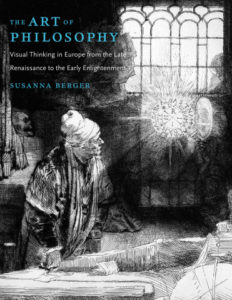
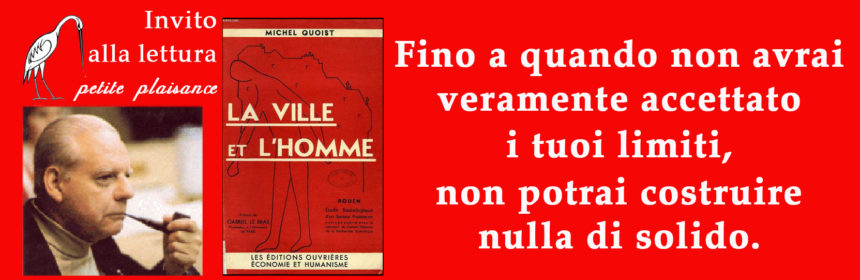
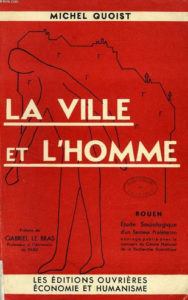


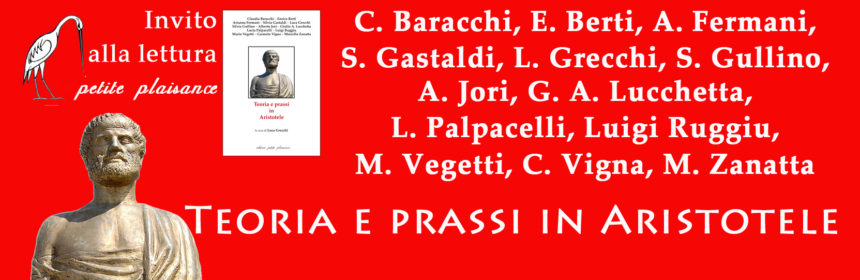
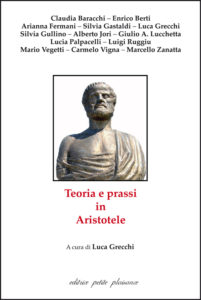
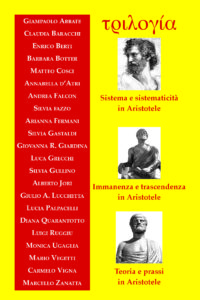
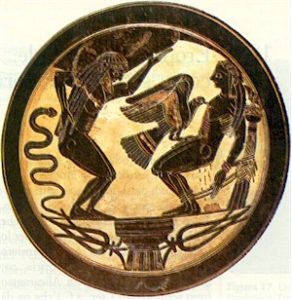 ***
***