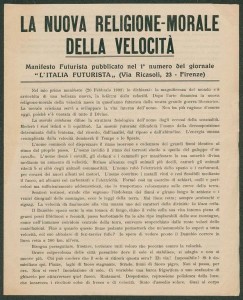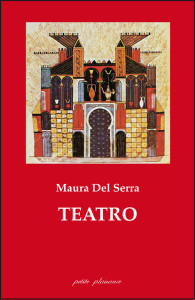Giancarlo Chiariglione – La caricatura e il suo doppio ovvero: Elio Petri e i nodi del cinema politico italiano
Parlando di Elio Petri, viene da domandarsi come quest’autore abbia potuto occupare così autorevolmente la categoria del politico (cineasta d’impegno, regista del cinema politico) ed essere al contempo oggetto di un ostracismo critico che sovente ne ha fatto il prototipo di tutto quanto andava evitato al cinema negli anni sessanta e settanta. L’esiguo numero di pubblicazioni[1] che lo riguardano, testimonia, infatti, di come egli, nel panorama delle analisi dei film italiani del dopoguerra, sia stato relegato in una zona oscura, ambigua, che in malo modo si concilia con il cristallino apprezzamento (sconfinante spesso nel plebiscito) ottenuto da alcune sue pellicole presso il grande pubblico. Provare a definire i caratteri della vicenda Petri, diventa pertanto un’operazione complessa, nonostante sia diffusa la sensazione che si stia forse entrando in una nuova fase degli studi sul regista romano[2]; che sia finalmente possibile operare un ripensamento generale alieno sia ai passati radicalismi che hanno, come vedremo, compromesso un’analisi accurata della sua opera, sia a possibili future canonizzazioni acritiche.
Noto soprattutto come regista e artista, l’autore romano è stato anche un uomo lucido (e inquieto) che ha riflettuto molto sul senso del suo lavoro, un intellettuale che ha partecipato da protagonista alla discussione nata dai fuochi della contestazione che nei decenni “caldi” divampavano su tutti i fronti, un attento indagatore del nostro sociale che, senza mai sacrificare la propria soggettività a dogmatismi e ragioni di partito (il riferimento è chiaramente al PCI), ha utilizzato tutte le risorse che lo spettacolo gli metteva a disposizione per mostrare al pubblico l’estrema complessità del reale.
Elio Eraclio Petri nasce il 29 gennaio del 1929 in via dei Giubbonari, allora cuore “popolare” di Roma. Figlio unico in un’epoca di famiglie assai numerose, cambia varie volte casa e quartiere. Suo padre, di corporatura minuta e di indole mite, faceva lo stagnino (la sua figura personificata dall’attore Salvo Randone, ritorna più volte nelle pellicole petriane), mentre la madre dall’aria dolce e così rassomigliante fisicamente al figlio, la casalinga. Un po’ perché di famiglia modesta e un po’ per incostanza, il giovane Petri abbandona gli studi (Istituto Tecnico Superiore) prima della maturità, per inseguire con l’insaziabile fame dell’autodidatta una cultura fatta di vita di strada e di convinta militanza politica:
«Mi cacciarono due volte dalla scuola e, infine, fui io a rifiutarmi di prendere il titolo di studio. Tutto pareva, anche allora, più necessario dell’andare a scuola. […] erano anni di guerra e di dopoguerra […] Le strade puzzavano ancora di morte e di fascismo. Se feci, quindi, una scuola fu per le strade, nelle cellule del partito comunista, nei cantieri del genio civile, al cinema, al varietà, nelle biblioteche comunali, leggendo i giornali e le riviste di partito, amando «Politecnico», facendo scuola di partito, nelle lotte dei disoccupati, in camera di sicurezza, anche a Regina Coeli, negli scontri con la polizia, nelle sparatorie, nei linciaggi, nei postriboli, negli studi dei pittori della mia età, in tipografia, da Rosati a Piazza del Popolo, nei cineclub, nei comizi, tra coloro che a quel tempo venivano ancora chiamati rivoluzionari di professione. I miei testi li trovavo nelle sezioni del partito comunista e sui carrettini dei libri usati. I miei eroi: Totò, Bogart e Julien Sorel»[3].
E di questa tenace volontà di rincorrere ogni interesse o suggestione, di questa ostilità verso qualsiasi compiutezza e stabilità, verso una deterministica concezione del mondo, tutte le opere di Petri porteranno le tracce tanto nell’immaginario (plateale ed eccentrico), quanto nello stile (così vitalistico da sfiorare spesso l’eccesso). Per quel che riguarda, invece, il partito comunista, l’autore romano, appassionato di politica sin da giovanissimo, si iscrive allo stesso nel 1946 e aderisce alla Federazione giovanile. Petri è un giovane comunista intraprendente e disciplinato, che dapprima partecipa in modo attivo al referendum monarchia-repubblica e alle proiezioni e ai dibattiti del Circolo romano del cinema fondato da Cesare Zavattini, e poi, divenuto a sua volta dirigente della Federazione, si impegna per diffondere celebri film sovietici nelle più disparate sale cinematografiche della provincia (il ricordo di quegli estenuanti viaggi e dei tentativi, spesso vani, di convincere gli esercenti a proiettare opere come Biancheggia una vela solitaria [Beleet Parus Odinokij, 1937] di Vladimir Legoscin, Il Compagno “P” [Ona Zasciscjajet Rodinu, 1943] di Friedrich Ermler e Il destino di un uomo [Sud’ba? Eloveka, 1959] di Sergei Fyodorovich Bondarchuk, saranno in futuro rivissuti dal cineasta con divertimento e nostalgia). Negli stessi anni Petri si distingue anche per l’originalità con cui firma alcuni articoli per il periodico «Gioventù nuova», in virtù dei quali, viene invitato a collaborare alla rubrica cinematografica de «l’Unità» come vice di Tommaso Chiaretti. Tramite questa vera e propria pratica sul campo[4], il nostro approda, infine, al mondo del cinema. Coloro che lo introducono nell’ambiente sono il direttore del quotidiano comunista Pietro Ingrao e l’amico Gianni Puccini, già direttore della rivista «Cinema» e sceneggiatore di Ossessione (1943) con Visconti, Mario Alicata, Antonio Pietrangeli e Giuseppe De Santis.
Proprio a quest’ultimo, alla disperata ricerca di un cronista “romano de Roma” capace di fare un’inchiesta su un tragico fatto che aveva scosso la città, i due sopraccitati consigliano il futuro regista di Indagine. In pieno clima neorealista, la cronaca alimentava la fantasia e la coscienza di intellettuali ed artisti, pertanto, anche De Santis, interessato a trasporre cinematograficamente la vicenda dell’incidente che il lunedì 15 gennaio 1951 aveva coinvolto più di duecento giovani donne richiamate in via Savoia 31 da un annuncio che prometteva un posto da dattilografa[5], decide di promuovere un’indagine sul campo. Data l’applicazione con la quale ha portato avanti la ricerca e i buoni risultati raggiunti, Petri viene invitato a prendere parte alla realizzazione della sceneggiatura con lo stesso regista, Basilio Franchina, Rodolfo Sonego, Zavattini, Puccini e anche se alla fine non viene accreditato nei titoli di testa, questa collaborazione risulterà decisiva per la sua carriera. Nell’autunno del 1951, infatti, hanno luogo le riprese di Roma ore 11 (1952) e il giovane Elio è promosso a secondo assistente alla regia a fianco di Basilio Franchina. Tale apprendistato sancisce anche l’inizio di un rapporto di amicizia con il maestro ciociaro che crescerà nel tempo («per me fu più di un fratello» disse a tal riguardo il nostro)[6] e che sosterrà Petri sino ai tempi del suo esordio con L’assassino (1961). Dal canto suo, De Santis, affezionatosi a quel ragazzo umorale ma così pieno di curiosità e intraprendenza (e soprattutto comunista ortodosso come lui), commissionandogli altre cinque sceneggiature[7], contribuirà in modo consapevole a consolidare un imprinting che influenzerà il suo stile marcato e visionario, fatto di una presa diretta della realtà umana e sociale, come pure il suo gusto per la composizione ampia e articolata abbinata ad audaci movimenti della macchina da presa (secondo le cadenze e i ritmi della cinematografia americana).
Con questo percorso tipicamente neorealista fatto di inchieste giornalistiche, scripts e documentari[8], Petri realizza un primo nucleo di opere che potremmo definire di “assestamento”. Il controllato film d’esordio L’assassino, l’antonioniano I giorni contati (1962) e Il maestro di Vigevano (1963), originale adattamento dell’omonimo romanzo di Lucio Mastronardi, denotano, infatti, la ricerca da parte dell’autore di una strada propria, di un linguaggio personale. Il quale si appalesa in forma satirica nell’episodio Peccato nel pomeriggio del corale Alta infedeltà (1964)[9] e nel graffiante apologo fantascientifico La decima vittima (1965). La fase successiva è quella della produzione matura, nella quale Petri, rielaborati i nodi tematici ed espressivi più importanti del quinquennio d’avvio in termini rivoluzionari, raggiunge infine un suo equilibrio e una sua, personalissima, misura. Sono gli anni inaugurati dal letterario A ciascuno il suo (1967), che proseguono con l’elegante Un tranquillo posto di campagna (1968) e culminano infine nella fortunata accoppiata di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) e La classe operaia va in paradiso (1971). Questa stagione solenne, figlia anche dell’armoniosa collaborazione tra il cineasta romano, l’attore feticcio Gian Maria Volonté e lo sceneggiatore Ugo Pirro è però destinata a concludersi, lasciando il posto al terzo e ultimo periodo della filmografia di Petri in cui l’efficacia e l’intensità del suo discorso si esasperano nella metafora livida e soffocante de La proprietà non è più un furto (1973), nel tetro giallo politico di Todo Modo (1979), nel sartriano Le mani sporche (1979) e nel disperato e a tratti apocalittico Le buone notizie (1980).
Al di là delle varie fasi creative che hanno segnato la sua opera, il comun denominatore della produzione di Petri resta indubitabilmente la passione[10]: la stessa che lo lega alla politica. E in tal senso, un primo motivo per cui la critica fece del regista il bersaglio privilegiato di un’accesa battaglia ideologica, stilando nei suoi riguardi innumerevoli capi d’accusa, può forse essere rintracciato nella traumatica interruzione della sua militanza nel «partito dell’infanzia e dell’adolescenza», successiva a quell’evento epocale che fu la rivoluzione ungherese del 1956.
La sollevazione anti-sovietica nell’allora Ungheria socialista originata da una dimostrazione di intellettuali e operai che il 23 ottobre incoraggiarono il ritorno al potere in Polonia di Wladyslaw Gomulka, vittima dello stalinismo, venne, infatti, duramente repressa dall’intervento dei soldati dell’Armata Rossa (il 10 novembre i Consigli di lavoratori, studenti e intellettuali ungheresi chiesero il cessate il fuoco), provocando in Italia una profonda lacerazione tra la militanza dissidente[11] e la posizione ufficiale del PCI. I quadri dirigenziali con Togliatti in testa (e ad eccezione di personaggi come il sindacalista Giuseppe Di Vittorio e l’allora direttore della sezione milanese de «l’Unità» Davide Lajolo), giudicarono l’intervento sovietico «una dolorosa necessità» per arginare la “controrivoluzione” orchestrata da gruppi armati ostili alla democrazia popolare[12]. Mentre Petri e altri centouno intellettuali e artisti comunisti come Alberto Asor Rosa, Carlo Muscetta, Natalino Sapegno, Renzo Vespignani, Delio Cantimori, Mario Socrate, Dario Puccini, Alberto Caracciolo, Renzo De Felice e Lucio Colletti, sconvolti dalle notizie provenienti da Budapest e cercando di smarcarsi dalla linea togliattiana, si riunirono per stilare un documento assai critico, pieno di dolore e di delusione nei confronti dell’operato sovietico in Ungheria. Il “Manifesto dei 101” suscitò polemiche di fuoco, ma Togliatti non cedette e la dura reazione della direzione del partito creò un vero e proprio “caso di coscienza” in quei firmatari che volevano utilizzare il documento per stimolare un dibattito inerente all’organizzazione interna del PCI. Proprio per sgombrare il campo dalle accuse di arrivismo, Petri, Paolo Spriano, Mario Socrate, Renzo Vespignani e altri inviarono a «l’Unità» una lettera nella quale si parlava di critiche pretestuose, di buona fede carpita, visto che anche la mobilitazione pressoché contemporanea di intellettuali francesi come Marguerite Duras, Albert Camus, Edgar Morin e Jean Paul Sartre (che a proposito dell’accaduto parlò di errori dello stalinismo corretti «a colpi di cannone»), per domandare il ritiro dei soldati sovietici dal suolo ungherese, evidenziava la portata politica dell’avvenimento e la necessità di una chiara presa di posizione da parte di tutti gli uomini di buona volontà.
Così, se la rottura verificatasi in seno al PCI tra intellettuali, artisti e classe dirigente da un lato favorì l’amaro abbandono di personaggi come Italo Calvino, dall’altro rafforzò la contestazione di alcuni degli attivisti sopraccitati, i quali, non volendo rinunciare al libero confronto sulle idee, si raccolsero attorno alla rivista «Città aperta». Finanziata dall’industriale Gian Fabrizio Sacripante e diretta da Tommaso Chiaretti, nella redazione della medesima si ritrovarono i letterati Dario Puccini e Mario Socrate, il filosofo classico Luca Canali, l’architetto Pietro Moroni, i pittori Ugo Attardi, Marcello Muccini, Renzo Vespignani e di nuovo Elio Petri. La rivista ospitava articoli di letteratura, pittura, architettura e cinema, nonché diversi contributi riguardanti il dibattito sull’ideologia marxista. Intervennero sulle sue pagine Calvino, Callisto Cosulich, Ugo Pirro, Giuseppe Campos Venuti e altri. La copertina del primo numero (25 agosto 1957), un’acquaforte di Vespignani (fraterno amico di Petri che fornirà numerose altre illustrazioni alla pubblicazione), presentava una prostituta intenta a sollevare la gonna per mostrare un religioso, un generale e un uomo politico infilati nelle sue mutandine. Quel disegno satirico era una esplicita dichiarazione politica dei dissidenti, i quali, deploravano l’invasione sovietica dell’Ungheria e riaffermavano contemporaneamente il loro rifiuto nei confronti della realtà politica italiana. La vicenda di questo eteroclito gruppo che incalzava la verità al di fuori di ogni vizio intellettuale[13], si concluse però come spesso si concludono le storie nelle quali ai protagonisti risultano sinceramente inconsapevoli i confini tra l’utopia e la realtà. Alla fine, il militante e critico d’arte Antonello Trombadori e il responsabile culturale del PCI Mario Alicata (che all’inizio tentò di convogliare i nostri nella redazione de «Il Contemporaneo» e poi, resosi conto dell’impossibilità di fermare l’iniziativa, cercò di contenerla proponendo in successione Enzo Modica e Chiaretti come direttori), riuscirono, infatti, ad avere la meglio su quei comunisti così indocili. Come ci racconta lo stesso Vespignani
«Con quella rivista volevamo misurare la febbre del partito, la sua capacità di resistenza alla nostra opposizione. Provocavamo. […] Venivamo convocati da Alicata, alle Botteghe Oscure, in una stanzetta monacale, spartana, e trovavamo il fascicolo, riga per riga, annotato da lui, […] ogni nota era una domanda per noi, ed esigeva una risposta, una correzione, che restavano lettera morta. […] In mezzo a tutto c’era Trombadori […] Aveva tutte le qualità per essere la nostra coscienza critica: è finito con lo scrivere ventimila articoli sugli sbandamenti della casualità […] Una volta, nel pieno di una lite, li da Alicata, esco dalla stanza per andare al cesso, e al cesso incontro Togliatti. […] Lui non disse niente: uscì senza filarmi, ma con la faccia nera. [Invece] Antonello, mi si butta al collo, piange, sento le lacrime sulla pelle, e dice, “Ma che state facendo, che state facendo…”. Gli dico: “Una rivista, Antonello, solo una rivista”. Con Antonello eravamo amici […]; ma poi c’era in lui il funzionario di partito, la smorfia di un uomo d’ordine.[…] Espulsero Tommaso Chiaretti: ce ne andammo anche noi, Petri, io, tutti»[14].
E in effetti, dopo una prima sospensione delle pubblicazioni (anche in virtù delle polemiche relative alla ferma condanna espressa dai redattori per l’esecuzione dell’ex premier ungherese Imre Nägy), col numero del giugno-luglio 1958, «Città aperta» cessò di uscire. Nel frattempo gli “eretici” (da Petri a Canali, da Socrate a Puccini, da Vespignani ad Attardi), avevano omesso di rinnovare la tessera del partito. Il futuro regista de L’assassino, quindi, smettendo di essere un comunista “ortodosso” (pur restando ancora affettivamente vicino al PCI), divenne uno di quegli intellettuali non tradizionali «che caratterizzano l’ambiente cinematografico romano»[15]. Uno scomodo “compagno di strada” destinato però a perdere sempre più contatto con il suo vecchio partito, visti anche i feroci e ingiustificati attacchi che negli anni settanta il regista ricevette dal PCI per la sua vicinanza al collettivo del giornale «Il Manifesto»[16]. Ma soprattutto, Petri venne gradualmente travolto dall’aggressività polemica di una critica che, pur prendendo di mira l’intero fenomeno del cinema politico italiano, scelse proprio l’opera del regista romano come oggetto su cui riversare un’ostilità a volte persino isterica[17]. Negli anni sessanta, infatti, il cinema si era ritrovato di nuovo ben saldo al centro di quella “battaglia delle idee” che animava il dibattito culturale italiano. Tale realtà, quindi, stimolò la nascita di numerose e articolate pubblicazioni che trattavano in modo combattivo e variamente engagé le tematiche e la funzione della settima arte nella società dell’epoca[18]. Questo fermento stilcritico[19] non riuscì però a coagularsi in un fenomeno omogeneo, dato che la critica cinematografica del periodo appariva come un orbe costituito da oggetti testuali contemporaneamente molto diversi e molto simili tra loro. All’interno di questa nebulosa è infatti possibile riconoscere le cosiddette correnti di opinione (la critica dei quotidiani legata ad intellettuali e pubblicisti non direttamente riconducibili alla politica), le correnti di tendenza (la critica delle pubblicazioni legate ai partiti) e infine l’esperienza della “critica militante” (simboleggiata da riviste come «Cinema & Film», «Ombre rosse» e «Filmcritica»), la quale, portando i germi dell’elaborazione teorica e della passione politica in armonia con le tesi del Movimento e della Nuova Sinistra, riuscì a improntare di sé tutto il decennio. Centrale per questi “attivisti della celluloide” era la questione dell’opera autenticamente rivoluzionaria, per cui non bastava trattare tematiche di denuncia, ma occorreva anche veicolarle con strategie comunicative lontane tanto dalle consuetudini produttive (negazione del circuito commerciale), quanto dalle abitudini narrative ed espressive del cinema tradizionale (rivoluzione del linguaggio). Ne conseguiva che il cinema politico italiano (compreso quello “a sinistra”), aderendo in massima parte alle convenzioni industriali e linguistiche del film di buona fattura, fosse in odore di conservatorismo. Questo tipo di impostazione influenzò anche il resto della critica, la quale, quando non assisteva da pigra spettatrice alla controversia, inseguiva l’onda della contestazione aderendo in maniera conformistica alle ipotesi più radicali.
Così, proprio mentre alcune riviste cercavano di definire in maniera quasi scientifica le basi del mestiere dello studioso di cinema, la critica tutta mancava clamorosamente il bersaglio del cinema politico, creando una frattura tra gli autori “impegnati” coinvolti nelle strutture dell’industria cinematografica nostrana e una generazione di censori che si rappresentava in termini di “bisogni” spesso deliranti. E di tale frattura, il caso Petri costituisce senza dubbio il culmine, il sintomo più evidente. L’immagine del cineasta romano che, infatti, si può estrapolare dai testi, dalle recensioni, dalle analisi della critica del periodo è quella di una figura alterata e a suo modo monotona; con tratti ritornanti che la rendono simile ad una caricatura. E sappiamo benissimo che, pur essendo di natura effimera, in stretta analogia col motto di spirito e lo scherzo[20], la caricatura è storicamente un espediente per ritrarre una persona della quale si vogliono amplificare alcuni difetti nella prospettiva ludica e talvolta pure satirica[21]. Una specie di doppio grottesco che mantenendo con l’immagine originale una naturale relazione di identità, attraverso i suoi caratteri così eccessivi, stravolti, ci vuole comunicare qualcosa di preciso. Come sostiene, infatti, l’illustre storico dell’arte viennese Ernst Kris, i segni della deformazione solitamente suggeriscono «l’esistenza di altre idee […] sono gli elementi che svelano la tendenza»[22]. Così, in modo paradossale, le annotazioni più aspre e ritornanti della “burrasca militante”, favoriscono oggi la possibilità di mettere a fuoco un inedito ritratto dell’opera dell’autore romano. Sono i tratti che ci rivelano come il cinema di Petri, proprio perché al di fuori delle coordinate dell’universo stilcritico, sia forse stato in grado di far emergere una ragione e una sensibilità che rappresentavano una sfida alla razionalità e alla sensibilità incorporate nelle istituzioni sociali e culturali dominanti, di attuare quel sovvertimento della coscienza che rientra nelle qualità rivoluzionarie dell’arte. Pertanto, quello stesso atteggiamento censorio, quella maschera grottesca messa dalla critica all’autore romano, gettano anche un fascio di luce sul cinema politico italiano inteso come fenomeno culturale, consentendoci di ripiegare sulle sue tracce per raccoglierne i frammenti e provare a ripristinare l’oggetto perduto.
Se è vero, infatti, che le caricature, le immagini satiriche diffondono impulsi ostili[23], allora tutto fa pensare che le pellicole di Petri, del regista simbolo di quella tendenza, possano essere l’ideale oggetto perturbante per una fruttuosa analisi delle produzioni politicamente impegnate, del cinema definito in modo sprezzante del compromesso linguistico[24]. Il senso di questa formula ci porta a riflettere su quanto fosse inattuabile per la critica dell’epoca l’ipotesi di un discorso politico rivoluzionario incentrato sulle forme espressive e sugli schemi del racconto tradizionale. Il “peccato originale” di Petri, riguardava appunto la sua scelta di inserirsi nel cinema dell’esistente per creare prodotti che alla critica apparivano come buone confezioni, merci perfettamente funzionali all’industria culturale e alle sue esigenze commerciali[25] (addirittura la volontà del regista di instaurare un legame con il pubblico, veniva interpretata nei termini di una conquista di spettatori-clienti). Il tratto distintivo di tale filone, infatti, veniva indicato come un racconto piano, senza sussulti, facilmente “digeribile” dallo spettatore; assai lontano dallo svolgere un discorso articolato e “rivoluzionario”[26]. Prerogative, queste, che non corrispondono minimamente all’opera del cineasta romano, visto che il suo stile è in realtà mai banale o lineare, ma piuttosto straripante, teso a porsi spettacolarmente in primo piano. Il linguaggio di Petri non spicca certo per essere essenziale o per una povertà di soluzioni, giacché a prevalere sono una sovrabbondanza (a volte greve), una frenetica mobilità dello sguardo[27], un suggestivo intento straniante[28], un’accattivante didascalismo, i quali, tramite un repentino e ardito cambiamento di fronte, portarono le sue pellicole ad essere (anche) etichettate come prodotti “griffati” e quindi nuovamente impolitici[29]. Questi repentini mutamenti di opinione, sempre intrisi di ironia (quando non di aggressività), questa incontenibile volontà di marchiare l’opera di Petri per la sua incapacità di far coincidere linguaggio poetico ed enunciato politico, riportano alla mente la proverbiale storiella della volpe e dell’uva, con la critica nel ruolo della prima e la sfuggente identificazione del controverso genere cinematografico in quello della seconda. Troppo intenti a rimarcare i vizi della forma e dei contenuti in rapporto alle nuove virtù dell’ideologia (annullando così ogni considerazione pertinente rispetto al linguaggio e dimostrando che il periodo della contestazione si palesava come un momento di radicalizzazione, piuttosto che di rifondazione di metodologie e pratiche critiche)[30], gli “appunti corsari” dell’epoca, infatti, non hanno, in realtà, colto appieno l’ambiziosa portata della riflessione artistica petriana: mestare nel torbido del discorso politico e collocarsi al suo centro.
Incapace (o non ancora pronta) a superare il limbo formalizzato della politica della rappresentazione, la critica non si è resa conto che il cineasta romano, puntava, invece, alla rappresentazione del politico: ossia alla rappresentazione di quella realtà che concerne la dimensione della vita pubblica nelle sue relazioni con il potere («politico non è tanto ciò che riguarda la società; quanto la configurazione dei rapporti di potere nella vita pubblica…»)[31]. Il cinema petriano, il cui espressionismo risente sia della “scuola desantiana” (come abbiamo visto prima), che di quella esuberanza della scrittura[32], la quale dall’inizio degli anni sessanta si andava affermando in Italia come un codice comune, prende forma, infatti, soprattutto grazie ad un proprio stile figurativo, ad una scelta consapevole di un linguaggio volutamente artefatto. Le basi della sua identità d’autore biasimati come cattivo gusto, kitsch o midcult dalla critica, derivano per l’appunto dall’inclinazione a “teatralizzare” a “spettacolarizzare” il reale del nostro sociale con la chiara intenzione di amplificare i fantasmi del potere che vi si agitano. Da attento studioso dei meccanismi repressivi che tutti portiamo dentro (sia quelli che il potere lo esercitano che i sudditi, dato che ognuno ha la sua fetta di potere e tende ad esercitarla autoritariamente) e che si legano alla richiesta di una continua presenza paterna, carismatica, facendo di noi degli immaturi (o dei bambini in cerca di modelli di comportamento)[33] e in considerazione dell’influenza della figura dell’attore nella nostra cultura, il cineasta ha affermato:
«Se parti dal principio che la società è un teatro, un principio molto elementare, così elementare da sembrar banale, ma che è vero. Allora ti spieghi il perché dei ruoli sociali, e come alcuni ruoli siano più significativi di altri e come la massa si identifichi nei ruoli del potere e così via»[34]
Petri, conscio che il mondo infinito delle forme e delle manifestazioni comiche del teatro popolare, della cultura popolare, si è sempre opposto alla cultura ufficiale e al suo tono serioso e ossequiente, tramite il suo cinema dell’eccesso, all’esibizione del posticcio («mi piace Stroheim molto più di Flaherty. Non mi piacciono i documentari […] C’è il massimo della manipolazione, perché fingono di documentare ciò che non è documentabile se non attraverso un’interpretazione […] Mi piace il barocco e tutto quello che è spettacolo»)[35], è stato l’autore italiano che meglio di altri ha approfondito e delineato la scissione che è presente in ciascuno di noi accostandola alle dinamiche dei rapporti di forza che condizionano la società, suggerendo al contempo a coloro che si trovavano (e si trovano) dall’altro lato dello schermo che, essendo l’attore una proiezione di noi stessi ed il pubblico una proiezione dell’attore, riconoscere l’importanza del ruolo della recitazione, della maschera, nell’ambito della vita quotidiana, significa, forse, riconoscere e accettare la propria condizione umana.
Giancarlo Chiariglione
Consulta il sito uffciale di Elio Petri
Note
[1] I libri dedicati all’autore romano sono oggettivamente pochi e al di là di alcune eccezioni, tendono a proporre un ritratto tutto sommato stereotipo. Tra i contributi italiani che si segnalano per una certa originalità abbiamo la monografia di Rossi (Alfredo Rossi, Elio Petri, La Nuova Italia, 1979), il volume relativo alla retrospettiva organizzata dalla Mostra del cinema di Venezia nel 1983 (a un anno dalla morte del cineasta), curato da Ugo Pirro, il numero monografico de “I quaderni Del Lumière” (Di Martino Anna e Morini Andrea, Elio Petri, Edizioni Ente Mostra Internazionale Del Cinema Libero, Bologna, 11 febbraio 1995), il saggio sulla science-fiction petriana La decima vittima (Lucia Cardone, Elio Petri, Impolitico. La decima vittima (1965), Edizioni ETS, Pisa, 2005), il “DVD + Libro” della Feltrinelli (Stefano Leone, Nicola Guarnieri e Federico Bacci, Elio Petri. Appunti su un autore, Feltrinelli, Milano, 2006) e la raccolta di scritti cinematografici e non, edita recentemente da Bulzoni e curata da Jean A. Gili, Elio Petri, Scritti di cinema e di vita, Bulzoni, Collana Cinema/Studio, Roma, 2007. L’interesse nei confronti dell’autore romano è invece storicamente consolidato in Francia, dato che proprio il famoso critico J. A. Gili, dedicatosi in prevalenza all’analisi del cinema italiano, ha realizzato alcune opere di un certo spessore sul regista romano basate soprattutto su lunghe e articolate interviste (si pensi per esempio a Elio Petri, Facultè des Lettres et Sciences Humanites section d’Histoire, Nice, 1974 ed Elio Petri et le cinéma italien, Editions Les Rencontres d’Annecy, 1996)
[2] Alberto Barbera in Paola Pegoraro Petri (a cura di ), Lucidità inquieta. Il cinema di Elio Petri, Museo Nazionale del Cinema di Torino, Torino, 2007, p.6.
[3] Alfredo Rossi, Elio Petri, La Nuova Italia, 1979, p. 3.
[4] Già nel 1945 il giovane autore segue con attenzione tutti i film proiettati al festival organizzato al cinema romano “Quirino”, rimanendo indelebilmente segnato da Roma città aperta di Roberto Rossellini. A proposito della passione per la settima arte che lo colse in quegli anni, Petri dice «Allora il cinema mi interessava già molto: vedevo anche tre film al giorno; faccio parte della prima generazione veramente cinematografica. In fondo, noi non abbiamo avuto bisogno di scuole tecniche: la grammatica e la sintassi le conoscevamo istintivamente a forza di essere spettatori». Intervista, in Jean A. Gili (sous la direction de), Elio Petri, Université de Nice, 1972, p. 22.
[5] Le candidate, giunte di prima mattina per le prove di selezione, si ritrovarono pigiate come in un tram sulla scala condominiale che conduceva allo studio di un noto avvocato. Le ragazze si spingevano, lottavano tra di loro per non essere sopraffatte dalle più intraprendenti, mentre la ringhiera cedette di schianto facendo precipitare rovinosamente le stesse nella tromba delle scale. Le conseguenze furono settantasette feriti e un decesso. Petri aveva il compito di indagare le motivazioni sociali, psicologiche ed economiche che portarono al disastro, ricostruendo le biografie e le aspettative di vita di ciascuna candidata. E ciò che emerse dai colloqui con le protagoniste e le loro famiglie, più che i sogni e le aspirazioni delle giovani e dei loro congiunti, fu “l’incombenza del reale”, sotto forma della necessità di quattrini. Anche l’avvenimento appariva in tutti lontano (logorato persino nel ricordo); il perché dell’accaduto, le responsabilità, le relazioni tra le ragazze non erano che accidenti, variabili di una storia con un unico, specifico attante: il denaro. La “realtà sociale” aveva determinato la tragedia. Con il titolo Roma ore 11, tale materiale venne pubblicato nel 1956 con una prefazione di Giuseppe De Santis nella collezione “Il gallo”, collana Omnibus, n° 27, per le Edizioni Avanti! (Milano-Roma) e più di recente (2004) da Sellerio.
[6] Con De Santis lavoravano già aspiranti cineasti come Carlo Lizzani e Gillo Pontecorvo.
[7] Un marito per Anna Zaccheo (1953), Giorni d’amore (1954), Uomini e lupi (1956), La strada lunga un anno (1957) e La garçonnière (1960).
[8] Nel 1954 Petri gira un cortometraggio ambientato nel mondo del ciclismo di chiaro impianto documentaristico, intitolato Nasce un campione. L’opera è prodotta da Arturo Zavattini, Pasquale De Santis e dallo stesso autore romano che a tal proposito dice «A quell’epoca girare cortometraggi era una tappa obbligatoria sulla strada dell’apprendistato tecnico-professionale». Nel 1957, lo stesso cineasta realizza invece I sette contadini, un progetto sviluppatosi nell’ambito dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia dedicato alla drammatica vicenda dei fratelli Cervi e sceneggiato da Cesare Zavattini, Luigi Chiarini e Renato Nicolai. Per un approfondimento di questo documentario si leggano gli scritti di Gianni Rondolino e Oreste Del Buono nel saggio di Lino Miccichè, Studi su dodici sguardi d’autore in cortometraggio (Lindau, Torino, 1995).
[9] Alta infedeltà è un film a episodi del 1964 diretto dai registi Franco Rossi (Scandalosa), Luciano Salce (La Sospirosa), Mario Monicelli (Gente moderna) e, appunto, Petri.
[10] Paola Pegoraro, la compagna di Petri, in relazione a questo aspetto racconta «Elio lo conobbi negli anni sessanta e di lui mi colpirono la passione politica, la passione per il cinema, la passione per l’arte moderna, la passione per il jazz, in una parola la passione», Paola Pegoraro Petri (a cura di ), op. cit., p. 9
[11] Ugo Pirro ricorda il dramma di quei momenti «Fu un anno memorabile e triste il 1956, l’invasione sovietica dell’Ungheria colpì al cuore una generazione di militanti comunisti, cambiò profondamente anche Elio che si ritrovò, per così dire, dietro i carri armati sovietici e, nello stesso tempo, davanti alle barricate, accanto ai rivoltosi. […] Tagliato in due dalla passione politica, trafitto, per così dire dalle sue stesse convinzioni, si rosicchiava con ostinazione le unghie fino a farle sanguinare. Parlava, parlava, polemizzava con se stesso e con tutti per vincere la delusione, salvare la passione politica, lavandola dal settarismo cui un po‘ tutti ci eravamo abbandonati in quel dopoguerra straordinario». Ugo Pirro, Il cinema della nostra vita, Lindau, Torino, 2001, p. 19.
[12] «L’Unità» del 25 ottobre 1956 uscì con il titolo «Da una parte della barricata a difesa del socialismo», indicando la rivoluzione del paese magiaro come un «putsch controrivoluzionario» della vecchia Ungheria fascista e reazionaria.
[13] «Città aperta», di fatto un coraggioso esperimento in equilibrio tra ortodossia formale e concreto dissenso, era impegnata nel rinnovamento sociale, morale e culturale dell’Italia. Mossi dall’ideale socialista non inquinato da compromessi riformistici e decisi a contrastare l’arretratezza della società capitalistica italiana, le nebbie del clericalismo e le varie manifestazioni del conformismo borghese, gli autori del periodico esprimevano in sostanza «il desiderio di discutere di tutto, tra comunisti, senza reticenze […]». Nello Ajello, Intellettuali e PCI. 1944-1958, Laterza, Bari, 1979, p. 440.
[14] Enzo Siciliano, falce e pennello, «Corriere della Sera», 21 febbraio 1993.
[15] Callisto Cosulich, Germi, Petri e l’impero del male in «Bianco e nero», LIX, 1 gennaio 1998.
[16] Ugo Pirro, op. cit., p. 109.
[17] Sostiene Gian Piero Brunetta che all’inizio degli anni settanta, vi è uno specifico momento in cui «su Petri tirano tutti la loro palla, come ai baracconi del Luna park. L’esercizio appare facile […] anche se, in non pochi casi, ha un che di canagliesco e maramaldesco», G. P. Brunetta, Storia del cinema italiano dal 1945 agli anni ottanta, Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 696.
[18] Riviste già attive da tempo come «Filmcritica», a partire da 1960 diedero vita ad un nuovo corso ingaggiando collaboratori come Adriano Aprà, Maurizio Ponzi, Stefano Roncoroni e Luigi Faccini. Nel corso di quello stesso decennio nacquero numerose altre testate tra cui «Cinema 60», «Cineforum», «Film Selezione», «Centrofilm», «Cinema & Film» e «Ombre rosse», le quali, pur essendo sovente legate a situazioni locali, fugaci, come afferma Alberto Boschi, attestavano con la loro presenza «la vitalità del dibattito sul cinema», Alberto Boschi, Le nuove riviste, in Giorgio De Vincenti (a cura di), Storia del cinema italiano 1960/1964, vol. X, Marsilio Edizioni Bianco e Nero, Roma, 2001.
[19] La riflessione sul cinema si arricchiva grazie anche alla creazione di manifestazioni come la Mostra del Cinema Libero di Porretta Terme (1960) e la Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro (1965), le quali, con il loro taglio vivace e innovativo, ambivano a contrapporsi a festival storici come la kermesse veneziana. Sui quotidiani, invece, alcuni rubrichisti, pur non appartenendo in senso stretto al circuito degli addetti ai lavori, riuscivano spesso con la loro competenza a dare alle recensioni una dimensione di piccolo e documentato saggio…
[20] Attilio Brilli, Dalla satira alla caricatura. Storia, tecniche e ideologie della rappresentazione, Dedalo, Bari, 1985, p. 194.
[21] Come affermava in merito lo storico dell’arte e politico seicentesco fiorentino Filippo Baldinucci «E caricare dicesi anche da’ pittori o scultori, un modo tenuto da essi in fare ritratti, quanto più somiglianti al tutto alla persone ritratta, ma per giuoco, e talora per ischerno, aggravando e crescendo i difetti delle parti imitate sproporzionatamente. Talmente che nel tutto appariscano essere essi e nelle parti variati», Filippo Baldinucci, Vocabolario toscano dell’arte e del disegno, Firenze, 1681, p. 29.
[22] Ernst Kris, Psychoanalytic Explorations in Art, International University Press, 1952, trad. It. Ricerche psicoanilitiche sull’arte, Torino, Einaudi, 1967, p. 181.
[23] Richard Woodwfield (a cura di), Sentieri verso l’arte. I testi chiave di Ernst H. Gombrich, Leonardo Arte, Milano, 2003, p. 336.
[24] Alfredo Rossi, op. cit. p. 9.
[25] Petri, in realtà, realizzò, anche un film militante, totalmente alternativo, che ebbe una diffusione modesta e sotterranea. Si tratta di Ipotesi su Giuseppe Pinelli, capitolo del lungometraggio Documenti su Pinelli (conosciuto anche come Dedicato a Pinelli), realizzato in reazione alla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, deceduto in circostanze misteriose presso la Questura di Milano il 15 dicembre 1969. Il progetto nacque dopo Piazza Fontana, quando cioè si formò il “Comitato cineasti contro la repressione”. Anche se aderirono al Comitato molti autori appartenenti alle associazioni di categoria ANAC e AACI (che si riunirono in cinque gruppi di lavoro), solo Petri e Nelo Risi portarono a termine il loro film. L’episodio realizzato dal regista romano con l’aiuto di Ugo Pirro, dell’operatore Luigi Kuveiller, e con la partecipazione di Volonté, Di Berti e Renzo Montagnani, ironizza sulle diverse versioni date dalla Questura per giustificare la morte dell’anarchico Pinelli (e avvalorare così la tesi del suicidio). A chi giudica tale opera un caso isolato nella filmografia dell’autore, è d’uopo ricordare che la messa in scena e la scelta della ricostruzione ironica, si inseriscono perfettamente nell’unità poetica del suo percorso artistico. Su tale opera si vedano i testi di Ugo Pirro, op. cit., 1983, p. 70 e op. cit., 2001, p.81.
[26] Recensendo Il maestro di Vigevano, Gian Luigi Rondi disse «i sogni, le proiezioni dei pensieri e dei desideri dei personaggi, per voler restare troppo fedeli alla qualità umana degli stessi personaggi, sono di gusto troppo facile, troppo ingenuo, privi di un vero sapore critico e finiscono per farsi appesantire dagli stessi difetti che vorrebbero mettere alla berlina», G. L. Rondi, Il maestro di Vigevano, «Il Tempo», 27 dicembre 1963.
[27] A tal riguardo, recensendo A ciascuno il suo, Maurizio Ponzi censurò l’uso dello zoom, definito come un obiettivo che dovrebbe «essere controllato dalle autorità, come uno stupefacente. Esso amplifica, sottolinea, schiaccia, deforma, isola […] altera, nel senso letterale della parola, la realtà […] Ciò non è grave […] in un film fantastico […] ma lo è in un film che ispira, al fondo, ad essere di denuncia». Maurizio Ponzi, A ciascuno il suo, «Cinema e film», I,2, primavera, 1967.
[28] Giovanna Grignaffini affermò che Petri aveva messo «comode pantofole al buon Brecht», “Petri e Rosi: timeo Danaos et dona ferentes”, in «Cinema & cinema», III, 7-8, aprile-settembre.
[29] Parlando de La decima vittima, Lino Miccichè sottolinea che la «perizia linguistica e la stessa vivacità stilistica del regista finiscono per trasformarsi in puro ricamo virtuosistico dando […] al film gli orpelli esterni e le effimere eleganze di un prodotto “firmato”», Lino Miccichè in Il cinema italiano degli anni ’60, Venezia, Marsilio, 1975, p. 175.
[30] Adelio Ferrero (coautori Giovanna Grignaffini e Leonardo Quaresima), Il cinema italiano degli anni ’60, Guaraldi, Rimini; Firenze, 1977, p. 5.
[31] Maurizio Grande, Eros e politica. Sul cinema di Bellocchio Ferreri, Petri Bertolucci, P. e V. Taviani, Protagon, Siena, 1995, p. 18.
[32] Barbara Grespi “Modi e mode della rappresentazione”, in Gianni Canova (a cura di), Storia del cinema italiano, 1965/1969, vol. XI, Bianco & Nero-Marsilio, Roma-Venezia, 2002, p. 233 e passim.
[33] Paola Pegoraro Petri, op. cit., 99.
[34] Ellen Cunamo, L’impazienza della macchina da presa, in Ugo Pirro, 1983.
[35] Ibidem