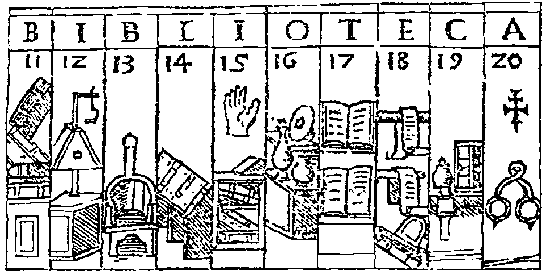Cosimo Quarta (1941-2016) – L’utopia trae le sue origini da una profonda coscienza etica. La perenne tensione tra l’essere e il dover essere è ciò che fa dell’uomo un essere progettuale. Platone nella Repubblica sottolinea a più riprese che il progetto da lui delineato non È impossibile, ma solo difficile da realizzare e aveva fatto della paideia il cardine di ogni rapporto umano. Educare è umanizzare. Umanizzare è liberare. La paideia è la via che conduce alla libertà.
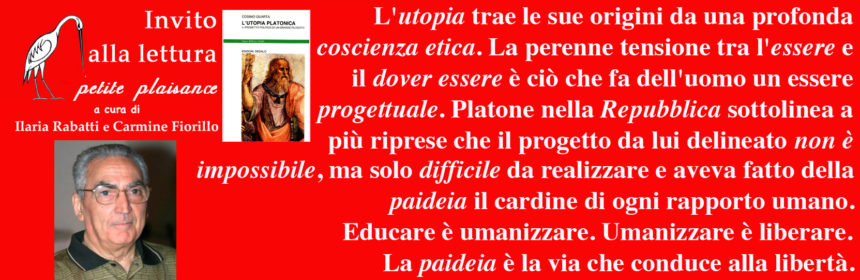
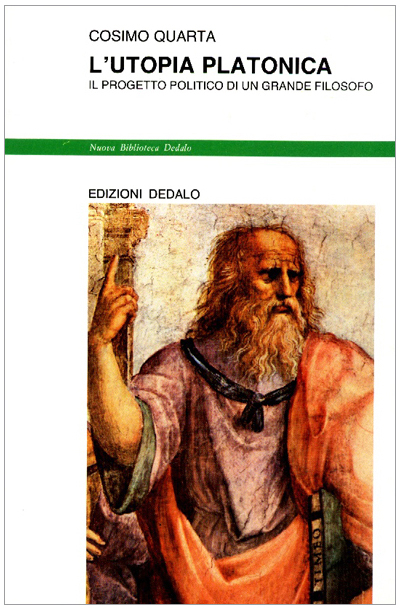
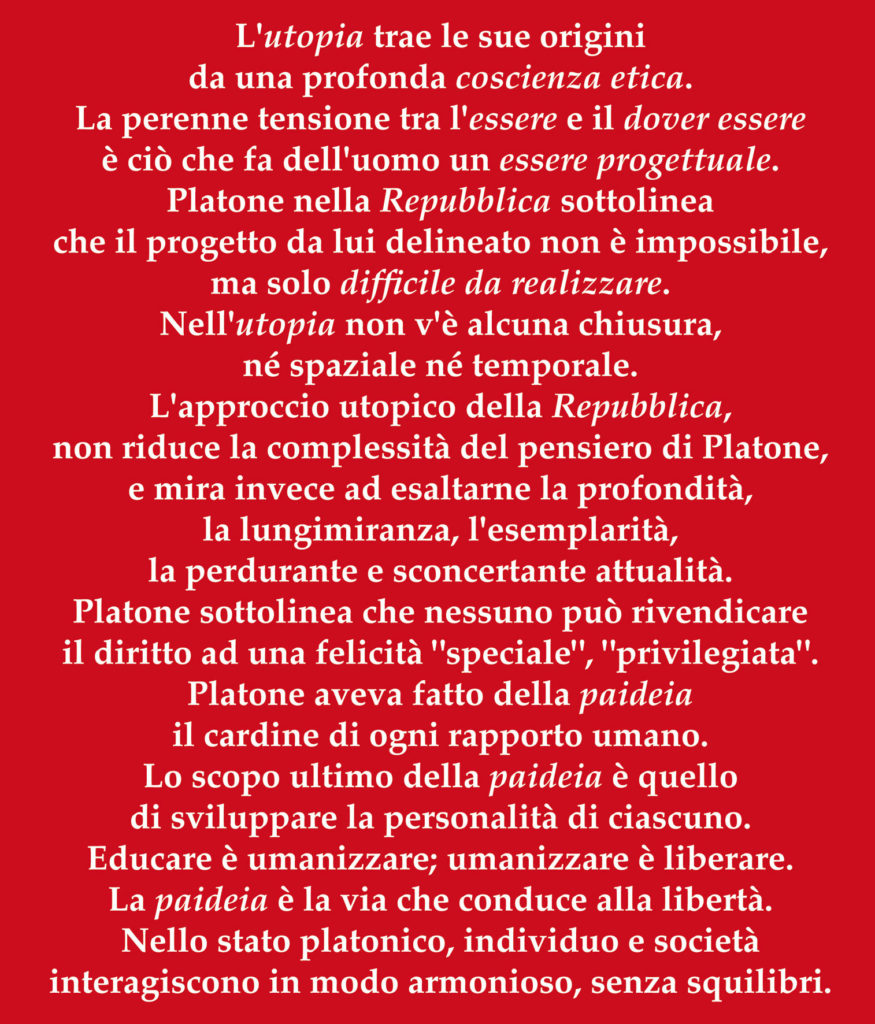
È opportuno chiarire che qui il termine «utopia» (con tutti i suoi derivati) non è usato nel senso comune e banale di sogno, castello in aria, chimera, fantasticheria, gioco letterario; né in quello più impegnativo, ma ugualmente distorsivo, di stato ideale. Partendo dalla nuova parola coniata da Thomas More, è agevole scorgere com’essa oscilli, fin dalle origini, tra ou-topia («non luogo») ed eu-topia («buon luogo»), sicché l’utopia si configura come la «società buona» che «non c’è». Solo che questo suo «non essere» non coincide col nudo «non essere» degli eleati, ma si presenta, per dirla con Ernst Bloch, come un «non essere ancora», nel senso che ha la stessa realtà e consistenza di un progetto. L’utopia, dunque, è il progetto della società buona che non è ancora, e che proprio per questo gli uomini sono protesi a realizzare.
Ora il progetto nasce sempre da un bisogno; e il bisogno implica una carenza d’essere, esprime cioè la presa di coscienza che la realtà di fatto, il mondo in cui ci si ritrova a vivere, non soddisfa adeguatamente le profonde esigenze umane. Donde, appunto, il protendersi degli uomini verso realtà nuove e diverse, ritenute idonee a soddisfare i loro fondamentali bisogni di libertà, sicurezza, pace, giustizia, eguaglianza, fraternità, amore. Questi bisogni sono sempre stati presenti lungo la storia, anche se espressi in forme varie e molteplici. In questo senso essi sono fondamentali, ossia primordiali, radicati nella natura umana ab origine. Anzi sono proprio essi a costituire, in certo modo, l’essenza specifica dell’uomo, a farne cioè, come ho detto altrove, un homo utopicus, un essere cioè proteso a realizzare il suo dover essere, ch’è poi l’«umanità» e la società in cui vivere «umanamente»: la società giusta e fraterna.
Questa perenne tensione tra l’essere e il dover essere è ciò che fa dell’uomo un essere progettuale. Ma progettando e realizzando se stesso, l’uomo, proprio perché originariamente dimensionato di socialità, progetta e realizza anche la storia. E nell’incontro-scontro di questi esseri progettanti che sono gli uomini, l’utopia s’invera e diventa il progetto della storia. Non v’è infatti generazione che non abbia tentato non solo di elaborare, ma anche di realizzare, in qualche modo, il suo progetto di umanità e di società. I modi e i criteri di tale elaborazione sono stati certo diversi sul piano della consapevolezza teorica e dell’efficacia storica (miti, favole, messaggi di salvezza, progetti filosofici, prassi politica e rivoluzionaria), ma tutti ugualmente significativi sotto il profilo antropologico.
L’utopia non nasce dunque, come generalmente si crede, da una coscienza ludica, ma trae le sue origini da una profonda coscienza etica. È l’insostenibilità delle condizioni presenti che spinge gli uomini ad elaborare un progetto o, comunque, a prefigurare uno stato di cose diverso da quello in cui essi vivono. L’utopia nasce sotto l’urgenza della prassi, ossia dietro la spinta di bisogni concreti e, in quanto tale, è ben lungi dall’essere qualcosa di «astratto», come opinano molti dei suoi detrattori. L’accusa di «astrattezza» deriva il più delle volte dal fatto di aver confuso l‘utopia con l’ideale. Infatti, mentre uno dei caratteri fondamentali dell’ideale è quello di essere irrealizzabile per principio, l’utopia si caratterizza invece come progetto teso alla realizzazione. Ciò che del resto era stato già chiarito da Platone quando nella Repubblica sottolineava a più riprese che il progetto da lui delineato non era impossibile, ma solo difficile da realizzare; notando al tempo stesso come le difficoltà di realizzazione derivassero fondamentalmente dallo scarto che inevitabilmente s’interpone tra teoria e prassi.
Occorre inoltre rilevare che il «meglio» o l’«ottimo» che il pensiero utopico persegue non è il «meglio» o l’«ottimo» in senso assoluto, ma solo in senso relativo; ossia è il «meglio» che gli uomini di quella determinata società e di quel determinato tempo sono riusciti o riescono a scorgere. Nell’utopia non v’è quindi alcuna chiusura, né spaziale né temporale. Essa, infatti, non si chiude in se stessa, isolandosi dalla realtà circostante, ma è aperta al mondo, a ciò che di meglio il mondo produce. La tensione verso un futuro migliore non significa negazione della tradizione, del passato-presente. L’utopia se da un lato rifiuta quanto d’ingiusto e di negativo il presente contiene, dall’altro raccoglie e sviluppa tutto quello che di positivo le generazioni passate ci hanno tramandato. Ogni generazione, come si diceva, ha il suo progetto utopico, le cui istanze però, e le relative realizzazioni, dipendono dalle condizioni storiche di fatto. Sicché, ciò che una generazione non riesce a realizzare viene ripreso e istanziato dalle successive. E in questo processo dialettico tra le generazioni o, ciò che è lo stesso, tra passato, presente e futuro, consiste la storia; la quale, almeno per quanto in essa v’è di positivo, può essere a ragione considerata come il prodotto dell’utopia.
Vista in questa luce, l’utopia si presenta come la molla dell’agire umano e, insieme, come il motore della storia. Se poi, come spesso capita, gli uomini utilizzano questo motore per tornare indietro invece che per spingersi in avanti, allora questa forza potente che muove la storia, proprio perché ha mutato segno e direzione, dev’essere chiamata con un nome diverso da quello di utopia. In tal caso, infatti, ci si trova di fronte alla distopia, ossia ad un progetto di società perversa; una forza altrettanto potente con cui l’utopia da sempre si scontra e che è causa non secondaria del lento scorrere dei processi storici, e quindi dei ritardi nella maturazione della coscienza storica. La confusione tra utopia e distopia ha indotto non pochi critici, tra cui Popper, a caratterizzare il pensiero utopico in termini di illiberalità, intolleranza, massificazione, totalitarismo, violenza ecc., generando così numerosi fraintendimenti che, com’è noto, hanno colpito anche Platone.
L’approccio utopico, ossia la rilettura in chiave storico-macrostorica dei testi platonici che questo libro propone, lungi dal ridurre la complessità e problematicità del pensiero di questo grande maestro, mira invece ad esaltarne la profondità, la lungimiranza, l’esemplarità e, ultima ma non per importanza, la perdurante e, per certi aspetti, sconcertante attualità. Platone è attuale non solo perché, come tutti i veri «classici», ha parlato e continua a parlare agli uomini di ogni tempo e luogo, ma anche perché in non pochi passaggi delle sue opere lo sentiamo come un «contemporaneo», come uno che vive in mezzo a noi ed è gravato dai nostri medesimi problemi. Basti, a dimostrazione di ciò, un solo piccolo esempio tratto dalla Lettera settima (325 cd): «Vedendo questo, e osservando gli uomini che allora si dedicavano alla vita politica, e le leggi e i costumi, quanto più li esaminavo ed avanzavo nell’età, tanto più mi sembrava che fosse difficile partecipare all’amministrazione dello stato, restando onesto» (tr. il. A. Maddalena, Bari, 1971; il corsivo è mio). Un brano, questo, che s’attaglia assai bene a quel che accade oggi, soprattutto in Italia, dove disonestà, corruzione, affarismo, hanno infangato la politica, trasformandola da «attività eroica» in attività criminale. Di qui l’urgenza di ridare alla politica il suo autentico ruolo. E su questo Platone può darci ancora utili suggerimenti.
[…] Platone non trascurava affatto la felicità dei singoli. La sua preoccupazione era quella che lo stato diventasse uno strumento per il perseguimento della felicità dei «pochi». Infatti, egli dice, «il fine propostoci nel fondare lo stato» non è quello di far sì che una sola categoria di cittadini sia «particolarmente felice», ma quello di assicurare all‘intero stato il massimo possibile di felicità.[1] Come si vede, Platone è ben lungi dal negare ai cittadini del suo stato, in quanto singoli, la felicità . Ciò che egli vieta è che nessun cittadino o gruppo di cittadini goda di una felicità tutt’affatto «speciale», «straordinaria», rispetto agli altri. Se i critici di Platone non avessero sorvolato sul ruolo e significato che il termine «speciale» (diapherontos) assume per una corretta interpretazione del passo in questione, molti equivoci si sarebbero potuti evitare.
Qui Platone sottolinea che, di fronte alla felicità, tutti i cittadini sono uguali; e che nessuno, quale che sia la propria funzione nello stato, può rivendicare il diritto ad una felicità «speciale», «privilegiata». Lo stato esiste perché tutti e non solo alcuni siano il più possibile felici. Era questa una concezione dello stato talmente avanzata che nemmeno Aristotele riuscì a coglierne lo spirito, né tanto meno l’enorme portata utopica. […] Platone enuncia e sancisce proprio questo principio: il diritto di tutti alla felicità senza discriminazione veruna. I «custodi-reggitori» non saranno infelici, ma avranno la loro parte di felicità (e d’infelicità), «per quanto è possibile, nella stessa misura degli altri».[2] E di ciò si contentino. Lo «stato giusto», se vuole essere e conservarsi tale, non può permettere che i suoi «custodi-reggitori» approfittino delle funzioni che la comunità ha loro assegnato per procurarsi una felicità «speciale»; poiché così facendo il «tutto» verrebbe asservito a una sola «parte», stravolgendo l’ordine delle cose. Lo stato cesserebbe in tal modo d’essere una comunità politica e si trasformerebbe in una consorteria di privati, o meglio, in una giungla, dove i più potenti o i più furbi sottometterebbero i più deboli e onesti in vista del loro esclusivo tornaconto.
Si potrebbe a questo punto obiettare: ma questa felicità, cui tutti nello «stato giusto» hanno diritto, in che cosa propriamente consiste? E inoltre: i «custodi-reggitori», che attingono i gradi più alti del sapere, possono essere felici allo stesso modo degli altri cittadini, la cui natura non ha permesso loro di elevarsi ai fastigi della scienza? La risposta al primo quesito non presenta particolari difficoltà, dal momento che Platone ha sempre sostenuto, dai suoi primi scritti fino alle Leggi, che la vera felicità consiste nella virtù, ossia nel possesso della saggezza, della temperanza, della giustizia.[3]
[…] Platone, da un lato, riconosce nei filosofi-reggitori il più alto livello di umanità, proprio a causa della loro sapienza, che li pone in grado di conoscere «l’idea del bene», dall’altro, egli dice pure, come s’è già visto, che tale sapienza, se non è accompagnata dalla giustizia, non è affatto virtuosa. I filosofi-reggitori sono virtuosi soprattutto perché sono «giusti»; e sono «giusti» perché, obbedendo al principio del ta eautou prattein, non si limitano a contemplare il « bene» da loro speculativamente raggiunto, ma devono anche saper usare di questa loro «scienza del bene», dato che per Platone la felicità non si consegue attraverso il possesso dei «beni» […], ma mediante la capacità di usarne rettamente.[4] Ora, l’unico modo che i filosofi-reggitori hanno di usare correttamente, ossia di mettere in pratica la loro sapienza, che è appunto «scienza del bene», è quello di ridiscendere nella «caverna», ossia di impegnarsi concretamente nel governo della polis. In tal modo essi divengono «giusti», cioè virtuosi e, quindi, felici. Al pari degli altri cittadini, i quali, se vogliono essere felici, devono anch’essi usare rettamente dei beni in loro possesso, quali che siano. Se, infatti, la scienza è «lo strumento che procura il retto uso e la buona fortuna», allora, dice Platone, è necessario che «tutti gli uomini … s’impegnino … a divenire quanto più e possibile sapienti …».[5]
Tutti gli uomini, quindi, e non solo alcuni, per essere felici, devono acquisire quel grado di sapienza che consenta loro di svolgere al meglio possibile la funzione sociale per cui sono più adatti. […]
Come avrebbe potuto pensare, d’altronde, di eliminare la « personalità individuale »un autore come Platone che aveva fatto della paideia il cardine di ogni rapporto umano? E qual è lo scopo ultimo della paideia se non quello di sviluppare la personalità di ciascuno? Educare è umanizzare; umanizzare è liberare. La paideia è la via che conduce alla libertà. È vero che nella Repubblica il problema della libertà non viene affrontato in maniera organica; di tale problema infatti si parla solo per fugaci accenni. Ma come poteva Platone escludere dal suo modello «primo», dal suo stato «giusto» e «perfetto» la libertà e istanziarla invece nello «stato secondo» e «imperfetto» descritto nelle Leggi […]? […] Come avrebbe potuto Platone, acuto indagatore e profondo conoscitore dell’animo umano e del suo insopprimibile anelito di libertà, concepire uno stato che fosse in netto contrasto con quelle profonde esigenze umane per la cui crescita e soddisfazione, del resto, lo stato stesso è nato e ha senso?
La considerazione platonica dell’individuo non fa mai astrazione dalla comunità alla quale egli appartiene e in cui vive e convive. Nello stato platonico, individuo e società interagiscono in modo armonioso, senza squilibri. […] Un chiaro esempio di come Platone trattasse con pari dignità individuo e società, senza alcuna propensione a far prevalere l’una a scapito dell’altro, o viceversa, è dato da Repubblica, IV, 441 c-d, in cui, alternativamente, stato e individuo vengono considerati modelli l’uno dell’altro. Per non parlare poi di quelle profonde ed eloquenti pagine dei libri VIII e IX, dove trasformazioni costituzionali e trasformazione dei caratteri individuali procedono in perfetta sintonia, senza squilibri e sfasature.
Se dunque […] per Platone lo stato non è «tutto», nel senso che non è il «fine» assoluto cui la persona si rapporterebbe come puro «mezzo», occorre tuttavia guardarsi dal cadere nell’errore opposto; affermando cioè che nella Repubblica l’individuo è «il prius rispetto allo stato».[6] Questa ipotesi, infatti, al pari della precedente, poggia su basi alquanto labili. […] Il problema dei rapporti stato-individuo non può essere risolto ricorrendo a categorie del tipo prius-posterius. Poiché in tal modo si corre il rischio di falsare gli stessi termini del problema.
In che senso, infatti, l’individuo può essere il prius? Non certo sul piano fisico, ontologico; dov’egli si presenta chiaramente come il «risultato» della volontà o, comunque, dell’azione procreatrice dei genitori e, quindi, come posterius. L’individuo può forse considerarsi il prius sul piano etico? Anche su questo piano il problema si presenta tutt’altro che semplice. Certamente, una norma diviene etica nel momento in cui s’impone alla coscienza, o meglio, nel momento in cui la coscienza la riconosce e liberamente l’accetta come vincolo insuperabile, ossia come un «imperativo» cui si ispira la «massima» che guida il proprio «agire». In questo senso la norma etica, in quanto scaturente da un processo interiore è senz’altro un fatto individuale, anzi si rivela come il fatto individuale per eccellenza. E tuttavia rimane pur sempre, al tempo stesso, un fatto sociale, dal momento che si tratta di una libera (e perciò etica) accettazione di una norma preesistente all’individuo, nel senso ch’egli la « riconosce» (prima ancora di accettarla e farla propria) perché la «trova», per così dire, già in qualche modo operante nel contesto di società-storia in cui vive.
[…] Proprio perché sociali tali «valori» hanno la loro prima radice nella volontà delle singole persone che formano appunto la società. La norma morale, oggettiva e universale, non è un misterioso a priori, un dettame della «pura ragione» di cui si ignora la genesi, ma è un risultato storico, ossia il prodotto della convergenza di una pluralità di singole volontà verso un obiettivo comune: la salvezza e il progresso dell’umanità. Cioè dell’uomo in quanto specie, non in quanto singolo. Un patrimonio (culturale, certo, non genetico) che gli uomini di ieri hanno lasciato alle generazioni presenti le quali, a loro volta, hanno il «dovere» di trasmetterlo, migliorato, a quelle future. Poiché è in tal modo appunto che l’umanità si va costruendo.
[…] Se il problema dei rapporti stato-individuo s’imposta in termini di prius e di posterius, invece di avvicinarsi alla soluzione dello stesso ci si allontana. Stato e individuo non possono essere considerati secondo un prima e un dopo, perché essi non sono entità distinte e contrapposte. La società non è altro che l’insieme degli individui che la compongono, mentre l’individuo, a sua volta, non può essere concepito se non come membro di una società. Al di fuori di ogni rapporto sociale l’individuo umano semplicemente non sussisterebbe come tale. Affermare che l’individuo è il «prius rispetto allo stato» sarebbe come dire che l’individuo è il prius rispetto alla specie. Il che, evidentemente, sarebbe privo di senso dato che l’individuo è, per dirla con Kierkegaard, «in ogni momento … se stesso e la specie».[7]
Cosimo Quarta, L’utopia platonica. Il progetto politico di un grande filosofo, Edizioni Dedalo, Bari 1993, pp. 7-7, 240-247.
***
[1] Platone, Repubblica, IV, 420 b-e. Il medesimo concetto è ribadito a VII, 520 e, e anche altrove. Che Platone mirasse a rendere «veramente felice» ogni cittadino del suo «ottimo stato», lo aveva già riconosciuto un critico piuttosto severo del pensiero politico platonico come R.H. Crossman, Plalo Today, London, 1937, p. 111.
[2] Aristotele, Politica, II, 1264 b 22-24. È opportuno osservare che in altro luogo Aristotele affermerà, come Platone, che uno stato è felice non se una sola classe è felice, ma se tutti i cittadini lo sono. Cfr. Ivi, VII. 1329 a 22-24.
[3] Cfr., tra gli altri, Alcibiade primo, 134 b -135 e; Gorgia, 493 b-d; 506 d – 508 a; Repubblica, V, 621 c-d e passim; Leggi, II, 661 d – 663a; anche V, 732 d – 734 e.
[4] Eutidemo, 280 a – 282 a.
[5] Eutidemo, 282 a.
[6] M. Isnardi Parente, Socrate e Platone, p. 245.
[7] S. Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, tr. it., Firenze, 1968, p. 33.
Cosimo Quarta – L’uomo è un essere progettuale. Il progetto spinge a impegnarsi per cambiare lo stato di cose presente. La carenza di progettazione sociale è segno di fuga dalla vita, perché realizzare il fine richiede impegno, dedizione, pazienza, sofferenza, sacrificio.
Cosimo Quarta – Se manca solo uno di questi momenti (critico, progettuale, realizzativo), non si dà coscienza utopica, e anzi, non si dà coscienza autenticamente umana.
Cosimo Quarta – Il bisogno di progettare, nell’uomo, non è un fatto accidentale, ma essenziale, in quanto corrisponde alla sua originaria natura. Il progettare è possibile ed ha senso solo in presenza e in vista del futuro. La “fame di futuro” è fame di progettualità, ossia bisogno forte e urgente di utopia, il cui strumento privilegiato è la progettualità.
Cosimo Quarta – Non può costruirsi una società comunitaria senza un’azione parallela mirante a trasformare contemporaneamente le condizioni esterne e le coscienze. Perché vi sia autentica comunità occorre sviluppare una coscienza comunitaria. Il principio fondamentale che regge l’intero edificio comunitario di Utopia è proprio l’humanitas, ossia la coscienza del valore e della dignità degli uomini, di tutti gli uomini, e del loro comune destino.