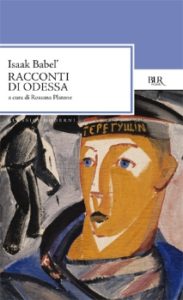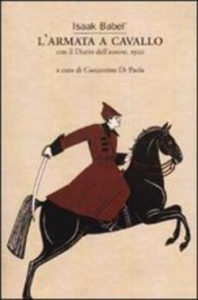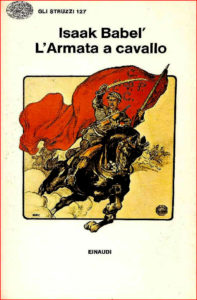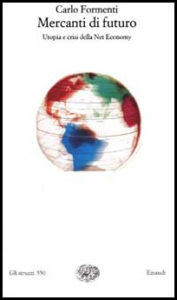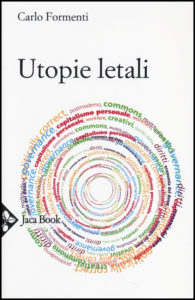Fernanda Mazzoli
Una voce poetica dimenticata: Isaak Ėmmanuilovič Babel’
Fondare la rivoluzione sull’anima umana,
sulla sua aspirazione al bene, alla verità,
al pieno dispiegarsi delle sue facoltà.
La rivoluzione non può negare il sabato – la spiritualità, l’esperienza interiore dell’uomo, i suoi fondamenti morali – a costo di non sapersi più distinguere dai suoi nemici e finire per distruggere, come aveva colto Camus nel suo L’homme révolté, nello stesso tempo uomini e principi.
Leggere l’impaginato di otto pagine in PDF cliccando qui:
Fernanda Mazzoli, Isaak Emmanuilovič Babel’

Isaak Babel’
Precoce fu la passione per i libri di Isaak Babel’ (13 luglio 1894, Odessa, Ucraina / 27 gennaio 1940, Prigione di Butyrka, Mosca, Russia). Gli accesero l’immaginazione e gli regalarono una fertile inventiva con la quale alterare «tutte le cose del mondo», fino a non sapere più distinguere fra realtà e fantasia e ingannare se stesso e chi voleva ascoltarlo con le sue avvincenti storie. Leggeva sempre, ricorda in un suo racconto (Nel sottoscala, 1930), «durante le lezioni, nelle ricreazioni,lungo la strada di casa,di notte, a tavola», e per un libro rinunciava a tutti i divertimenti condivisi dai compagni, dalle fughe da scuola per bighellonare al porto, alle partite di bigliardo nei caffé, alle nuotate nel fiume che attraversava Odessa. A causa dei libri, e della bizzarria che a loro e all’ambiente familiare doveva, non aveva amici: «E chi poteva aver voglia di frequentare un tipo simile?». La solitudine lo seguirà come un’ombra discreta nascosta nelle pieghe di una vita avventurosa, compagna muta tra i compagni dell’armata a cavallo, fino al silenzio degli ultimi anni, quando l’assalto al cielo tentato dai bolscevichi era precipitato nelle secche della normalizzazione stalinista.

Isaak Babel’
Che non gliene sarebbe venuto niente di buono dalla sua passione per i libri, la madre, con una sensibilità tutta ebraica per le sventure, lo aveva presagito e proprio nel momento in cui una brillante carriera sembrava attendere il figlio. Il giovane Isaak era stato ammesso alla classe preparatoria del ginnasio, superando la bassissima soglia del cinque per cento riservata agli Ebrei. Mentre il padre, come impazzito dalla gioia, chiusa la bottega, si era precipitato a comperargli un berretto da ginnasiale, la madre «intuiva il destino nei miei occhi e mi guardava con amara pietà, perché lei sola sapeva quanto fosse sfortunata la nostra famiglia» (La storia della mia colombaia, 1925).
Correva l’anno 1905, anno di moti rivoluzionari che portarono alla creazione della Duma, anno di disordini che non di rado sfociavano in pogrom contro la comunità ebraica ed il decenne Isaak si trovò nel bel mezzo di uno di questi e vi perse il nonno, massacrato dai russi, e la «colomba color ciliegia», regalatagli dal padre come premio per l’ammissione e schiacciata dal venditore ambulante Makarenko che colpisce il bambino, scagliandolo a terra, e gli uccelli appena presi al mercato. «Da ragazzo ho desiderato ardentemente di possedere una colombaia: in tutta la vita non ho avuto desiderio più forte. Avevo dieci anni quando mio padre promise di darmi il denaro per l’acquisto di un’assicella e di tre coppie di colombi». Costruita la colombaia e avuto il denaro promesso, il mattino del 20 ottobre Isaak, malgrado le fucilate che echeggiavano in città, corse al mercato venatorio e comperò finalmente gli agognati colombi, ma «in qualche luogo lontano cavalcava la sfortuna su un gran cavallo» e il ragazzo si ritrovò a terra, insanguinato dalle viscere dell’uccello schiacciato. «Il tenero intestino del colombo strisciava sulla mia fronte, ed io chiusi l’occhio che m’era rimasto ancora aperto perché non vedesse il mondo che mi si stendeva davanti. Quel mondo era piccolo e orribile».
Distrutto il negozio del padre, nascosto con i genitori in casa di amici russi per tutta la durata del pogrom, il bambino contrsse una malattia nervosa che richiese il suo allontanamento dalla cittadina di Nikolaev per luoghi più salubri. Così, si imbarcò con la madre per Odessa, dove era nato dieci anni prima, nella Moldavanka – il ghetto ebraico – e si stabilì in casa del nonno paterno, rabbino cacciato dalla sua città per contraffazione di cambiali, stravagante inventore, erudito straccione e pazzo agli occhi dei concittadini.
A Odessa studiò all’Istituto commerciale dove ebbe la fortuna di incontrare uno straordinario insegnante di francese, un bretone, che gli insegnò la lingua e l’amore per la letteratura del suo paese, al punto che scrisse i suoi primi racconti, che poi butterà via, giudicandoli incolori, in quella lingua. Fino al sedicesimo anno, su insistenza del padre, studiò anche l’ebraico, la Bibbia, il Talmud e il violino, ma agli esercizi musicali preferiva la lettura di Turgenev e di Dumas e, strimpellando per ingannare il padre che si era messo in testa di fare di lui un violinista di successo, divorava le pagine dei romanzi posti sul leggio. Intanto, scriveva di notte le storie che raccontava di giorno ai ragazzi dei vicini.

Antonina Pirozhkova e Isaac Babel’.

Isaak Babel’ con Antonina e la figlia.
Più tardi, la Moldavanka, con la sua vita rumorosa, i suoi tuguri abitati da un’umanità dedita a bizzarri traffici, i suoi banditi generosi e trucidi, diventerà il teatro di molti suoi racconti che – ricostruendo con vivacità e un tocco d’umorismo l’ambiente della prima giovinezza – ripercorrono, in realtà, il maturare della sua vocazione letteraria, a cui attribuisce un’origine familiare, nella somiglianza che avverte con il nonno mezzo pazzo, autore di un’autobiografia in ebraico dal significativo titolo L’uomo senza testa.
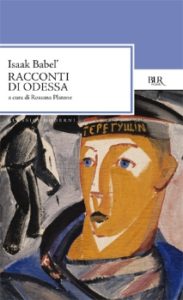
Racconti di Odessa
Altro mentore di quegli anni fu un singolare abitante della Moldavanka, correttore di bozze di un giornale di Odessa, nonché «filosofo della scuola naturalistica» che gli consigliò, dopo avere letto una tragedia che il quattordicenne Babel’ gli aveva sottoposto a giudizio, di immergersi nella natura, come una pietra o come un animale, se davvero aveva l’intenzione di scrivere qualcosa che valesse la pena.

Racconti proibiti e lettere intime, Feltrinelli, 1961

Cronache dell’anno 1918
Qualche anno più tardi, sarà Gorkij – che pubblicherà nel 1916 i suoi primi racconti, rifiutati da molti giornali –, a dargli un consiglio decisivo: di andare fra la gente, come ricordò lo scrittore in una breve ed intensa Autobiografia, pubblicata per una rivista nel 1924. E per sette anni – anni che sconvolsero il mondo – Isaak Babel’ andò fra la gente, si immerse nel turbine della Rivoluzione, lasciò che il suo universo poetico maturasse lentamente nel fragore, nel caos, nella stanchezza e nel fervore della guerra rivoluzionaria, fra un attacco e un ripiegamento e si facesse strada al passo dei cavalli dell’Armata cosacca di Budënnyj che, agli ordini del nuovo potere sovietico, respinse fin quasi a Varsavia i Polacchi che avevano conquistato Kiev.

L’Armata a cavallo. Titolo originale: Конармия.
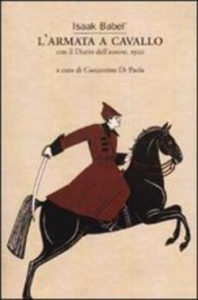
L’armata a cavallo
Anni turbinosi per la Russia e per il giovane Babel’: soldato sul fronte rumeno nel 1917, prestò servizio nell’anno seguente nella Ceka e al commissariato del Popolo per l’istruzione, combattè nell’armata del Nord e poi nella Prima armata di Cavalleria, strano soldato dall’aria poco marziale, piccolo, occhialuto, con la sacca piena di manoscritti e giornali. Lavorò come tipografo ad Odessa e fu cronista a Pietroburgo e nell’anno 1923 riprese a scrivere, dopo avere imparato ad esprimere i suoi pensieri «con chiarezza e in forma sintetica», come se «i sogni impossibili» e le «canzoni dissonanti» che covava in sé dall’ infanzia si fossero asciugati nelle notti all’addiaccio, dilaniate «dal latte della luna» o nella polvere e nel fumo delle battaglie che avevano incendiato la pianura polacca «levigata come un asse». La guerra rivoluzionaria, il contatto diretto con gli eventi e gli uomini avevano finito per mettere le briglie alle «tempeste» della sua immaginazione , affinatasi e sublimatasi in un tirocinio linguistico – che si affiancò all’esistenziale – all’insegna della concisione.
L’asciuttezza del cronista si compenetra senza sforzo con il lirismo del poeta che ha saputo trovare «il senso della natura», raccontata per squarci improvvisi, di grande efficacia pittorica, capaci di fondere il movimento dell’Armata a cavallo con il dispiegarsi dei campi di papaveri e il gioco del «vento di mezzogiorno tra la segale gialligna». Dilaga l’armata cosacca nella steppa, tutt’attorno cadaveri e villaggi distrutti, e intanto «il sole arancione rotola nel cielo, come una testa recisa, una tenera luce s’accende nelle fenditure delle nubi, svettano sulle nostre teste gli stendardi del tramonto. Il lezzo del sangue di ieri e dei cavalli uccisi geme nel fresco della sera». Come un fiume in piena, l’armata continua la sua marcia verso Novograd e al sole succede la luna che si adagia sulle onde del nero Zbruč che i cosacchi sono costretti a guadare, non essendoci più ponti.
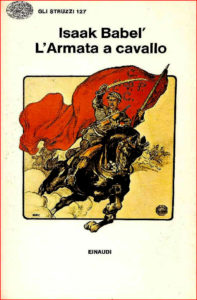
L’Armata a cavallo
È così che si apre il primo dei racconti che compongono l’opera più nota di Isaak Babel’ e che introduce il lettore in un mondo sconvolto dalla guerra e dalla rivoluzione, eroico e crudele, capace di grande coraggio e smisurate speranze, così come di spietate azioni e meschini sentimenti. Le «orde pezzenti» che si rovesciano sulle antiche città polacche portano con sé il vento impetuoso del nuovo mondo che i bolscevichi stanno cercando faticosamente di costruire, ma anche la violenza cieca e la sete di vendetta e la brama di saccheggio di ogni esercito. Per quanto sia arrivato l’ordine di Trotskij di non scannare i prigionieri, ma di sottoporli a regolare processo, sul fronte le passioni degli uomini esacerbati dalle lunghe privazioni, dalle perdite subite, dai traditori annidati in ogni villaggio, hanno spesso la meglio sui richiami alla nuova legalità rivoluzionaria e, semplicemente, all’umana pietà. Il nostro narratore, assegnato allo stato maggiore della divisione come corispondente, si vede più di una volta costretto a compilare rapporti di denuncia di azioni banditesche, che porteranno i colpevoli davanti al tribunale di guerra.

L’armata a cavallo
È la lucida consapevolezza di stare vivendo una storia grande e terribile a fare de L’Armata a cavallo un’opera epica, nel senso più alto: scevra da ogni retorica, da ogni compiacimento, da ogni intento agiografico. Il giovane Isaak, andato fra la gente e buttatosi a capofitto nel tumulto della guerra e della rivoluzione, sia per intima adesione alle ragioni di questa, sia per trovare se stesso in quanto scrittore, mette a segno quell’immissione di «realismo quotidiano nella sublimità tragica» che, secondo Auerbach, caratterizza la grande epica omerica. E così, mentre combatte con la cavalleria cosacca, condividendo con i suoi compagni fatiche, stenti, pericoli, «la cronaca dei misfatti quotidiani» lo opprime «senza posa come un vizio di cuore». È lo sterminio delle api, di cui sono stati profanati gli alveari intossicati dallo zolfo, ma anche gli stupri di gruppo, i saccheggi delle chiese, le esecuzioni sommarie per un sospetto di tradimento. Il cronista-combattente di Odessa tiene un diario minuzioso, da cui poi svilupperà i suoi racconti, in cui compare sotto il nome di Ljutov, e non nasconde nulla, né a sé stesso, né al lettore. I compagni dell’armata a cavallo non sono eroi esemplari, sono uomini capaci di eroismo e di ferocia, una massa in movimento sui «binari precipitosi» che il partito bolscevico ha aperto «nella pasta acida delle storie russe», sospinti dalla marcia frenetica di una storia che corre più veloce di loro, ancora incrostati dalla scorie di un passato che sa di servitù, sopraffazione, pregiudizi, «ansimante crudeltà contadina». Dunque, Babel’-Ljutov decide di assumere pienamente, senza infingimenti e romantiche illusioni, «la curva misteriosa della retta di Lenin», che ha scagliato in prima fila la comunità cosacca e che da quelle scorie saprà liberarla, come osserva sentenziosamente Galin che lavora con lui al giornale del fronte.

Semen Budennyj, il popolare e combattivo comandante dell’Armata a cavallo.
Non piacquero questi racconti al generale Budënnyj che accusò l’autore di avere denigrato l’Armata che aveva comandato, dando prova di sraordinario coraggio e capacità decisionale che lo scrittore non mancò di riconoscere, cogliendo nel suo «sorriso abbagliante» e nelle sue scarne parole la grandezza del personaggio, nuovo tipo di condottiero popolare. Mentre nomina un comandante di brigata, il generale, che deve l’incarico alla sua non comune audacia, si limita a dirgli, sorridendo: «Il serpente ci attanaglia. Si vince o si crepa! Non c’è altra via, hai capito?», e lo minaccia, sempre sorridendo, di fucilarlo, se scappa. Budënnyj, naturalmente, ha ragione: è con uomini come lui che si vincono le rivoluzioni e Babel’ è il primo a riconoscerlo, ma sa altrettanto bene distinguere tra propaganda e letteratura e non sarà mai disposto a sottomettere l’una all’altra, fino a preferire il silenzio negli anni dello stalinismo trionfante.
È nel racconto forse più struggente di tutta la raccolta, Gedali, fantastico, diafano e malinconico come un dipinto di Chagall, che «la sublimità tragica» vissuta dal narratore e da milioni di uomini con lui, si staglia con icastica evidenza. A Gedali, padrone di una botteguccia nel ghetto ebraico della cittadina polacca di Žitomir, studioso del Talmud e di Maimonide, nonché fondatore di una impossibile Internazionale, soddisfatto che la rivoluzione le abbia suonate ai cani malvagi degli antisemiti, ma tuttavia preoccupato perché i fucili continuano a sparare, il narratore risponde che la rivoluzione «non può fare a meno di sparare». È un’Internazionale impossibile, quella di Gedali e il combattente dell’Armata a cavallo, spinto verso di lui alla vigilia del sabato dalla «densa malinconia dei ricordi», non si fa illusioni in merito e non ne offre al suo bizzarro interlocutore. Tuttavia, ne è affascinato e non solamente per un richiamo della tradizione in cui è stato cresciuto: sono la sua intelligenza e la sua sensibilità di rivoluzionario a confrontarsi con le parole dello strambo vecchio. Lui accoglie la rivoluzione, ma accoglie anche il sabato ed è deluso che la rivoluzione mandi avanti solo i fucili. Sparavano i polacchi e sparano i rivoluzionari e questo lui non lo capisce, perché «la rivoluzione è gioia. E alla gioia non piace avere orfani in casa». Gedali non sa più dove è la rivoluzione e dove la controrivoluzione. Lui vuole «un’Internazionale di brava gente» e che «sia tesserata ogni anima e le assegnino una razione di prima categoria. Prendi, anima, mangia e ricevi dalla vita il tuo godimento!». E invece, rincara Gedali, loro ignorano completamente con quale companatico si mangi l’Internazionale …
Il redattore del Krasnyj Kavalerist – il giornale del fronte – ha bello offrirgli con spavalderia il suo companatico: «polvere da sparo» da innaffiare «con il sangue migliore», perché la sua pronta e un po’ scontata risposta si deve far da parte per lasciare avanzare il sabato, «un sabato fanciullo» che «dall’azzurra oscurità saliva in cattedra».
Pagina straordinaria, e per la qualità della scrittura – incisiva, sognante e densa, intimamente aderente a luoghi e personaggi – e per la sconvolgente lucidità che si annida nelle parole di Gedali sotto l’incalzare delle immagini. Parole profetiche, ad un secolo dall’Ottobre la cui demiurgica ambizione è ripiegata nella costruzione di quel «socialismo reale» che, nonostante indubbi meriti, non ha certo realizzato le promesse di emancipazione che mobilitarono milioni di uomini in Russia e nel mondo intero. Non è certo questa la sede per anche solamente accennare ad un bilancio dell’esperienza della rivoluzione bolscevica che ha segnato una svolta epocale, ineludibile. Ritengo, però, che l’esaurirsi della sua spinta ideale e il crollo miserevole dell’Unione sovietica, le cui macerie hanno finito per trascinare con sé – almeno per i più – l’idea stessa della possibilità di una società non fondata sui rapporti di produzione capitalistici, rinserrando più che mai gli uomini nella gabbia d’acciaio dell’attuale sistema sociale, possano essere lette (e corrette in un futuro che abbiamo il dovere di immaginare diverso dall’attuale presente “senza storia”) anche alla luce delle considerazioni del bizzarro rigattiere di Žitomir che vuole fondare la rivoluzione sull’anima umana, sulla sua aspirazione al bene, alla verità, al pieno dispiegarsi delle sue facoltà. La rivoluzione non può negare il sabato – la spiritualità, l’esperienza interiore dell’uomo, i suoi fondamenti morali – a costo di non sapersi più distinguere dai suoi nemici e finire per distruggere, come aveva colto Camus nel suo L’homme révolté, nello stesso tempo uomini e principi. Ma nella steppa nel 1920 la rivoluzione è ancora giovane, muove i suoi primi passi, impetuosi, sgraziati, commoventi e pieni di promesse e Afonka Bida, capoplotone di Babel’-Ljutov, può ancora ritenere di stare combattendo anche per le api «sterminate dagli eserciti in lotta».
Pochi rapidi tratti, battute essenziali ed incisive, capaci di restituire in un’istantanea un uomo e uno sprazzo della sua verità, il coraggio sfrontato con cui si presenta al mondo, o la sua disperazione, o la sua tenace convinzione: si susseguono pagina dopo pagina i compagni di lotta, gesti e parole scorrono in un grande ritratto corale che è quello dell’armata in perpetuo nomadismo, scandito dal «lamento dei convogli», dagli spari, dai gemiti dei feriti, dai nitriti dei cavalli.
Sfilano davanti al lettore il giovane comandante di brigata Kolesnikov, dalla cui andatura Babel-Ljutov riconosce «l’indifferenza imperiosa del chan tartaro», il caposquadra Chlebnikov che guarda il mondo «come un prato di maggio», appassionato di cavalli e che per un cavallo che gli è stato preso abbandona il partito, Ilija, figlio ribelle del rabbino di Žitomar, agitatore e poeta che nella sacca da soldato tiene i ritratti di Lenin e Maimonide e muore di tifo «tra i versi, il filatterio e le pezze da piedi». E il mite pastore Saška, cantore dello squadrone, che con le sue canzoni «lastricava di suoni e lacrime le nostre strade estenuanti», Sidorov, inetto al combattimento dopo una ferita, che cerca scampo dalla «zampa pelosa della sua angoscia», sognando l’Italia che gli è entrata nel cuore come un’ossessione e dove sta covando un fuoco che lui potrebbe attizzare, il capoplotone Surokov con il suo curioso paragone fra Lenin e la gallina, entrambi capaci di tirare fuori dal mucchio e prendere al primo colpo, il primo la verità, l’altra i chicchi di grano. E il fabbro Baulin, «forte, laconico, ostinato» caposquadrone poco più che ventenne, che non ha mai conosciuto la frivolezza, incrollabile sulla strada che ha intrapreso, incurante delle privazioni, al punto da potere dormire seduto: uno di quegli uomini – sottolinea lo scrittore – decisivi per il trionfo della Rivoluzione.
Uomini semplici, non di rado rozzi, ma consapevoli, e fieri di essere al centro di un esperimento senza precedenti nella storia dell’umanità: il governo operaio-contadino, il primo nel mondo, per il quale vale la pena battersi e resistere alla fame, al freddo, alla nostalgia di casa, al dolore per i compagni uccisi e per i cavalli cui i Cosacchi sono legati da un vincolo di fraterna amicizia. Con questi uomini Isaak Babel’ attraversa gli anni della guerra rivoluzionaria, con loro condivide le costanti privazioni e gli improvvisi entusiasmi, per un attacco riuscito, per un discorso di Lenin o un volantino di Trotskij, con loro scopre la fraternità, intorno ad un misero pasto messo in comune, ad un giaciglio sotto un fienile, alle note pensose di una canzone e a un gesto di compassione per il cadavere di un nemico. Bagliori che si accendono nell’ombra vischiosa di una solitudine che non smette di accompagnare Babel’-Ljutov: difficoltà di farsi accettare – lui, intellettuale ebreo dal portamento poco marziale dai bellicosi e rustici Cosacchi – certamente, eredità del ghetto, forse, oppure conseguenza di un’inguaribile propensione alla malinconia e alla fantasticheria, contratta nell’infanzia; comunque sia, la solitudine gli aleggia intorno, «nel deserto polveroso e arroventato dei campi», «sotto l’instancabile pioggia galiziana», nella notte pronta a volargli incontro «su cavalli focosi».
È proprio il riuscito e mai banale intreccio tra ispirazione lirica ed epopea collettiva a fare de L’Armata a cavallo un’opera singolare ed autentica, in cui senso della storia e sentimento dell’umana condizione si fondono in una soluzione linguistica originale, capace di abbracciare con naturalezza registri molto diversi in un fluire incessante che sposa il ritmo incalzante della neonata rivoluzione.

Copertina della rivista del Fronte di Sinistra delle Arti (LEF), 1923, litografia
Diversi racconti, poi inclusi nel libro, vennero pubblicati nel 1924 sulla prestigiosa rivista Lef, diretta da Majakovskij; ad essi ne seguiranno altri, dedicati alla città di Odessa, ed alcune commedie. Dieci anni dopo, al primo congresso degli scrittori sovietici, Babel’ si definì ironicamente maestro del genere letterario del silenzio.

LEF
Qualcuno, nel frattempo, non aveva mancato di incolparlo di formalismo e scarsa produttività. Intervenne ancora l’anno successivo al Congresso internazionale antifascista degli scrittori, tenutosi a Parigi; poi, sempre più estraneo al clima politico e culturale imposto dallo stalinismo, finì per ritirarsi dalla vita pubblica e chiudersi in un definitivo silenzio, di fronte agli esiti di una rivoluzione che non aveva saputo – o potuto – conciliare Budënnyj e Gedali e si stava arenando nell’impasse di una nuova autocrazia. Come altri comunisti della prima ora, sarà accusato di spionaggio e arrestato e come loro confesserà crimini inesistenti: cedimento di fronte alle pressioni poliziesche, forse, disperazione, impotenza, senso del fallimento – sicuramente e, nel più profondo, un’oscura, tenace e tragica fedeltà, fino all’autoannientamento, a quel governo primo nel mondo che l’Armata a cavallo aveva contribuito a fare trionfare.

La foto di Babel’ eseguita dal NKVD dopo il suo arresto
Processato e condannato, sarà fucilato sul finire del gennaio 1940. I suoi archivi e manoscritti, confiscati, sono andati perduti. Sarà pubblicamente riabilitato nel 1954 dalle accuse che gli costarono la vita.
Fernanda Mazzoli
Le citazioni sono prese da Isaac Babel’, L’armata a cavallo e altri racconti, Feltrinelli, Milano, 1976, trad. dal russo di Ignazio Ambrogio, Filippo Frassati e Maria Olsoufieva.
Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word
 Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.
Seguici sul sito web


![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 16-03-2018)