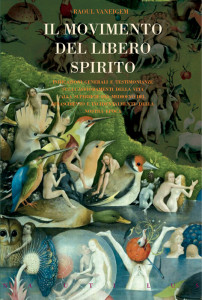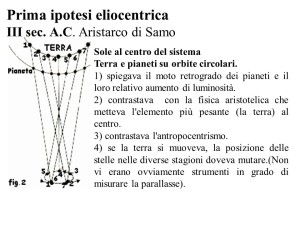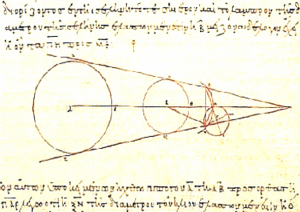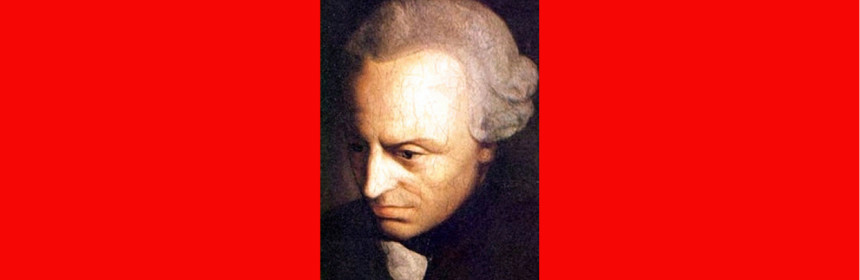È sovente citata, quando si vuole sollecitare una presa di posizione da parte di qualcuno, l’affermazione evangelica di Gesù secondo la quale “chi non è con me, è contro di me” (Mt 12, 30; Lc 11, 23). A tal proposito, va detto che è sicuramente bene prendere posizione in favore o contro una determinata tesi, se si ritiene di avere risolto il problema che ne sta alla base, oppure se si ritiene di avere buoni argomenti in favore o contro la tesi stessa. Questo contribuisce all’avanzamento della conoscenza. Tuttavia, l’atteggiamento sintetizzabile con il motto “o con me o contro di me”, il quale prescinde da una adeguata argomentazione, è un atteggiamento fideistico – in cui cioè si richiede di prendere posizione “a prescindere” –, non filosofico.Atteggiamenti fideistici e atteggiamenti filosofici vanno nettamente distinti, essendo i primi, in filosofia, non auspicabili.
Per operare questa distinzione è molto utile la dialettica aristotelica, che costituisce la prima elaborazione compiuta della tendenza, propriamente greca, ad ascoltare, prima di prendere posizione, tutte le opinioni rilevanti su un determinato argomento, per poter poi decidere con maggiore consapevolezza. Al risultato, infatti, la filosofia insegna che si deve arrivare alla fine, non all’inizio della analisi; saremmo altrimenti di fronte, appunto, a una posizione fideistica, dogmatica, non filosofica.
La dialettica greca insegna che nessuno è depositario della intera verità, bensì che da tutti si può imparare. Aristotele scrisse in merito, nella Metafisica (993 a 30-b4), che “la contemplazione della verità è in un certo senso difficile, ma in un altro facile. Un segno di ciò è il fatto che nessuno individualmente la coglie in modo adeguato, né tutti sbagliano, ma ognuno dice qualcosa riguardo alla natura delle cose: e mentre ognuno di noi contribuisce poco o nulla alla verità, una considerevole parte di essa risulta da tutti i nostri contributi”. Coloro che si sono dedicati al sapere – anche coloro che hanno espresso tesi sbagliate – andrebbero ringraziati per Aristotele, poiché hanno comunque trasmesso, con la loro riflessione, l’abitudine a pensare.
L’atteggiamento fideistico, contrariamente a quanto si è soliti ritenere, non è solo quello religioso. La fede più diffusa oggi, in Occidente, consiste ad esempio nella insostituibilità del modo di produzione capitalistico. Vi sono inoltre, in ambito culturale, molte microforme di fede laiche praticamente impermeabili alla dialettica. Personalmente, ne ho fatto esperienza – evito i riferimenti polemici, poiché la filosofia deve sempre avere a cuore i contenuti generali – alcuni mesi fa. Scrissi un articolo di alcune pagine critico nei confronti degli argomenti, a mio avviso poco progettuali, dei cosiddetti “no euro”, ossia dei sostenitori della necessità di uscire dall’euro e dalla UE. Lo proposi a uno studioso che conosco da tempo, noto sostenitore delle tesi “no euro”, come testo di discussione per il suo sito, molto seguito e incentrato appunto su questa tematica. La risposta ricevuta, grosso modo, fu che il testo, benché interessante, non sarebbe stato pubblicato in quanto contrario alle tesi sostenute nel sito, che evidentemente dovevano andare in una sola direzione.
Il testo è stato pubblicato altrove (lo si trova attualmente, col titolo ironico Euro si, Euro no, sul sito www.petiteplaisance.it, in cui sono raccolti molti miei articoli). La cosa da rilevare è però come molti gruppi, siti, riviste, blog, anche di derivazione accademica, comportandosi in questo modo mostrino di essere rivolti non alla ricerca della verità, ma alla mera autoconferma identitaria. Essi contravvengono in questo modo, peraltro senza rendersene conto, a una indicazione filosofica primaria, in base a cui per prendere posizione adeguatamente in merito a un determinato tema, occorre sempre confrontarsi con tutte le opinioni rilevanti su di esso. Se non lo si fa, ci si pone – utilizzo sempre una metafora aristotelica – nella posizione di un giudice che, convinto a priori della colpevolezza di un imputato, si rifiuti di ascoltare le tesi della difesa: così facendo, egli contravviene all’etica insita nella propria funzione giudicante. Ebbene: una filosofia che si pone solo come parte, senza ascoltare realmente le argomentazioni della parte avversa, e soprattutto senza porsi nell’orizzonte dell’intero, cessa immediatamente di essere filosofia, e si riduce a fede.
La filosofia non si incentra dunque sul motto “o con me o contro di me”, ma sostiene – se mi è lecito forgiare un nuovo slogan – che si è con noi tanto più quanto si è contro di noi, poiché chi critica le tesi che argomentiamo ci aiuta o a rafforzarle (se sono vere), o a emendarle (se sono false). In questo senso, in filosofia, esercitando la critica dialettica chi è apparentemente contro di noi sta in realtà con noi, e al contempo sta con tutti gli altri, e non sta contro nessuno: perché sta dalla parte della verità, e dunque anche del bene.
Luca Grecchi
Immagine in evidenza: The Chess Players, Thomas Eakins, 1876.
Scarica il testo in PDF
Luca Grecchi,
Chi non è con me è contro di me?
Riflessioni sulla dialettica
Già pubblicato su “Diogene.it Magazine” del 04-02-2016.

Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word

N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.
Dello stesso autore nel Blog di Petite Plaisance:

Luca Grecchi (1972), direttore della rivista di filosofia Koinè e della collana di studi filosofici Il giogo presso la casa editrice Petite Plaisance di Pistoia, insegna Storia della Filosofia presso la Università degli Studi di Milano Bicocca. Da alcuni anni sta strutturando un sistema onto-assiologico definito “metafisica umanistica”, che vorrebbe costituire una sintesi della struttura sistematica della verità dell’essere. Esso rappresenta, nella sua opera, la base teoretica di riferimento sia per la fondazione di una progettualità sociale anticrematistica, sia per la interpretazione dei principali pensieri filosofici. Grecchi è soprattutto autore di una ampia interpretazione umanistica dell’antico pensiero greco, nonché di alcuni studi monografici su filosofi moderni e contemporanei, e di libri tematici su importanti argomenti (la metafisica, la felicità, il bene, la morte, l’Occidente). Collabora con la rivista on line Diogene Magazine e con il quotidiano on line Sicilia Journal. Ha pubblicato libri-dialogo con alcuni fra i maggiori filosofi italiani, quali Enrico Berti, Umberto Galimberti, Costanzo Preve, Carmelo Vigna.
Libri di Luca Grecchi

L’anima umana come fondamento della verità (2002) è il primo libro di Grecchi, che pone, in maniera stilizzata, il sistema metafisico umanistico su cui sono poi strutturati i suoi libri successivi. La tesi centrale di questo libro è appunto che l’anima umana, intesa come la natura razionale e morale dell’uomo, è il fondamento onto-assiologico della verità dell’essere. Questo sistema metafisico costituisce la base per una analisi critica della attuale totalità sociale, e per una progettualità comunitaria finalizzata alla realizzazione di un modo di produzione sociale conforme alle esigenze della natura umana. (Invito alla lettura: Scarica alcune pagine del libro)
Karl Marx nel sentiero della verità (2003) costituisce una interpretazione metafisico-umanistica del pensiero di Marx, che viene analizzato nei suoi nodi essenziali, spesso in aperta critica con la secolare tradizione marxista. Nato originariamente come elaborazione degli studi di economia politica dell’autore compiuti negli anni novanta del Novecento, il testo assume carattere filosofico-politico. Marx è analizzato come il pensatore moderno che, rifacendosi implicitamente al pensiero greco, realizza la migliore critica al modo di produzione capitalistico, pur non elaborando – per carenza di fondazione filosofica – un adeguato discorso progettuale.
Verità e dialettica. La dialettica di Hegel e la teoria di Marx costituisce in un certo senso una integrazione del precedente Karl Marx nel sentiero della verità. Il testo effettua una sintesi originale, appunto, sia della dialettica di Hegel che della teoria di Marx. Pur riconoscendo l’influenza del pensiero di Hegel nelle opere del Marx maturo, Grecchi propone la tesi che il pensiero di Marx, strutturatosi nei suoi punti cardinali prima del suo studio attento ed approfondito della Scienza della Logica, sia nella sua essenza non dialettico. Una versione sintetica di questo libro è stata pubblicata sulla rivista Il Protagora nel 2007.
La verità umana nel pensiero religioso di Sergio Quinzio (2004) con introduzione di Franco Toscani, è una sintesi monografica sul pensiero del grande teologo scomparso nel 1996. Il testo presenta al proprio interno una analisi del pensiero ebraico e cristiano, unita ad una rilettura poetica ed umanistica del testo biblico. Il tema centrale è quello della morte, e della speranza nella resurrezione su cui Quinzio ripetutamente riflette, e che vede continuamente delusa. Al di là dei riferimenti religiosi, la riflessione del teologo si presta ad una profonda considerazione sulla fragilità della vita umana.
Nel pensiero filosofico di Emanuele Severino (2005) con introduzione di Alberto Giovanni Biuso, è una sintesi monografica sul pensiero del grande filosofo italiano. Il testo presenta al proprio interno una analisi critica del nucleo essenziale della ontologia di Severino e delle sue analisi storico-filosofiche e politiche. Esiste uno scambio di lettere fra Severino e Grecchi in cui il filosofo bresciano mostra la sua netta contrarietà alla interpretazione ricevuta. Il testo, tuttavia, è segnalato nella Enciclopedia filosofica Bompiani come uno dei libri di riferimento per la interpretazione del pensiero severiniano.
Il necessario fondamento umanistico della metafisica (2005) è un breve saggio in cui, prendendo come riferimento la metafisica classica (ed in particolare le posizioni di Carmelo Vigna), l’autore critica la centralità dell’approccio logico-fenomenologico rispetto al tema della verità, ritenendo necessario anche l’approccio onto-assiologico. Per Grecchi infatti la verità consiste non solo nella descrizione corretta di come la realtà è, ma anche di come essa – la parte che può modificarsi – deve essere per conformarsi alla natura umana. Si tratta del primo confronto esplicito fra la proposta di Grecchi della metafisica umanistica e la metafisica classica di matrice aristotelico-tomista.
Filosofia e biografia (2005) è un libro-dialogo composto con uno dei maggiori filosofi italiani, Umberto Galimberti. Nel testo si ripercorre il pensiero galimbertiano nei suoi contenuti essenziali, ma si pone in essere anche una serrata analisi di molti temi filosofici, politici e sociali, in cui spesso emerge una sostanziale differenza di posizioni fra i due autori. Di particolare interesse le pagine dedicate al pensiero simbolico, all’analisi della società, ed alla interpretazione dell’opera di Emanuele Severino. Percorre il testo la tesi per cui la genesi di un pensiero filosofico deve necessariamente essere indagata, per giungere alla piena comprensione dell’opera di un autore.
Il pensiero filosofico di Umberto Galimberti (2005), con introduzione di Carmelo Vigna, è un testo monografico completo sul pensiero di questo importante filosofo contemporaneo. Si tratta di un testo in cui Grecchi, sintetizzando la complessa opera di questo autore, prende al contempo posizione non solo nei confronti della medesima, ma anche di filosofi quali Nietzsche, Heidegger, Jaspers, che nel pensiero di Galimberti costituiscono riferimento imprescindibili. Vigna, nella sua introduzione, ha definito il libro «una ricostruzione seria ed attendibile del pensiero del filosofo» in esame.
Conoscenza della felicità (2005), con introduzione di Mario Vegetti, è uno dei testi principali di Grecchi, in cui l’autore applica il proprio approccio classico umanistico alla società attuale, mostrando come essa si ponga in radicale opposizione alle possibilità di felicità. L’autore, seguendo la matrice onto-assiologica del pensiero greco, mostra che solo conoscendo che cosa è l’uomo risulta possibile conoscere cosa è la felicità. Scrive Vegetti, nel testo, che Grecchi è «pensatore a suo modo classico», per il suo «andar diritto verso il cuore dei problemi». Il libro è assunto come riferimento bibliografico, per il tema in oggetto, dalla Enciclopedia filosofica Bompiani. .
Marx e gli antichi Greci (2006) è un libro-dialogo composto con uno dei maggiori filosofi italiani, Costanzo Preve. Nel testo viene effettuata una analisi non tanto filologica, quanto ermeneutica e teoretica dei rapporti del pensiero di Marx col pensiero greco. I due autori, concordando su molti punti, colmano così in parte una lacuna della pubblicistica su questo tema, che risulta essere stato nel tempo assai poco indagato. Di particolare interesse l’analisi effettuata dai due autori di quale potrebbe essere, sulla base insieme del pensiero dei Greci e di Marx, il miglior modo di produzione sociale alternativo rispetto a quello attuale. (Invito alla lettura: Scarica alcune pagine del libro)
Vivere o morire. Dialogo sul senso dell’esistenza fra Platone e Nietzsche (2006), con introduzione di Enrico Berti, è un saggio composto ponendo in ideale dialogo Platone e Nietzsche su importanti temi filosofici, politico e morali: l’amore, la morte, la metafisica, la vita ed altro ancora. Scrive Berti, nella sua introduzione, che, come accadeva nel genere letterario antico dell’invenzione, Grecchi non nasconde lo scopo “politico” della sua opera, la quale «risulta essere innanzitutto un documento significativo di amore per la filosofia e di vitalità di quest’ultima, in un momento in cui l’epoca della filosofia sembrava conclusa».
Il filosofo e la politica. I consigli di Platone, e dei classici Greci, per la vita politica (2006) è una ricostruzione del pensiero filosofico-politico di Platone effettuata in un continuo confronto con le vicende della attualità. In questo libro Grecchi pone esplicitamente Platone, in maniera insieme divulgativa ed originale, come proprio pensatore di riferimento. Il filosofo ateniese infatti, a suo avviso, pur scrivendo molti secoli or sono, rimane tuttora colui che ha offerto le migliori analisi, e le migliori soluzioni, per pensare una migliore totalità sociale, ossia un ambiente comunitario adatto alla buona vita dell’uomo.
La filosofia politica di Eschilo. Il pensiero “filosofico-politico” del più grande tragediografo greco (2007) costituisce una interpretazione, in chiave appunto filosofico-politica, dell’opera di Eschilo. Lo scopo principale di questo libro è quello di “togliere” Eschilo dallo specialismo degli studi poetico-letterari, per inserirlo – come si dovrebbe fare per tutti i tragici greci – nell’ambito del pensiero filosofico-politico. Nel testo viene presa in carico l’analisi precedentemente svolta da Emanuele Severino ne Il giogo (1988), ritenendone validi molti aspetti ma giungendo, alla fine, a conclusioni opposte circa il presunto “nichilismo” di Eschilo.
Il presente della filosofia italiana (2007) è un libro in cui vengono analizzati testi di alcuni fra i più importanti filosofi italiani contemporanei pubblicati dopo il 2000. Gli autori analizzati vengono ripartiti in quattro categorie: 1) pensatori “ermeneutici-simbolici” (Sini, Vattimo, Cacciari, Natoli); 2) pensatori “scientifici-razionalisti” (Tarca, Antiseri, Giorello); 3) pensatori “marxisti-radicali” (Preve, Losurdo); 4) pensatori “metafisici-teologici” (Reale). Il testo è arricchito da due appendici e da una ampia postfazione di Costanzo Preve. In questi testi Grecchi oppone criticamente, ai vari approcci, il proprio discorso metafisico-umanistico.
Corrispondenze di metafisica umanistica (2007) è una raccolta di testi in cui sono contenuti scambi epistolari, nonché risposte di Grecchi ad introduzioni e recensioni di suoi libri. Il testo rispecchia la tendenza dell’autore a prendere sempre seriamente in carico le altrui posizioni; secondo Grecchi, infatti, di fronte a critiche intelligenti, sono solo due gli atteggiamenti filosofici possibili: o fornire argomentate risposte, o prendere atto della correttezza delle critiche e rivedere le proprie posizioni. Il tema caratterizzante il testo è dunque la “lotta amichevole” per la emersione della verità.
L’umanesimo della antica filosofia greca (2007) è un libro in cui Grecchi effettua, in sintesi, la propria interpretazione complessiva della Grecità. Partendo da Omero, e giungendo fino al pensiero ellenistico, l’autore mostra come non la natura, né il divino, né l’essere furono i temi principali del pensiero greco, bensì l’uomo, soprattutto nella sua dimensione politico-sociale. L’uomo infatti assume centralità, in vario modo, in tutti i vari filoni culturali della Grecità, dal pensiero omerico a quello presocratico, dal teatro fino all’ellenismo.
L’umanesimo di Platone (2007) è un testo monografico sul pensiero di Platone, da Grecchi in quegli anni ritenuto come il più rappresentativo della Grecità. Ponendo in essere una analisi complessiva delle diverse interpretazioni finora effettuate del pensiero platonico, Grecchi applica al medesimo il proprio paradigma ermeneutico metafisico-umanistico, cogliendo in Platone la centralità del ruolo filosofico-politico dell’uomo, ed insieme la centralità della posizione anti-crematistica, all’interno di una considerazione progettuale e della totalità sociale.
L’umanesimo di Aristotele (2008) è un testo monografico sul pensiero di Aristotele, che sarà poi da Grecchi ripreso negli anni successivi come struttura teoretica di riferimento. Ponendo in essere una analisi complessiva delle diverse tematiche del pensiero aristotelico, Grecchi applica al medesimo il proprio paradigma ermeneutico metafisico-umanistico, cogliendo in Aristotele – così come in Platone, ma in forma differente – la centralità del ruolo filosofico-politico dell’uomo, ed insieme la centralità della posizione anti-crematistica, all’interno di una considerazione progettuale della totalità sociale.
Chi fu il primo filosofo? E dunque: cos’è la filosofia? (2008), con introduzione di Giovanni Casertano, è un libro suddiviso in due parti. Nella prima parte, prendendo come riferimento alcuni fra i principali manuali di storia della filosofia italiani, Grecchi mostra come essi spesso non definiscano l’oggetto del loro studio, ossia la filosofia, dichiarandola talvolta addirittura indefinibile. L’autore, invece, offre in questo libro la propria definizione di filosofia come caratterizzata da due contenuti imprescindibili: a) la centralità dell’uomo; b) la ricerca, il più possibile fondata ed argomentata, della verità dell’intero. Nella seconda parte l’autore esamina dieci possibilità alternative su “chi fu il primo filosofo”, giungendo a concludere che, pur all’interno del contesto comunitario della riflessione greca, il candidato più accreditato risulta essere Socrate.
Socrate. Discorso su Le Nuvole di Aristofane (2008) è una ricostruzione di fantasia, pubblicata nella collana Autentici falsi d’autore dell’editore Guida, di un discorso che avrebbe potuto essere tenuto da Socrate ad Atene l’indomani della rappresentazione della famosa commedia di Aristofane. Si tratta, come è nello stile della collana, di una ricostruzione al contempo verosimile e spiritosa, in cui Grecchi coglie l’occasione per offrire la propria interpretazione, insieme umanistica ed anticrematistica, del pensiero socratico. Tale interpretazione risulta convergente con quelle offerte, nella medesima collana, da Mario Vegetti su Platone e da Enrico Berti su Aristotele.
Occidente: radici, essenza, futuro (2009), con introduzione di Diego Fusaro, è un testo in cui l’autore analizza il concetto di Occidente e le sue tradizioni culturali costitutive, sempre in base al proprio sistema metafisico-umanistico. Analizzando le radici greche, ebraiche, cristiane, romane e moderne, ma soprattutto l’attuale contesto storico-sociale, Grecchi coglie nella prevaricazione derivante dalla smodata ricerca crematistica l’essenza dell’Occidente, ed individua per lo stesso un futuro cupo. Il testo è arricchito dal dialogo con Fusaro, alla cui introduzione Grecchi risponde in una appendice finale.
Il filosofo e la vita. I consigli di Platone, e dei classici Greci, per la buona vita (2009), è una raccolta di brevi saggi in cui l’autore, prendendo spunto da alcuni passi del pensiero platonico, e più in generale del pensiero greco classico, affronta sinteticamente alcune tematiche centrali per la vita umana (l’amore, la famiglia, la filosofia, la storia, le leggi, la democrazia, l’educazione, l’università, la mafia, la libertà, ecc.), col consueto approccio attualizzante, ovvero facendo interagire – nel rispetto del contesto storico-sociale dell’epoca in cui tale pensiero nacque – il pensiero platonico col nostro tempo. Il libro è arricchito da un lungo saggio finale di Costanzo Preve, intitolato “Luca Grecchi interprete dei filosofi classici Greci” (con risposta), in cui il filosofo torinese sintetizza le posizioni dell’autore.
L’umanesimo della antica filosofia cinese (2009) costituisce il primo volume di una trilogia sull’umanesimo dell’antico pensiero orientale (l’unica nel nostro paese effettuata da un solo autore). Il libro parte dalla constatazione che l’Oriente risulta essere pressoché assente dalle principali storie della filosofia occidentali. Tuttavia, in base alla definizione di filosofia fornita dall’autore, l’antico pensiero cinese risulta possedere, nei contenuti e talvolta anche nei metodi, caratteristiche tali da non poter essere considerato pregiudizialmente assente dal quadro filosofico. Non si tratta, comunque, di un manuale di storia della filosofia cinese, ma di una interpretazione umanistica dei principali contenuti costitutivi dell’antico pensiero cinese.
L’umanesimo della antica filosofia indiana (2009) costituisce il secondo volume di una trilogia sull’umanesimo dell’antico pensiero orientale. Il libro parte dalla constatazione che l’Oriente risulta essere pressoché assente dalle principali storie della filosofia occidentali. Tuttavia, in base alla definizione di filosofia fornita dall’autore, l’antico pensiero indiano risulta possedere, nei contenuti e talvolta anche nei metodi, caratteristiche tali da non poter essere considerato pregiudizialmente assente dal quadro filosofico. Non si tratta, comunque, di un manuale di storia della filosofia indiana, ma di una interpretazione umanistica dei principali contenuti costitutivi dell’antico pensiero indiano.
L’umanesimo della antica filosofia islamica (2009) costituisce il terzo volume di una trilogia sull’umanesimo dell’antico pensiero orientale. Il libro parte dalla constatazione che l’Oriente risulta essere pressoché assente dalle principali storie della filosofia occidentali. Tuttavia, in base alla definizione di filosofia fornita dall’autore, l’antico pensiero islamico risulta possedere, nei contenuti e talvolta anche nei metodi, caratteristiche tali da non poter essere considerato pregiudizialmente assente dal quadro filosofico. Non si tratta, comunque, di un manuale di storia della filosofia islamica, ma di una interpretazione umanistica dei principali contenuti costitutivi dell’antico pensiero islamico.
A partire dai filosofi antichi (2010), con introduzione di Carmelo Vigna, è un libro-dialogo composto con uno dei maggiori filosofi italiani, Enrico Berti. In questo testo viene ripercorsa l’intera storia della filosofia, apportando interpretazioni originali non soltanto – anche se soprattutto – dei principali filosofi antichi, ma anche di quelli moderni e contemporanei. Non mancano inoltre considerazioni su temi di attualità, nonché su temi di interesse generale, quali l’educazione, la scuola e la politica. Scrive Vigna, nella introduzione, che «questo testo è tra le cose più interessanti che si possano leggere oggi nel panorama della filosofia italiana».
L’umanesimo di Plotino (2010) è un libro in cui l’autore colma una distanza temporale fra il periodo classico ed il periodo ellenistico della Roma imperiale. Il testo si divide in due parti. Nella prima, in ossequio alla tesi per cui ogni pensiero filosofico deve essere inserito all’interno del proprio contesto storico-sociale (anche in quanto è all’interno del medesimo che esso spesso “deduce” le proprie categorie), l’autore realizza una analisi del modo di produzione sociale greco e di quello romano, per tracciare alcune differenze importanti fra l’epoca classica e l’epoca ellenistica. Nella seconda parte, che è la più ampia, è invece analizzato, in base alle dieci tematiche ritenute centrali, il pensiero di Plotino.
Perché non possiamo non dirci Greci (2010) è un libro in cui l’autore sintetizza, in termini divulgativi, le proprie posizioni generali sui Greci. Il testo prende spunto dalla rilettura, in controluce, del classico di Benedetto Croce intitolato Perché non possiamo non dirci cristiani, per mostrare non solo come le radici greche siano almeno altrettanto importanti di quelle cristiane per la cultura europea, ma soprattutto che una loro ripresa sarebbe fortemente auspicabile. Il testo è completato da una ampia appendice inedita che costituisce una analisi critica del pensiero ellenistico (in rapporto a quello classico) incentrata sulle opere di Epicuro e di Luciano di Samosata.
La filosofia della storia nella Grecia classica (2010) è il testo ermeneutico forse più originale di Grecchi. Alla cultura greca si attribuisce infatti, solitamente, la nascita dei tronchi di pressoché tutte le discipline filosofiche e scientifiche tuttora studiate nella modernità (con varie ramificazioni). Tradizionalmente, tuttavia, la filosofia della storia è ritenuta essere disciplina moderna, senza precedenti antichi. Analizzando l’opera di storici, letterati e filosofi dell’epoca preclassica e classica, l’autore mostra invece le radici antiche anche di questo campo di studi, contribuendo ad un chiarimento teoretico della disciplina stessa.
Sulla verità e sul bene (2011), con introduzione di Enrico Berti e postfazione di Costanzo Preve, è un libro-dialogo con uno dei maggiori filosofi italiani, Carmelo Vigna. In questo testo viene ripercorsa l’intera storia della filosofia, insieme agli importanti temi teoretici ed etici che danno il titolo al volume. Scrive Berti, nella introduzione, che si tratta di «una serie di discussioni oltremodo interessanti tra due filosofi che sono divisi da due diverse, anzi opposte, concezioni della metafisica, ma sono accomunati dalla considerazione per la filosofia classica e soprattutto da un grande amore per la filosofia in sé stessa».
Gli stranieri nella Grecia classica (2011) è un libro in cui l’autore, prendendo distanza dalle interpretazioni tradizionali che caratterizzano gli antichi Greci come vicini alla xenofobia, mostra che, sin dall’epoca omerica, essi furono invece aperti all’ospitalità verso gli stranieri. Preceduto da una analisi anti-ideologica delle categorie di “razza”, “etnia”, “multiculturalismo” ed altre, Grecchi rimarca come sia stato centrale, nel pensiero greco classico, il concetto di “natura umana”, il quale possiede basi teoretiche salde ed una costante presenza nella riflessione greca, che l’autore appunto caratterizza come “umanistica”.
Diritto e proprietà nella Grecia classica (2011) è un libro in cui l’autore prende in carico i temi poco indagati del diritto e della proprietà nella antica Grecia. Si tratta di temi molto importanti per comprendere il contesto storico-sociale in cui nacque la cultura greca, e che pertanto non possono essere ignorati da chi studia la filosofia di questo periodo. Il testo sviluppa inoltre un confronto con il diritto romano – che si rivela assai meno comunitario di quello greco – e con il nostro tempo, per mostrare come la cultura greca possieda, anche sul piano giuridico, contenuti che sarebbero tuttora importanti da applicare.
L’umanesimo di Omero (2012) è un libro in cui l’autore effettua una analisi teoretica ed etica del pensiero omerico, inserendo l’antico poeta nel novero del pensiero filosofico, rompendo il tradizionale isolamento nel campo letterario che da secoli caratterizza questo autore. Grecchi insiste in particolare sul carattere di educazione filosofica dei poemi omerici, mostrando come essi abbozzino temi ontologici e soprattutto assiologici poi elaborati dalla intera riflessione classica. Il testo si distingue per il continuo aggancio dei miti omerici alla contemporaneità.
L’umanesimo politico dei “Presocratici” (2012) è un libro in cui l’autore, centralizzando il carattere politico-sociale del loro pensiero, prende distanza dalle interpretazioni tradizionali che caratterizzano questi pensatori come “naturalisti”, e che li separano sia dalla poesia e dal teatro precedenti, sia dalla filosofia e dalla scienza successive. L’autore, facendo riferimento agli studi di Mondolfo, Capizzi, Bontempelli e soprattutto Preve, mostra il nesso di continuità del pensiero presocratico con l’intero pensiero greco classico. Risultano centrali, in questa trattazione, le figure di Solone e Clistene, oltre a quelle più consuete di Eraclito, Parmenide e Pitagora.
Il presente della filosofia nel mondo (2012), con postfazione di Giacomo Pezzano, è un libro in cui vengono analizzati testi di alcuni fra i maggiori filosofi contemporanei non italiani (fra gli altri Bauman, Habermas, Hobsbawm, Latouche, Nussbaum, Onfray, Zizek). Nella introduzione si rileva, come caratteristica principale della filosofia del nostro tempo, la presenza in solidarietà antitetico-polare di una corrente scientifico-razionalistica ed, al contempo, di una corrente aurorale-simbolica. Esse occupano il centro della scena escludendo dal “campo di gioco” la filosofia onto-assiologica di matrice classica, presente oramai solo in un numero limitato di studiosi.
Il pensiero filosofico di Enrico Berti (2013), con presentazione di Carmelo Vigna e postfazione di Enrico Berti, è un testo monografico introduttivo sul pensiero di questo importante filosofo contemporaneo, uno dei maggiori studiosi mondiali del pensiero di Aristotele. Rapportandosi a tematiche quali l’interpretazione degli antichi, la storia della filosofia, l’educazione, l’etica, la politica, la metafisica, la religione, Grecchi non si limita a descrivere il pensiero dell’autore considerato ma, come è nel suo approccio, valuta; in maniera solitamente concorde, eppure talvolta anche critica, in particolare nella opposizione fra metafisica classica e metafisica umanistica.
Il necessario fondamento umanistico del “comunismo” (2013) è un libro scritto a quattro mani con Carmine Fiorillo, in cui gli autori mostrano come la diffusa critica (marxista e non) al modo di produzione capitalistico, priva di una fondata progettualità, risulti sterile ed inefficace. Assumendo come base principalmente il pensiero greco classico (ma anche le componenti umanistiche di altri orizzonti culturali), gli autori mostrano che solo mediante una solida fondazione filosofica è possibile favorire la progettualità di un ideale modo di produzione sociale in cui vivere, che gli autori appunto definiscono – ma differenziandosi fortemente dalla tradizione marxista – “comunismo”.
Perché, nelle aule universitarie di filosofia, non si fa (quasi) più filosofia (2013) è un pamphlet in cui si mostra che le attuali modalità accademiche di insegnamento della filosofia, incentrate sullo specialismo, non ripropongono più il modello greco classico della filosofia come ricerca fondata ed argomentata della verità onto-assiologica dell’intero, che Grecchi assume invece ancora come centrale. L’autore mostra come la causa principale di questa situazione sia attribuibile ai processi socio-culturali del modo di produzione capitalistico.
La musa metafisica. Lettere su filosofia e università (2013), con Giovanni Stelli, costituisce uno scambio epistolare nato dal commento di Stelli al pamphlet Perché, nelle aule universitarie di filosofia, non si fa (quasi) più filosofia. A partire da questo tema lo scambio ha assunto una rilevanza ed una ampiezza tale, estendendosi a contenuti storici, culturali e politici, da renderne di qualche utilità la pubblicazione. In esso Grecchi anticipa alcuni temi portanti del suo testo che sarà intitolato Metafisica umanistica. La struttura sistematica della verità dell’essere, cui sta lavorando dal 2003.
Discorsi di filosofia antica (2014) è un libro che raccoglie i testi del corso di lezioni sull’uomo nella cultura greca, da Omero all’ellenismo, tenuto dall’autore alla università degli studi di Milano Bicocca nel 2013. Esso accoglie inoltre i testi di alcune conferenze sul pensiero antico svolte dall’autore nel 2013 e 2014, ed in particolare, in appendice, un saggio inedito sulla alienazione nella antica Grecia. Quest’ultimo è un tema poco indagato in quanto mancano, alla mentalità filologica – poco teoretica – tipica del mondo accademico di oggi, i necessari riferimenti testuali (i Greci non avevano nemmeno la parola “alienazione”); questo saggio tuttavia può aprire un filone di ricerca su una tematica tuttora inesplorata.
Omero tra padre e figlia (2014) è un libro-dialogo con Benedetta Grecchi, figlia di 6 anni dell’autore, sulle vicende di Odisseo narrate appunto nella Odissea di Omero. Il testo costituisce – come recita il sottotitolo – una “piccola introduzione alla filosofia”, passando attraverso i contenuti educativi dell’opera omerica già delineati dall’autore nel libro L’umanesimo di Omero. Questo dialogo tra padre e figlia mostra come la filosofia possa passare anche ai bambini evitando, da un lato, di essere ridotta a “gioco logico”, e dal lato opposto di essere presentata come “chiacchiera inconcludente”.
Discorsi sul bene (2015) è un libro che raccoglie i testi del corso di lezioni sul Bene tenuto dall’autore alla università degli studi di Milano Bicocca nel 2014. In appendice sono aggiunte una intervista filosofica e due relazioni su temi etico-politici. Il testo si rivela importante in quanto, all’interno di un approccio aristotelico – in cui in sostanza il Bene è il fine verso cui ogni ente, per natura, tende –, Grecchi indica nel rispetto e nella cura dell’uomo (e del cosmo: gli elementi portanti del suo Umanesimo) i contenuti fondamentali del Bene.
Discorsi sulla morte (2015) è un libro che raccoglie i testi del corso di lezioni tenuto dall’autore alla università degli studi di Milano Bicocca nel 2015. L’autore, delineando le principali concezioni della morte presenti nella storia della filosofia, con particolare riferimento agli antichi Greci ed a Giacomo Leopardi, mostra come la rimozione di questo tema costituisca una delle principali concause di alcune psicopatologie del nostro tempo.
L’umanesimo della cultura medievale (2016) è un libro che raccoglie i contenuti umanistici del pensiero medievale. Rispetto alle interpretazioni tradizionali, ancora caratterizzate da una descrizione del Medioevo come età oscura, questo testo mostra il carattere umanistico in particolare della Scolastica aristotelica. Rispetto ai consueti autori di riferimento, ossia Agostino e Tommaso, particolare importanza è attribuita in questo volume a due autori del XIII secolo, Sigieri di Brabante e Boezio di Dacia (solitamente poco considerati), nonché alle ripetute condanne ecclesiastico-accademiche dell’aristotelismo che ebbero il loro punto culminante nel 1277.
L’umanesimo della cultura rinascimentale (2016) è un libro che critica la tradizionale interpretazione umanistica del pensiero rinascimentale del XIV e XV secolo. Rispetto, infatti, alla vulgata comune, che ritiene centrale in questo periodo la riscoperta filologica ed ermeneutica dei testi di Platone e di altri autori antichi, Grecchi reputa centrale la filocrematistica, e dunque la rottura – operata da modalità sociali sempre più privatistiche e mercificate, cui la cultura dell’epoca si adeguò – del legame sociale comunitario proprio dell’epoca medievale. Il Rinascimento costituì dunque, a suo avviso, la prima apertura culturale verso la modernità capitalistica.
In preparazione:
Umanesimo ed antiumanesimo nella filosofia moderna (e contemporanea);
L’umanesimo greco-classico di Spinoza;
Il sistema filosofico di Aristotele;
Metafisica umanistica. La struttura sistematica della verità dell’essere.
***********************************************
Seguici sul sito web
 ***********************************************
***********************************************

 Indice completo delle pagine pubblicate
Indice completo delle pagine pubblicate