Salvatore Bravo – Tra “oti” e “dioti”. Una civiltà si giudica dalla pratica della verità con la quale si autofonda. Senza radicamento comunitario non vi è futuro per il singolo come per l’umanità, il bisogno di radicamento è il paradigma che distingue la vita buona dalla non vita.
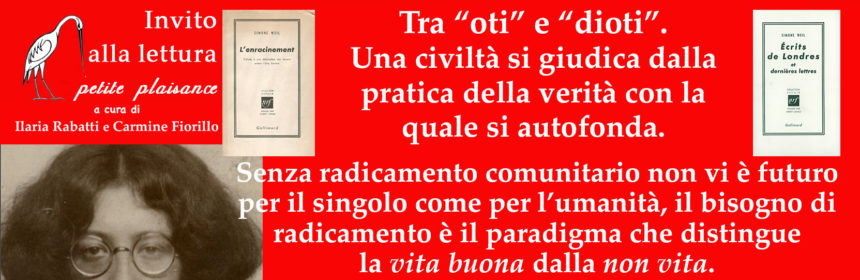
Salvatore Bravo
Tra “oti” e “dioti”
Una civiltà si giudica dalla pratica della verità con la quale si autofonda, il dioti /propter quid (il perché) deve vivere in tensione con l’oti /quod est (il che). Se tra il perché ed il che non vi è dialettica, ci si trova di fronte a forme di integralismo dogmatico. L’oti descrive il fenomeno, lo rappresenta separato dalla totalità senza intenderne il senso, il telos a cui tende. La descrizione è finalizzata al risultato ed all’utile. Il dioti interpreta in profondità, umanizza e spalanca le porte al vivere comunitario, in quanto coglie con la razionalità la verità, senza la quale non vi è politica, non vi è prassi, non vi è comunità. Se l’oti consente di misurare per usare, la verità è la precondizione per un comune progetto: senza il dioti non vi è umanesimo, ma solo tecnocrazia. La verità è al plurale, essa è nella storia di una comunità e dell’umanità. Il tempo della storia svela le contingenze distinguendole dall’eterno. Altra è l’esattezza che quantifica e consente di prevedere la ripetizione del fenomeno. Senza verità la vita di un essere umano è esposta agli eventi, è determinata dalle strutture di calcolo, è sussunta divenendo ente da misurare per essere controllato come semplice fondo di investimento (il capitale umano).
La verità si rivela nella razionalità dialogica in modo sempre perfettibile e pone l’essere umano in una posizione di attività e di cura verso l’ambiente, in tal maniera il tempo da cronologico (χρόνος-chronos) diviene qualitativo (καιρός-kairos).
Il tempo del kairos è tempo speciale, tempo nel quale gli attimi non si succedono eguali ed anonimi, ma rivelano la verità individuale ed universale senza contrapporle, ma fondendole nel tripudio della vita che si ritrova nel pensiero, che si umanizza nel concetto (Begriff) senza il quale non vi è che la dispersione, l’emorragia degli attimi e delle vite.
Diritti e doveri
Simone Weil distingue i doveri dai diritti, i primi sono necessità oggettivamente presenti nell’essere umano, mentre i diritti dipendono dalle contingenze e dal reciproco riconoscimento degli esseri umani. Senza il dovere il diritto non è che abuso, arbitrio, in quanto il riconoscimento dei doveri è la conditio sine qua non per un’esistenza degna di essere giudicata tale. Non vi è comunità senza il riconoscimento dei bisogni autentici degli esseri umani. Il dovere precede il diritto e continuerebbe ad esistere anche senza il riconoscimento degli esseri umani: è la verità di ciascuno, a cui non si può sfuggire.
Il dovere rispetto alla verità, ai beni collettivi, all’ordine armonico, umanizzano e sono propri dell’essere umano: senza di essi anche la civiltà più avanzata non si distingue dallo stato ferino. Simone Weil riflette con inquietudine, durante la seconda guerra mondiale sul mondo che verrà, un mondo di cui profetizza il trionfo dei diritti sui doveri, uno sbilanciamento che raffigura il concretizzarsi di nuove forme di violenze.
Il dovere di riconoscere i bisogni autentici è sostituito dai diritti contingenti (ed unicamente da questi): si è dinanzi ad un fenomeno di degradazione della natura umana. I soli diritti non possono che degenerare in desideri, in individualismo e dismisura. Il disordine della psiche è così istituzionalizzato, e l’essere umano è consegnato al disordine dei desideri indotti dalla struttura economica e dai poteri tecnocratici. Il diritto deve trovare il suo senso ed il suo limite proficuo nei bisogni della persona:
«Il primo criterio di distinzione dei bisogni dai desideri, dalle fantasie e dai vizi, dei cibi dalle ghiottonerie e dai veleni è che i bisogni sono limitati quanto i cibi corrispondenti. Un avaro non ha mai abbastanza oro, ma per ogni uomo, cui venga dato pane a volontà, verrà il momento della sazietà. Il nutrimento porta alla sazietà. Avviene lo stesso col nutrimento dell’anima. Il secondo criterio, legato al primo, è che i bisogni si dispongono per coppie di contrari e devono combinarsi in un equilibrio. L’uomo ha bisogno di nutrimento, ma anche di un intervallo fra i pasti; ha bisogno di caldo e di fresco, di riposo e di esercizio. Avviene lo stesso per i bisogni dell’anima».[1]
I desideri si connotano per essere illimitati, occupano ogni spazio psichico provocando lo sradicamento da sé e dalla comunità, sono gli alfieri del diritto a tutto, provocano l’isolamento dell’essere umano da sé e dal mondo. Il ripiegamento su se stessi è la forza con cui i poteri tecnocratici conservano il loro potere. Il desiderio si presenta come paradigma di valutazione della vita provocando la perenne rincorsa ai consumi ed alla frustrazione di massa.
I bisogni autentici disegnano un ordito di senso intorno ai diritti socialmente riconosciuti, e specialmente consentono di discernere il bisogno dai desideri, mettendo in moto i processi di disalienazione. La misura disegna l’equilibrio nell’anima e nella comunità.
Verità
Il primo bisogno per un essere umano è la verità, dalla verità verso se stessi, alla verità dell’informazione. Una comunità nazionale che non riconosce il bisogno alla verità recide in ogni essere umano la prima radice che lo tiene in vita e che lo tiene legato agli altri, al proprio tempo, alla propria storia. L’essere umano necessita di molte radici, di piani di verità che si integrano, senza i quali la vita non è che anomia ed è vissuta come priva di valore: è il regno del grigiore delle passioni debilitanti. Se la verità è sostituita dalla menzogna, si diffonde un profondo senso di scoramento e smarrimento, ci si rifugia in mondi paralleli, in oppiacei che se nell’immediato sono di ausilio per sopportare l’insopportabile, sul lungo periodo riducono l’essere umano ad atomo insignificante:
«Il bisogno di verità è il più sacro di tutti. Eppure non se ne parla mai. La lettura fa spavento, quando ci si sia resi conto della quantità e dell’enormità di menzogne materiali, diffuse senza vergogna anche nei libri degli autori più stimati. E così leggiamo come se si bevesse acqua di un pozzo sospetto. Ci sono uomini che lavorano otto ore al giorno e che, di sera, compiono l’enorme sforzo di leggere per istruirsi. Non possono concedersi il lusso di effettuare ricerche e verifiche nelle grandi biblioteche. Al libro che leggono, essi prestano fede. Non abbiamo il diritto di nutrirli di menzogne. Che senso può avere opporre la buona fede degli autori? Essi non lavorano fisicamente otto ore al giorno. La società li nutre perché abbiano tempo e modo per sforzarsi di evitare gli errori. Un addetto agli scambi che abbia provocato un deragliamento troverebbe una pessima accoglienza se volesse scusarsi dicendo di essere stato in buona fede».[2]
Il bisogno di verità non è riconosciuto nell’epoca del totalitarismo capitalista. Ci si sofferma sul diritto ad essere informati della giusta quantificazione, nei migliori dei casi, ma la verità è trattata con aria di sussiego come un limite all’esattezza, all’espansione economica illimitata. E comunque nessuno deve discutere la “verità” dell’espansione economica, il fondamento che la dinamizza. Senza la verità non vi è comunità democratica, perché solo il fine veritativo mediato dalla ragione – e dunque compreso – permette di cambiare rotta, di deviare in modo consapevole da una “verità” che si rivela come contingente e posticcia.
La verità è negata anche a livello personale. Ciascun individuo è portatore di un universo, di un’indole che si determina storicamente: il radicamento in se stessi è la condizione per partecipare e dialogare alla vita comunitaria, lo sradicamento dalla propria verità personale è la necrosi di un essere umano, che si ritrova nella gettatezza distante da sé e da tutti, esposto agli eventi e dunque manipolabile.
L’appartenenza patria
Le radici sono al plurale, il bisogno di radicamento si esplica nella viva tradizione della comunità patria in cui ci si riconosce, di cui si condivide il destino storico e dunque verso la quale ci si responsabilizza. Le radici si nutrono dello spirito, della cultura. Senza tale nutrimento le radici avvizziscono, il soggetto umano non ha la possibilità di formarsi e di pensare in modo divergente. Le radici gemmano, producono nuovi rizomi, se ogni individuo sente il legame non come catena, ma come l’esserci di senso, si riconosce in una storia per riplasmarla nuovamente. Il cosmopolitismo, il relativismo sempre più spinto verso il nichilismo passivo depaupera l’essere umano del suo bisogno di appartenenza, della sua disposizione al dono. Lo si deresponsabilizza in modo da ripiegarlo su se stesso, rendendolo indifferente alla vita altrui. L’indifferenza slega, è il sentimento antipolitico per eccellenza:
«Non è possibile soddisfare l’esigenza di verità di un popolo se a tal fine non si riesce a trovare uomini che amino la verità. Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell’anima umana. È tra i più difficili da definire. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall’ambiente. Ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente». [3]
Le radici multiple magnificano l’essere umano, trasformano frustrazioni ed aggressività, le sublimano in attività creatrice. Senza radici multiple la persona è fragile e riempie il suo tempo di merci e desideri. Si limitano, così, le capacità di creare spazio per nuove possibilità concettuali. Il tempo senza radici è colmo di cose, di desideri indotti, è tempo del sistema che si installa nella carne.
Beni collettivi
I beni collettivi rivelano che la persona è per essenza comunitaria. Nel bene collettivo l’essere umano vive in modo concreto l’appartenenza alla storia, alla grande famiglia della comunità patria. Lo spazio comune forma personalità solidali, pronte all’incontro. I beni collettivi sono l’agorà dove la parola è comunicazione. Senza beni pubblici non vi è vita civica, ma solo frammentazione competitiva e narcisistica:
«Un bisogno altrettanto importante è la partecipazione ai beni collettivi, partecipazione che non consiste in una fruizione materiale, ma in un sentimento di proprietà. Si tratta più di uno stato spirituale che di una disposizione giuridica. Là dove esiste veramente una vita civica, ognuno si sente personalmente proprietario dei monumenti pubblici, dei giardini, della magnificenza esibita nelle cerimonie; e così, il lusso che quasi ogni essere umano desidera è concesso persino ai più poveri. Ma non solo lo stato bensì qualsiasi specie di collettività ha il dovere di fornire la soddisfazione di questo bisogno».[4]
Lo sradicamento
La prima forma di sradicamento nel capitalismo avanzato è la precarizzazione del lavoro. Il precario ha un solo pensiero: il denaro. Per il precario non vi è possibilità di radicamento e di buona vita, perché è ossessionato dal denaro, dal timore di non poter soddisfare il minimo vitale, sempre esposto al ricatto della disoccupazione e della facile sostituzione dei lavoratori. Nel precario si consuma la tragedia del capitalismo, ma ne svela, anche, la verità violenta: il fine del capitalismo è lo sfruttamento ed il plusvalore:
«Esiste una condizione sociale – il salariato – completamente e perpetuamente legata al danaro, soprattutto da quando il salario a cottimo costringe ogni operaio ad essere sempre teso mentalmente alla busta paga. La malattia dello sradicamento raggiunge il massimo di gravità proprio in questa condizione sociale. Bernanos ha scritto che i nostri operai, almeno, non sono gente immigrata come quelli del signor Ford. Ma la principale difficoltà sociale del nostro tempo deriva dal fatto che essi, in un certo senso, lo sono. Benché geograficamente non abbiano mutato dimora, sono stati sradicati moralmente, esiliati e poi riammessi di nuovo, quasi per tolleranza, come carne da lavoro. La disoccupazione, beninteso, è uno sradicamento alla seconda potenza. Non si sentono in casa propria né in fabbrica, né nelle loro abitazioni, né nei partiti e sindacati che si dicono fatti per loro, né nei luoghi di divertimento, né nella cultura intellettuale, qualora tentino di assimilarla». [5]
Violenza e sradicamento
Lo sradicamento è vettore di violenza, la centuplica: lo sradicato non ha vincoli e pertanto è disponibile ad essere veicolo di sradicamento. Lo sradicato non ha storia, non ha riferimenti etici, si sente gettato al mondo, non se ne sente parte o accolto, per cui l’aggressività è la sua difesa, la rabbia covata a lungo è pronta scaricarsi senza mediazione del logos:
«Da alcuni secoli, gli uomini di razza bianca hanno distrutto dovunque il passato, stupidamente, ciecamente, nelle loro patrie e nelle patrie altrui. Se ciò nonostante c’è stato, per taluni aspetti, un reale progresso nel corso di questo periodo, ciò non è accaduto per merito di questa furia distruttiva, ma suo malgrado, per l’impulso di quel poco di passato che sopravviveva. Il passato distrutto non torna mai più. La distruzione del passato è forse il delitto supremo. Ai giorni nostri, la conservazione di quel poco che resta dovrebbe diventare quasi un’idea fissa. Bisogna arrestare il terribile sradicamento che viene continuamente prodotti dai metodi coloniali europei, persino quando assumono le forme meno crudeli. Bisogna astenersi, dopo la vittoria, dal punire il nemico vinto, perché così lo si sradicherebbe anche di più. Poiché non è possibile né desiderabile sterminarlo, aggravare la sua follia vorrebbe dire essere più pazzi di lui. In qualsiasi innovazione politica, giuridica o tecnica suscettibile di ripercussioni sociali, bisogna anzitutto mettere in programma provvedimenti che consentano agli esseri umani di riavere radici». [6]
L’alternativa alla violenza per lo sradicato è l’indifferenza, la malinconia depressiva dovuta al sentirsi nulla, all’estraneità al mondo. I cosiddetti Neet, giovani che consumano la loro esistenza nell’indifferenza e nella passività, denunciano la disumanità dello sradicamento, il silenzio di un mondo che, mentre offre l’esattezza nega i bisogni primi senza i quali non vi è che il vuoto alienante dei giorni che si susseguono eguali.
Senza radicamento comunitario non vi è futuro per il singolo come per l’umanità, il bisogno di radicamento è il paradigma che distingue la vita buona dalla non vita:
«L’anima umana ha bisogno più d’ogni altra cosa di essere radicata in molteplici ambienti naturali e di comunicare con l’universo per il loro tramite. La patria, gli ambiti definiti dalla lingua, dalla cultura, da un passato storico comuni, la professione, il paese, sono esempi di ambienti naturali. È criminale ciò che ha per effetto di sradicare un essere umano o di impedire che metta radici». [7]
La globalizzazione riduce le radici, le assottiglia, sradica in senso orizzontale e verticale. Non resta che lo spazio ed il tempo da attraversare, da fendere in modo continuo. Si assiste ad una rivoluzione antropologica che vorrebbe negare ogni forma di umanesimo in nome dei soli diritti formali ed individuali. Simone Weil comprese che la fine del conflitto comportava nuovi pericoli e controcorrente pose al centro del suo testo la necessità di praticare i bisogni che permettono all’essere umano la buona vita.
Salvatore Bravo
****
[1] Simone Weil, La prima radice, traduzione di Franco Fortini, Mondadori, Milano, p. 6.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem, p.21
[4] Ibidem, p. 18
[5] Ibidem, p. 22
[6] Ibidem, p. 25
[7] Simone Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, Éditions Gallimard, Paris 1957, p. 83.
