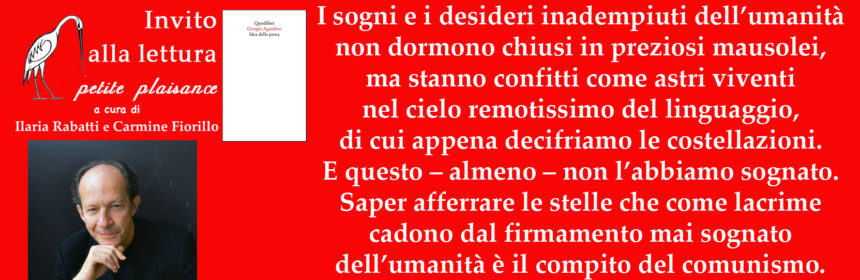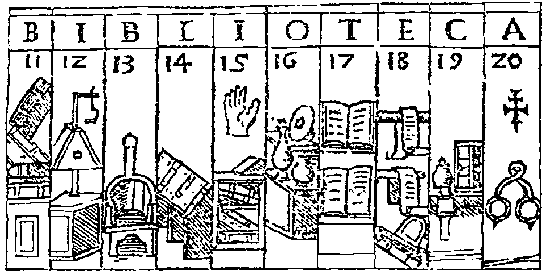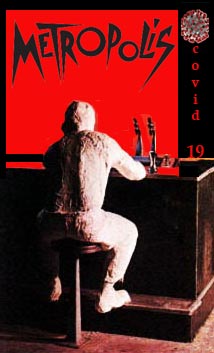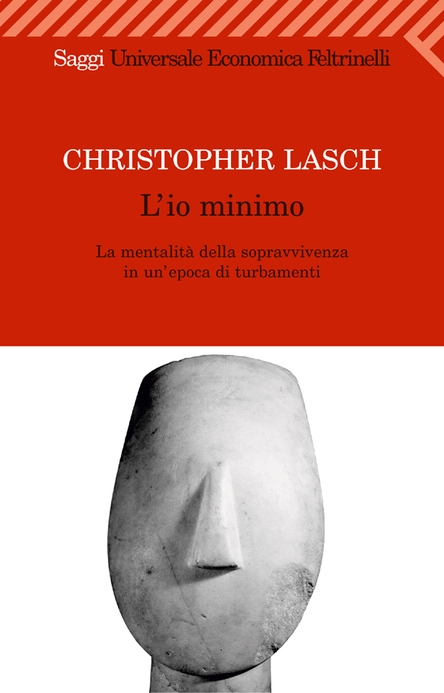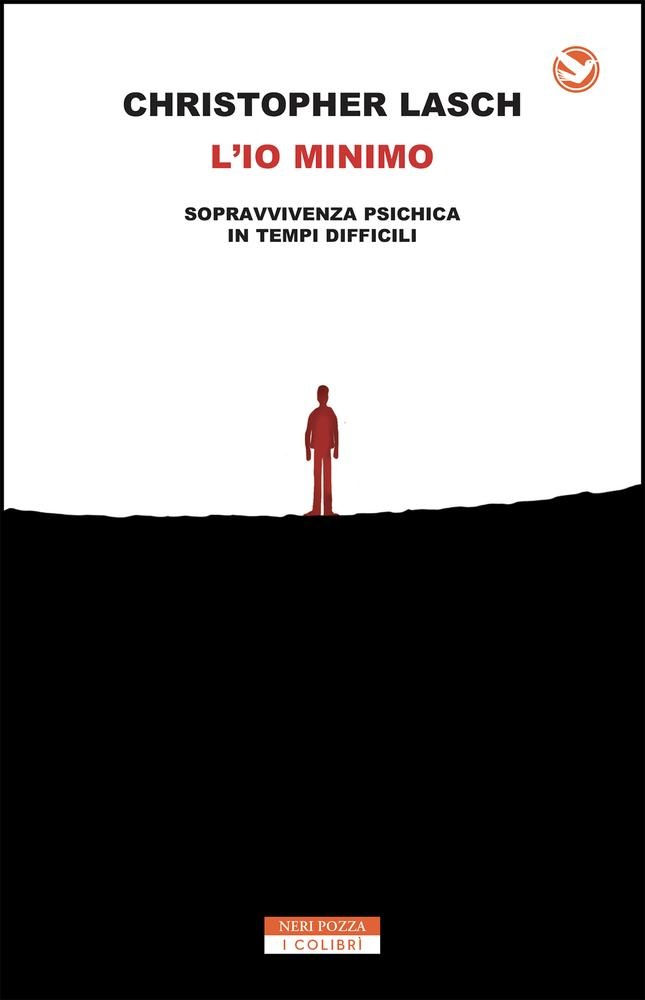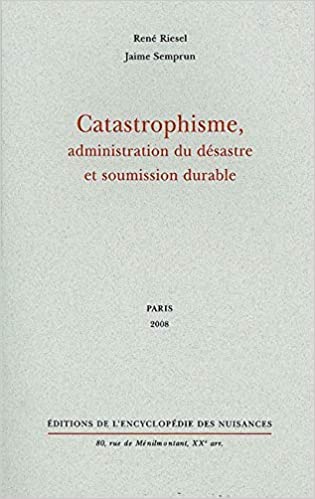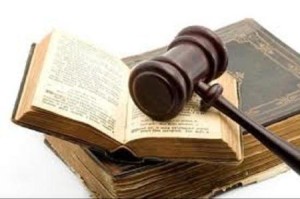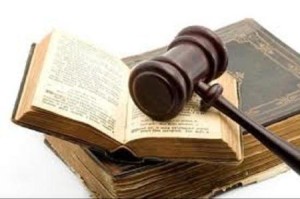
Queste brevi note prendono spunto dalle questioni poste dal libro di Luca Grecchi Diritto e proprietà nella Grecia classica. Paralleli con il nostro tempo (Petite Plaisance, Pistoia 2011), e in particolare dal suo confronto con alcune posizioni di Oliviero Diliberto, il quale ha sostenuto che una determinata concezione del diritto è in grado di guidare (o accompagnare) la struttura di un modo di produzione sociale verso il comunismo. In particolare la concezione del diritto chiamata in causa dall’ex Ministro della Giustizia è quella del diritto romano, il quale viene invece da Grecchi criticato (in quanto diritto proprietario e contrattuale, jus utendi et abutendi, diritto all’uso e all’abuso sulle cose e sulle persone) in nome dell’anti-crematistico umanesimo greco, e della conseguente concezione greca del diritto. Cercheremo di contribuire alla critica del diritto romano che fa da sfondo all’intera opera di Grecchi, attraverso alcune riflessioni di Roberto Esposito e di Giorgio Agamben1.
1. Il paradigma politico moderno-contemporaneo:
il diritto di essere liberi individui proprietari
I. La politica moderno-contemporanea non solo non si fonda su alcun legame sociale, ma è addirittura possibile solamente a partire dal suo scioglimento, da quello «slegame» che s-lega i singoli, allontanandoli l’uno dall’altro per re-legarli in spazi individuali chiusi e asettici ob-ligandoli a obbedire a codici astratti. Il contratto (pactum unionis/associationis) è ciò che separa (nel senso letterale del ricondurre a se stessi) gli uomini proprio nel momento in cui li accosta e unisce (pactum societatis) come sommatoria di individui messi giuridicamente in relazione per consegnare al potere sovrano ogni forma di autorità e di controllo (pactum subjectionis).
II. Oggi si può affermare che dopo la morte di Dio è venuta quella del social-comunismo2, perché viviamo la politica come un regno di atomi gestiti da un potere centrale economicamente sovrano, viviamo il drammatico esito della «dimenticanza» (parafrasando Heidegger) di una distinzione che nel mondo greco continuava a essere fondamentale ancora dopo il periodo classico, quella tra economia (monarchica) e politica (poliarchica), tra oikos – dominio dell’idion nella sua occlusiva univocità nonché congrega di singoli uomini, letteralmente idioti – e polis – campo aperto del koinon nella sua irriducibile e molteplice diversità:
se il processo di unificazione viene spinto oltre a un certo punto, non vi sarà più alcuna polis. Una città è per natura un che di molteplice [plethos], e se diventa troppo una sarà un’oikia piuttosto che una polis e un anthropos piuttosto che un’oikia: in realtà dobbiamo ammettere che l’oikia è più una della polis e l’anthropos dell’oikia: di conseguenza chi fosse in grado di realizzare tale unità non dovrebbe farlo, perché distruggerebbe la polis (Aristotele, Politica, II, 2, 1261a 17-23).
L’economia e la politica differiscono non solo tanto quanto oikia e polis (queste in effetti ne costituiscono le rispettive materie), ma anche perché la politica [politikè] consta di molti capi [pollon archonton], l’economia [oikonomikè] invece è il governo di uno solo [monarchia] (Aristotele, Economico, I, 1, 1343a 1-4).
Come notava anche Hegel, la polis greca è stata lo spazio (concettuale e fisico) della continua mediazione tra uno e molteplice, e proprio per questo è stato il luogo di nascita della libertà europea, della libertà in quanto tale, della costruzione morale e politica che permette di battere la potenza distruttiva e nullificante di Kronos il divora figli3.
III. Il paradigma moderno della politica e della sovranità è contraddistinto da due aspetti fondamentali: la persona concepita come proprietaria e il sovrano (Re o Stato che sia) come colui che gestisce la vita degli individui. Il diritto, il cui fondamento è che «ciascuno difenda la sua vita e le sue membra per quanto è in suo potere» (Hobbes, De cive, I, 7)4, è il dispositivo chiamato a normare e a codificare tutto ciò: il diritto deve sancire la proprietà individuale (cfr. p. e. Locke, Secondo trattato sul governo, V, 25-51)5 e dichiarare il potere sovrano statuale come gestore unico, vero e proprio Leviatano (cfr. p. e. Hobbes, Leviatano, XVII-XVIII)6. L’aspetto che qui ci preme evidenziare è che è stato il diritto romano a codificare per primo in maniera sistematica e politicamente performativa questi due aspetti, come cercheremo brevemente di mostrare seguendo rispettivamente Esposito e Agamben. Questo non significa negare discontinuità, magari anche radicali, rispetto alla concezione giuridica moderna (maggiormente incentrata sul soggetto piuttosto che sulla persona, per esempio), ma semplicemente segnalare la persistenza, più o meno sotterranea, nella modernità di una visione della vita in comune degli esseri umani (visione sostanzialmente antiumanistica e – anzi: in quanto – anticomunitaria) la cui incarnazione giuridico-politica è stata resa possibile dallo jus romano (d’altronde, il soggetto giuridico moderno è pensabile proprio a partire dalla persona giuridica romana).
IV. In altri termini, la tesi che intendiamo sostenere è che è nel diritto romano che hanno trovato una prima fondamentale fondazione e codificazione alcuni tratti fondanti la soggettività personale giuridica moderna, espressione della capacità di penetrazione ideologica del capitale, come ben aveva colto Marx laddove notava che, anche attraverso il diritto, «la proprietà privata viene incorporata nell’uomo stesso, e lo stesso uomo si riconosce come l’essenza [Wesen] della proprietà»7, proprietà privata concepita «in quanto attività che è per sé, in quanto soggetto, in quanto persona»8: l’individuo soggetto del diritto è oggetto di una drammatica Trennung tanto rispetto al Mensch quanto al Gemeinwesen9. Infatti, per Marx nel diritto «si tratta della libertà dell’uomo in quanto monade isolata e ripiegata su se stessa […]. Il diritto dell’uomo alla libertà si basa non sul legame dell’uomo con l’uomo, ma piuttosto sull’isolamento [Absonderung] dell’uomo dall’uomo. È il diritto a tale isolamento, il diritto dell’individuo limitato, limitato in se stesso»10: «l’utilizzazione pratica del diritto dell’uomo alla libertà è il diritto dell’uomo alla proprietà privata»11, la libertà concepita come arbitrium si configura come «il diritto di godere a proprio arbitrio (à son gré), senza considerare gli altri uomini, indipendentemente dalla società, del proprio patrimonio e di disporre di esso, il diritto dell’egoismo»12. Il diritto tenta di realizzare l’estrema astrazione, senza però rendersi conto che in realtà gli uomini non possono essere atomi e non lo sono mai, in quanto l’uomo non abita nella divina (o animale) indifferenza, come aristotelicamente evidenziato da Marx ed Engels:
la proprietà caratteristica dell’atomo consiste nel non avere alcuna proprietà e perciò nessuna relazione [Beziehung] […]. L’individuo egoistico della società civile si può gonfiare […] fino a diventare l’atomo […]. Ma, poiché il bisogno del singolo individuo non ha senso evidente di per sé per l’altro individuo egoistico che possiede i mezzi per soddisfare quel bisogno […], ogni individuo è quindi costretto a creare questa connessione […]. Sono quindi la necessità naturale, le proprietà umane essenziali, per quanto alienate [entfremdet] possano apparire, l’interesse, che tengono uniti i membri della società civile; il loro legame reale è la vita civile, e non la vita politica […], essi sono atomi solo nella rappresentazione [Vorstellung], nel cielo della loro immaginazione – il fatto che nella realtà [Wirklichkeit] sono esseri fortemente distinti dagli atomi, cioè non sono egoisti divini, ma uomini egoistici13.
Gli uomini, dunque, proprio in quanto uomini, sono necessariamente in rapporto con gli altri, non sono indipendenti: non c’è individuo che non dipenda dal legame sociale per realizzare persino il proprio utile e l’interesse privato; è la natura umana, l’essere bisognoso proprio dell’uomo, a fare degli individui umani esseri non autosufficienti e non assoluti – né animali né dei14. Das menschliche Wesen, ricorda Marx nella Tesi su Feuerbach, è das ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse (VI), e la vita sociale è essenzialmente Praxis (VIII), umwälzende in quanto sinnlich menschliche Tätigkeit (I)15. Questo, in estrema sintesi, è quanto il diritto romano ha cercato di mettere da parte attraverso il suo capillare dispositivo normativo e normalizzante, che ha dato vita a una paradossale coimplicazione tra individualismo e assolutismo, perché la realizzazione dei diritti individuali, la garanzia della loro sicurezza, viene connessa alla subordinazione a un’obbligazione politica che possiede un carattere di assolutezza, all’alienazione di tutti i diritti, persino alla donazione della vita.
2. Persona, libertà e proprietà: il dispositivo individualizzante del diritto
I. Il diritto romano viene da Esposito considerato un vero e proprio dispositivo, per il suo ruolo performativo, ossia produttivo di effetti reali: esso distingue la persona, intesa come entità artificiale portatrice del diritto, dall’uomo, inteso come essere naturale «cui può convenire o meno uno statuto personale» (TP, p. 13). Ciò significa che per il diritto, vero e proprio «meccanismo di disciplinamento sociale» (ibidem), l’uomo può essere considerato tanto persona quanto cosa, come si evidenzia nel caso dello schiavo, che abita la zona di transito tra cosa vivente e persona reificata. Non solo: qualcuno può essere considerato pienamente persona (essere incluso da parte del dispositivo del diritto) solamente se qualcun altro viene spinto verso i confini della cosa (viene escluso da parte del diritto). In poche parole, il diritto possiede un carattere «privativo ed escludente» (ivi, p. 20), esclude colui che è privato del diritto, mentre include colui che è ammesso dal diritto soltanto in quanto privato cittadino, proprietario della sua persona prima ancora che delle cose che lo circondano e di cui fa uso.
II. La persona, dunque, viene intesa nel diritto romano come una maschera, come una vera e propria finzione, come l’assunzione di un ruolo economico-sociale: il diritto romano ha trasferito lo scarto singolare tra corpo e persona (tra ciò che nell’uomo è da considerare ulteriore e separato rispetto alla sua semplice corporeità) «dall’ambito singolare dell’individuo alla trama complessiva dei rapporti tra gli uomini» (ivi, p. 94). La generalità del diritto unisce gli uomini proprio tramite ciò che li divide, essi «sono divisi dalla forma che li collega in un unico destino» (ivi, p. 95), destino che li allontana dall’esistenza concreta e dalla densità corporea per dar vita a categorie astratte di esclusione/inclusione: schiavi e liberi, suddivisi a loro volta in ingenui (liberi per nascita) e liberti (liberi per affrancamento). Il diritto rende gli esseri umani soggetti nel senso che li assoggetta, li rende cioè oggetti in quanto li definisce in base a uno status che li codifica: «servi, filii in potestate, uxores in matrimonio, mulieres in manu, liberi in mancipio, ma anche addicti, nexi, auctoritati, sono tutte classi di esseri umani alieni iuris» (ibidem), sottoposti alla potestà del pater familias, «unico tipo di vivente sui iuris» (ibidem).
III. Lo schiavo, notavamo, è una figura particolarmente rivelatrice in quanto «eternamente sospeso tra la condizione di persona e quella di cosa, cosa con un ruolo di persona e persona ridotta allo stato di cosa, a seconda che si guardi ai compiti effettivi che assolve nella società romana oppure alla sua classificazione strettamente giuridica» (ivi, pp. 95 s.). Infatti, da un lato, egli è quasi la non-persona nella persona, la cosa all’interno della persona, è proprietà del padrone alla stregua di cose e animali, è strumento certo «parlante» ma pur sempre strumento da utilizzare e «in piena balia di colui cui appartiene nei suoi atti e nel suo corpo» (ivi, p. 96), è letteralmente dominato dal suo dominus. Eppure, dall’altro lato, «può, in alcuni casi, rappresentare legalmente il dominus assente o addirittura amministrare un peculium» (ibidem), così come, seppur destituito di ogni personalità giuridica, può «essere sottoposto a pena, purché particolarmente crudele e infamante o anche, sotto tortura, testimoniare davanti a un giudice» (ibidem). Qualora fosse stato ucciso non dal padrone (sempre legittimato a farlo), il suo assassino poteva essere, sempre a seconda della volontà del padrone, condannato per omicidio («come accade quando si procura la morte di una persona»: ibidem), o tenuto al risarcimento pecuniario al proprietario («come se gli avesse sottratto qualsiasi altro bene materiale»: ibidem). La stessa ambiguità la si ritrova nel rituale della vindicatio in servitutem, nel passaggio dalla schiavitù alla libertà o viceversa, caratterizzato da una serie di stati intermedi che rendono «mai definitivamente compiuto e sempre reversibile» (ibidem) il transito da persona a cosa. Se si prende infatti, per esempio, la manumissio, l’affrancamento dello schiavo, si nota che essa, sempre connessa alla volontà sovrana del proprietario, può assumere le tre forme vindicta, testamento e censu:
nella prima l’emancipazione scaturisce dalla circostanza che alla vindicatio in libertatem di colui che, d’accordo col dominus, veste i panni dell’adsertor libertatis, non corrisponde una contravindicatio da parte del padrone. Nella seconda, per testamento, la liberazione avviene solo alla morte di quest’ultimo, con la conseguente estinzione degli obblighi patronali che negli altri casi continuano a vincolare il liberto. Nella terza, infine, la manumissio consiste nella iscrizione, sempre da parte del dominus, dello schiavo nelle liste del censo, e dunque nella sua iscrizione al novero dei cittadini liberi. Ma ciò che caratterizza, in tutte le forme, la procedura di manomissione è sempre la sua incompiutezza – vale a dire la distanza residua, graduata secondo precise misure, rispetto alla condizione di libertà effettiva (ivi, pp. 96 s.).
In altri termini, la liberazione restava sempre in sospeso, lo schiavo veniva considerato statuliber, non semplice liber, o addirittura gli restava preclusa la possibilità di fare testamento, in quanto tornava schiavo al momento della morte. Esisteva persino un istituto, la diminutio capitis (minima, media o maxima) volto alla «depersonalizzazione»: ciò mostra che la libertà, sempre e comunque nella disponibilità del padrone, era limitata nella forma, nell’estensione e nel tempo, venendo intesa «non come una condizione originaria, bensì derivata, cui l’uomo poteva accedere, temporaneamente e occasionalmente, attraverso un processo artificiale di personificazione» (ivi, p. 97).
IV. Non si deve pensare che tutto ciò valesse solo per lo schiavo, perché per il diritto romano nessun uomo era in quanto tale – per natura – persona: persino il liber per divenire pater doveva comunque passare «per lo stato di filius in potestate» (ivi, p. 98), vale a dire che prima di poter rivendicare lo jus vitae ac necis in quanto soggetto di diritto egli doveva essere stato a sua volta oggetto di analoga rivendicazione. Lo statuto di filius nel diritto mostra più di una consonanza con quello dello schiavo, o forse era persino peggiore di quello di quest’ultimo, in quanto – per esempio – il figlio abbandonato o venduto dal padre non diventava nemmeno proprietà del nuovo pater, perché restava in quella del padre naturale (cfr. ivi, pp. 98 s.). La persona, codificata dal diritto come centro individuale, si distingue dalla res in quanto sua proprietaria; il diritto romano compie una prestazione fondamentale che la giurisprudenza moderna non farà che accogliere, riarticolare e riallargare, quella della «separazione presupposta, all’interno dell’essere umano, tra un elemento naturale, corporeo, meramente biologico e un altro trascendente, costituito di volta in volta in centro di imputazione giuridica, razionale, morale» (ivi, p. 118)16. Come aveva intuito Simone Weil, cui Esposito si riallaccia, il diritto romano è diritto di usare e abusare, è legato a una divisione, a uno scambio e una quantità che ne fanno qualcosa di commerciale e legato all’esercizio della forza17: il diritto personale-individuale, sin dalla sua codificazione romana anzi grazie a essa, è un vero e proprio privilegio, qualcosa che include solamente laddove può escludere, è qualcosa di «privato e privativo» (ivi, p. 123), ha un carattere «di per sé particolaristico» (ibidem). È dunque contrario alla comunità e all’uguaglianza: «il privilegio per definizione è diseguale»18, e la diseguaglianza è per sua natura anticomunitaria.
3. L’homo sacer e l’eccezione sovrana
I. Secondo Agamben il fondamento del potere sovrano moderno non va cercato tanto nella libera cessione, da parte dei sudditi, del loro diritto naturale, quanto piuttosto nella conservazione, da parte del sovrano, del suo diritto naturale di fare qualsiasi cosa rispetto a chiunque, di punire chiunque (cfr. HS, p. 118): il sovrano moderno è come il pater romano, il quale non tanto prende in carico dai dominati (schiavi o figli che siano) il loro (supposto, o comunque sempre provvisorio, come notato) diritto personale, quanto piuttosto è l’unico a poter continuamente esercitare il proprio diritto di proprietà e di controllo rispetto a essi. Gli uomini che vengono sottoposti al potere sovrano vengono considerati uguali proprio come i dominati che vengono sottoposti all’autorità della persona romana venivano considerati uguali: in quanto a disposizione, persino in quanto uccidibili (cfr. p. e. Hobbes, De cive, I, 3)19. Nei termini di Agamben, la sovranità moderna considera politica la vita solamente in quanto vita sacra, ossia uccidibile ma insacrificabile (uccidibile proprio in quanto insacrificabile e viceversa).
II. Per definire la figura della sacralità connessa alla vita umana Agamben si rifà proprio a una figura del diritto romano arcaico: «at homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui occidit, parricidi non damnatur; nam lege tribunicia prima cavetur “si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit”. Ex quo quivis homo malus atque improbus sacer appellari solet» (HS, p. 79)20. Sacro viene dunque definito dal diritto romano quell’uomo la cui uccisione resta impunita ma il cui sacrificio resta interdetto: se è vietato violare qualsiasi cosa sacra, è invece non sacrilego uccidere l’uomo sacro, se ogni uccisione viene punita dalla legge, è invece lecito uccidere l’uomo sacro. L’uomo sacro si pone così all’interno del diritto come colui che è al di fuori tanto dello ius divinum (non può essere sacrificato secondo le prassi rituali) quanto dello ius humanum (è uccidibile da tutti senza punizione): lascia entrambi in sospeso proprio nel momento in cui ne conferma l’esistenza in maniera più radicale. In altre parole, l’homo sacer, restando a metà tra giurisdizione divina e umana, si pone in una zona di indistinzione tra il diritto e la sua applicazione, nel senso che attraverso di lui il diritto è all’opera attraverso la sua disattivazione: il diritto viene messo letteralmente in sospeso attraverso una duplice eccezione (cfr. ivi, pp. 80-82 e 90 s.). «La vita insacrificabile e, tuttavia, uccidibile, è la vita sacra» (ivi, p. 91): essa occupa lo stato di eccezione, appartiene a Dio nella forma della non sacrificabilità ed è inclusa nella comunità nella forma dell’uccidibilità, laddove l’appartenenza a Dio è normalmente definita dalla sacrificabilità e l’inclusione nella comunità dalla non uccidibilità.
III. L’homo sacer, suggerisce Agamben, va considerato come la figura originaria «della vita presa nel bando sovrano» (ivi, p. 92), ciò che è catturato in esso è «una vita umana uccidibile e insacrificabile: l’homo sacer» (ibidem), il suddito in quanto tale. Ciò significa che il diritto romano ha codificato la struttura essenziale della sovranità moderna, la quale ha in carico la gestione delle vite dei singoli proprio in quanto può negarle: «sovrana è la sfera in cui si può uccidere senza commettere omicidio e senza celebrare un sacrificio e sacra, cioè uccidibile e insacrificabile, è la vita che è stata catturata in questa sfera» (ibidem). La legge conosce un caso in cui essa manifesta in tutta la sua potenza la sua capacità di applicazione: quando si applica disapplicandosi, come accade nel caso dell’eccezione, momento in cui la legge si consegna a una pura vigenza senza alcun significato (Geltung ohne Bedeutung), in cui avviene il pieno abbandono al bando sovrano, che accosta e lega al proprio controllo con più forza proprio ciò che considera bandito rispetto all’ordine sociale (cfr. ivi, pp. 34, 59, 68, 122 s.)21. In tale momento la sovranità rivela il suo volto, la sua capacità di includere per esclusione e di escludere per inclusione: «sovrano è colui rispetto al quale tutti gli uomini sono potenzialmente homines sacri e homo sacer è colui rispetto al quale tutti gli uomini agiscono come sovrani» (ivi, pp. 93 s.).
IV. Potremmo anche dire: il sovrano è il pater dei sudditi considerati quali «figli adottivi» del padre imperator22. Foucault affermava che uno dei privilegi caratteristici del potere sovrano è stato sempre la vitae necisque potestas: ebbene, tale potestà è stata originariamente definita dal diritto romano, come «incondizionata potestà del pater sui figli maschi» (ivi, p. 97). Nel diritto romano vita è un concetto non giuridico, indica cioè il semplice fatto di vivere o un particolare modo di vita, tranne che proprio nell’espressione vitae necisque potestas, in cui diventa un vero e proprio terminus technicus. Per Agamben questo mostrerebbe come nel diritto romano la vita appare solo «come controparte di un potere che minaccia la morte» (ibidem), di un potere dunque assoluto, quello che «scaturisce immediatamente e unicamente dal rapporto padre-figlio» (ivi, p. 98), che fa sì che il cittadino maschio libero si trovi di per sé in una condizione di «uccidibilità virtuale» (ivi, p. 100), di sacralità rispetto al pater, potere esteso in seguito all’intera sfera pubblica: «l’imperium del magistrato non è che la vitae necisque potestas del padre estesa nei confronti di tutti i cittadini» (ivi, p. 99). La vita considerata politicamente dal diritto romano è dunque quella sacra, perennemente esposta alla morte eppure proprio per questo non sacrificabile e non punibile: attraverso il diritto romano la vita «si politicizza attraverso la sua stessa uccidibilità» (ibidem), ossia soltanto tramite «l’abbandono a un potere incondizionato di morte» (ivi, p. 101). È solo a partire dall’orizzonte aperto dal diritto romano, sostiene Agamben, che nella modernità il potere supremo potrà essere concepito come «la capacità di costituire sé e gli altri come vita uccidibile e insacrificabile» (ivi, p. 113): persino il sovrano stesso si ritroverà investito della sacertà, di modo che la sua uccisione – crimine di lesa maestà – verrà considerata non un semplice omicidio (qualcosa di più, nel suo caso), e proprio per questo non potrà avvenire semplicemente seguendo i riti ordinari e le forme sancite (cfr. ivi, pp. 114 s.)23.
V. La politica moderna potrà prendere così in gestione la vita sacra in quanto nuda vita, sostiene Agamben, quella stessa nackte Leben che per Engels è quanto resta – e a malapena – dopo l’Auflösung der Menschheit in monadi da parte dello Scheidungprozess del capitalismo, modalità di produzione e di organizzazione sociale che dichiara apertamente la soziale Krieg, il bellum omnium contra omnes tanto temuto da Hobbes: «ognuno sfrutta l’altro, e ne deriva che il più forte si mette sotto i piedi il più debole, a malapena resta la nuda vita»24, in una situazione in cui «ciascuno vede nel suo prossimo un nemico da togliere di mezzo o tutt’al più uno strumento da sfruttare per i propri fini»25, e «questa guerra di tutti contro tutti non può stupirci, poiché non è altro che la concreta attuazione del principio già insito nella libera concorrenza»26. La vita viene così totalmente denudata e privata della sua essenza umana, quasi sino a scomparire – appaiono ancora tristemente valide alcune cupe parole di Adorno: «quella che un tempo i filosofi chiamavano vita, si è ridotta alla sfera del privato, e poi del puro e semplice consumo, che non è più se non un’appendice del processo materiale della produzione, senza autonomia e senza sostanza propria. […] Lo sguardo aperto sulla vita è trapassato nell’ideologia, che nasconde il fatto che non c’è più vita alcuna»27.
Note
1 Faremo riferimento in particolar modo a R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007 (d’ora in poi TP in corpo testo) e G. Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995 (d’ora in poi HS in corpo testo).
2 È l’affermazione del Nobel per l’Economia del 1986 James M. Buchanan in: Il socialismo è finito, il Leviatano vive (1990), tr. it. di G. De Santis, in AA. VV., Le libertà dei contemporanei. Conferenze “Fulvio Guerrini” 1984-1993, presentazione di P. Ostellino, Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, Torino 1993, pp. 161-172.
3 Cfr. G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia (1840), vol. I, a cura di E. Codignola e C. Sanna, Sansoni, Firenze 1947, pp. 182 e 279 s.
4 Cfr. T. Hobbes, De cive. Elementi filosofici sul cittadino (1649), a cura di T. Magri, Editori Riuniti, Roma 2005, p. 25.
5 Cfr. J. Locke, Due trattati sul governo e altri scritti politici (1690), a cura di L. Pareyson, UTET, Torino 1982, pp. 247-263.
6 Cfr. T. Hobbes, Leviatano (1651), a cura di R. Santi, Bompiani, Milano 2001, pp. 275-303.
7 K. Marx, Manoscritti economici-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, Einaudi, Torino 2004, p. 102.
8 Ivi, p. 101. Altrove Marx affermava che gli individui sussunti alla forma-merce «si riconoscono reciprocamente come proprietari, come persone la cui volontà permea le loro merci. Qui entra in ballo il momento giuridico della persona, e della libertà nella misura in cui vi è contenuta» (K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica (1857-1858), 2 voll., tr. it. di E. Grillo, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 231).
9 cfr. K. Marx, La questione ebraica (1844), in B. Bauer – K. Marx, La questione ebraica, a cura di M. Tomba, Manifestolibri, Roma 2004, pp. 173-206: 193.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ivi, p. 194.
13 K. Marx- F. Engels, La Sacra famiglia, ovvero Critica della critica critica. Contro Bruno Bauer e soci (1845), in K. Marx – F. Engels, Opere, IV: 1844-1845, a cura di A. Scarponi, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 3-234: 134 s. Come ha scritto Charles Taylor, non solo «vivere in società è una condizione necessaria dello sviluppo della razionalità, in uno dei possibili sensi di questa proprietà, o della trasformazione [becoming] in un agente morale nel senso pieno del termine, o in un essere autonomo pienamente responsabile» (C. Taylor, Atomism, in Id., Philosophical Papers II: Philosophy and the Human Sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1985, pp. 187-210: 191), ma persino «essere un individuo non equivale a essere un Robinson Crusoe; significa piuttosto essere collocato in un certo modo tra gli altri uomini» (C. Taylor, L’età secolare (2007), tr. it. di P. Costa e M. C. Sircana, a cura di P. Costa, Feltrinelli, Milano 2009, p. 206): persino l’asocialità è socialmente determinata ed è resa possibile solo a partire da un orizzonte sociale di fondo.
14 Marx ed Engels possono così scrivere: «solo nella comunità [Gemeinschaft] con altri ciascun individuo ha i mezzi per sviluppare in tutti i sensi le sue disposizioni; solo nella comunità diventa possibile la libertà personale […]. Nella comunità reale gli individui acquistano la loro libertà nella loro associazione [Assoziation] e per mezzo di essa» (K. Marx – F. Engels, L’ideologia tedesca. Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del socialismo tedesco nei suoi vari profeti (1845-1846), tr. it. di B. Codino, introduzione di C. Luporini, Editori Riuniti, Roma 1975, pp. 54 s.). Proprio per questo nella kommunistische Gesellschaft lo sviluppo originale e libero degli individui non può che essere condizionato dalla Zusammenhang fra essi (cfr. ivi, p. 430), vale a dire che la società comunista certo non nega l’individualità, ma riconosce che la società non è costituita da individui, quanto piuttosto dalle relazioni materiali tra di essi (questo è il cum del comunismo): la vita individuale «abbraccia una grande cerchia di molteplici attività [Tätigkeiten] e relazioni [Beziehungen] pratiche con il mondo» (ivi, p. 245); «la società non consiste di individui [Individuen], bensì esprime la somma delle relazioni [Beziehungen], dei rapporti [Verhältnisse] in cui questi individui stanno l’uno rispetto all’altro» (K. Marx, Lineamenti fondamentali, cit., p. 242). In caso contrario si dà vita a vere e proprie Robinsonaden, «robinsonate» per le quali il punto di partenza viene considerato l’einzelne und vereinzelte individuo (cfr. ivi, pp. 3 s.), mentre persino l’interesse privato è configurabile solamente come elemento sociale, vale a dire che è possibile pensarsi come individui solo all’interno di una società che ha già posto i presupposti per farlo, ed è per questo che Marx poteva scrivere: «si tratta di interesse dei privati; ma il suo contenuto, come la forma e i mezzi della sua realizzazione, sono dati da condizioni sociali indipendenti da tutti. La mutua e generale dipendenza degli individui reciprocamente indifferenti [der gegeneinander gleichgültigen Individuen] costituisce il loro nesso sociale» (ivi, pp. 96 s.). Per un approfondimento di queste tematiche rimandiamo a L. Basso, Socialità e isolamento: la singolarità in Marx, Carocci, Roma 2008.
15 Cfr. K. Marx, Tesi su Feuerbach (1845), in K. Marx – F. Engels, Opere, V: 1845-1846, a cura di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 3-5.
16 Non deve allora sorprendere, sottolinea Esposito, che oggi alcuni tra i più importanti bioeticisti liberali (come Engelhardt o Singer) facciano esplicitamente riferimento al diritto romano, e in particolare alle figure di transito tra persona e cosa della manumissio e della municipatio, per articolare la loro concezione della persona (cfr. ivi, pp. 118-122).
17 Il riferimento di Esposito è allo scritto La persona e il sacro, dove tra le altre cose leggiamo: «la nozione di diritto è legata a quella di divisione, di scambio, di quantità. Ha qualcosa di commerciale. Evoca di per sé il processo, l’arringa. Il diritto non si sostiene che col tono della rivendicazione; e quando questo tono è adottato, la forza non è lontana, è subito dietro, per confermarlo, se no sarebbe ridicolo. […] Lodare l’antica Roma per averci trasmesso la nozione di diritto è singolarmente scandaloso. Perché se si vuole esaminare ciò che tale nozione era in origine, al fine di determinarne la specie, si vede che la proprietà era definita dal diritto di usare e abusare. E in effetti la maggior parte di quelle cose di cui ogni proprietario aveva il diritto di usare e abusare erano esseri umani. […] La nozione di diritto trascina naturalmente dietro di sé, per via della sua stessa mediocrità, quella di persona, perché il diritto è relativo alle cose personali. È situato a questo livello. Aggiungendo alla parola diritto quella di persona, il che implica il diritto della persona a ciò che si chiama la propria realizzazione, si farebbe un male ancora più grave» (in R. Esposito (a cura di), Oltre la politica. Antologia del pensiero impolitico, Mondadori, Milano 1996, pp. 75-78).
18 S. Weil, La persona e il sacro, cit., p. 78.
19 Cfr. T. Hobbes, De cive, cit., p. 23.
20 «Uomo sacro è, però, colui che il popolo ha giudicato per un delitto; e non è lecito sacrificarlo, ma chi lo uccide, non sarà condannato per omicidio; infatti nella prima legge tribunizia si avverte che “se qualcuno ucciderà colui che per plebiscito è sacro, non sarà considerato omicida”. Di qui viene che un uomo malvagio o impuro suole essere chiamato sacro».
21 Stato in cui, come negli ultimi mesi accade sempre più spesso in Italia ma non solo, a essere considerata normale è l’emergenza (nonché, con essa, il rischio e il pericolo).
22 Situazione che noi in Italia stiamo vivendo in maniera drastica negli ultimi mesi: colui che controlla governo, principali mezzi di comunicazione e di informazione e gran parte del movimento economico del nostro paese si ritrova a essere considerato come dispensatore personale (e spesso nei confronti di persone perlomeno poco raccomandabili) di ricchezze, di posti di lavoro, di abitazioni, persino di incarichi politici, come padre padrone di parlamentari, «attrici», politici, imprenditori, come vero e proprio detentore di un potere totale sulle vite di questi, costretti ad accettare la totale dipendenza per poter aspirare a una qualche forma di (evidentemente menzognera) indipendenza.
23 Analogamente a come un processo nei confronti dei parlamentari italiani deve passare attraverso il filtro dell’immunità e della votazione del Parlamento, o a come un processo per prostituzione minorile rivolto nei confronti di un esponente del Governo italiano (o, come ben sappiamo, del Capo di esso) può dover essere istituito presso lo specifico Tribunale del Consiglio dei Ministri.
24 F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra (1844), in K. Marx – F. Engels, Opere, IV, cit., pp. 235-514: 263.
25 Ivi, p. 362.
26 Ibidem.
27 T. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni sulla vita offesa (1951), tr. it. di R. Solmi, introduzione e nota di L. Ceppa, Einaudi, Torino 1994, p. 3.