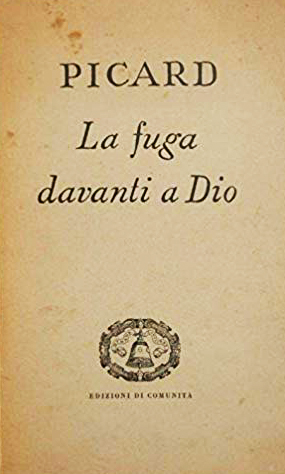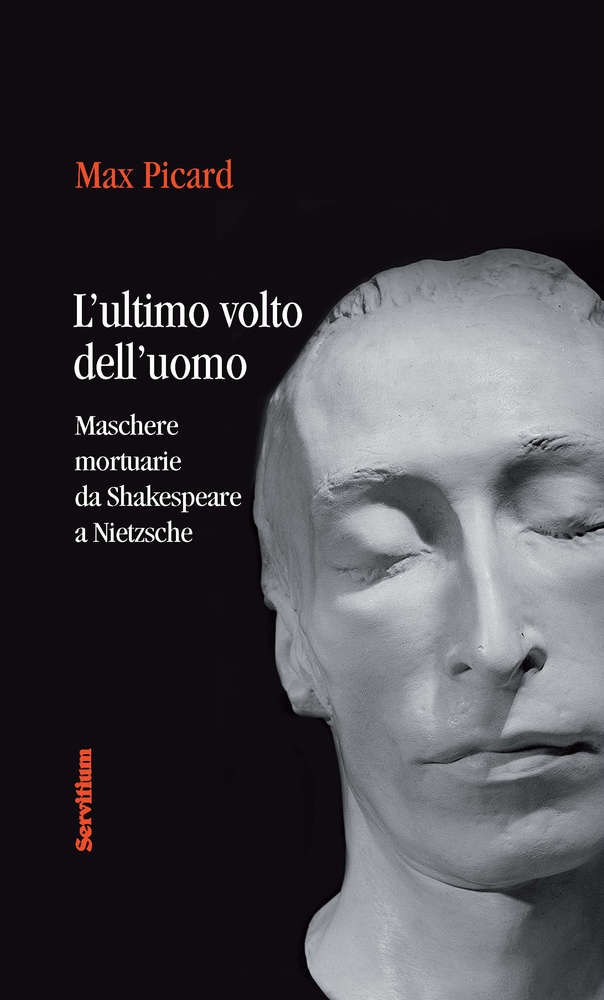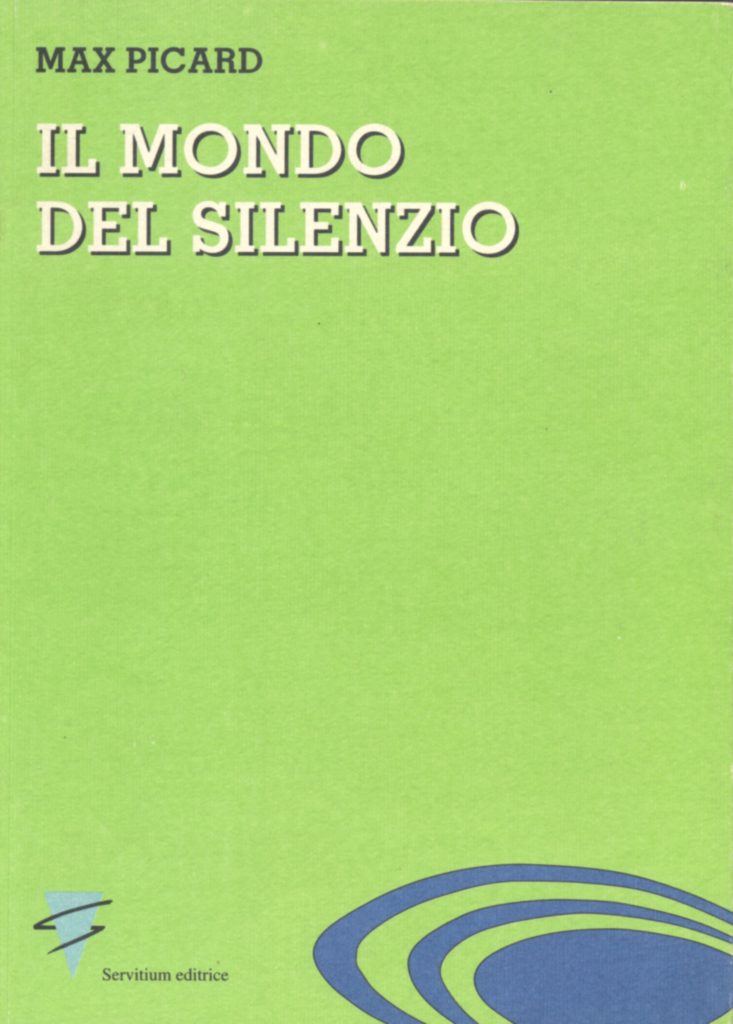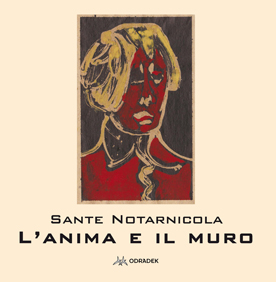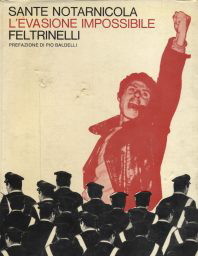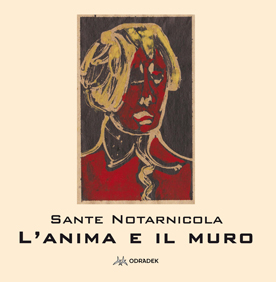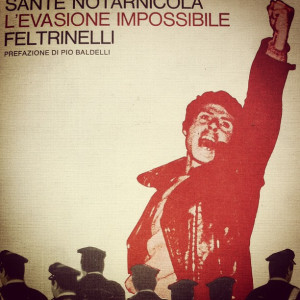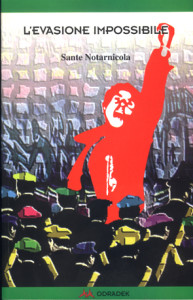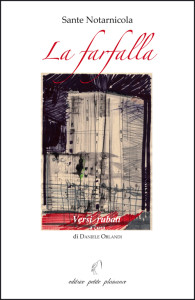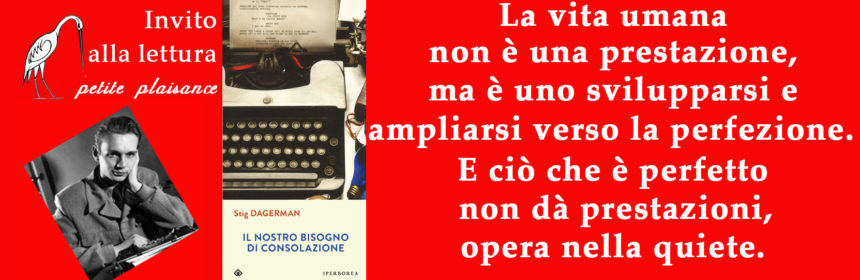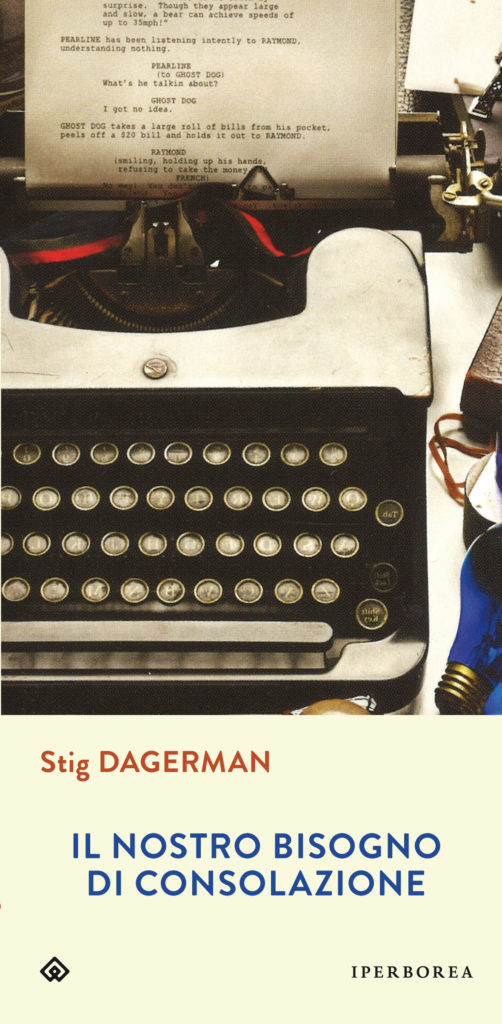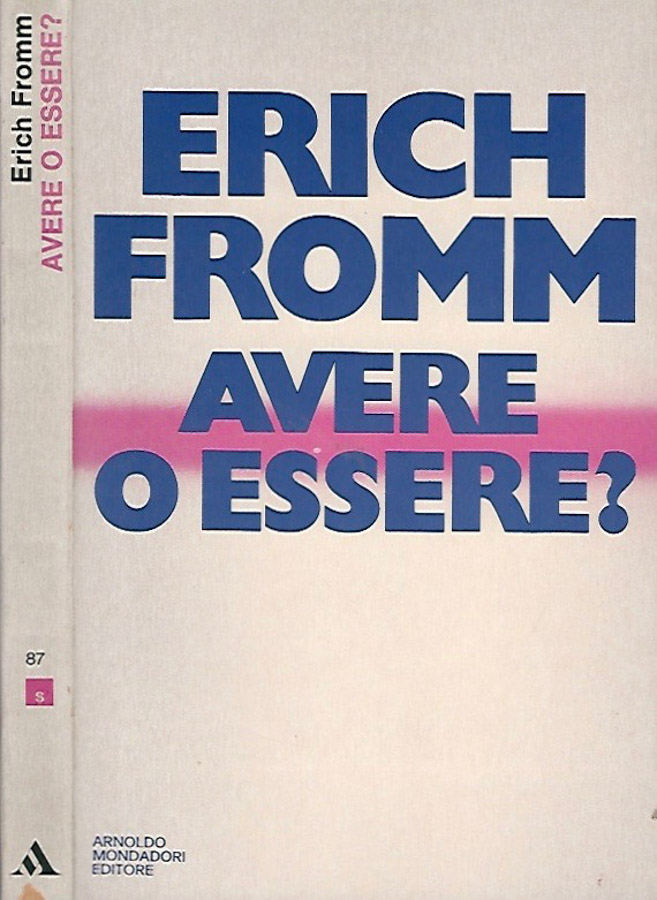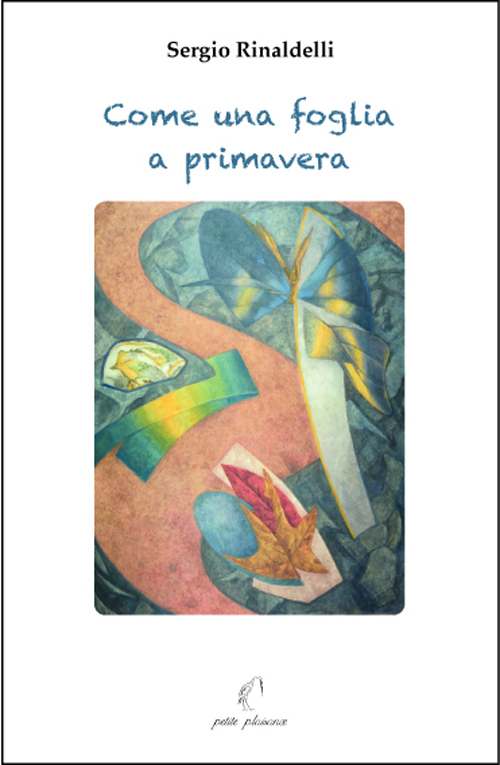Max Picard (1888-1965) – Il silenzio emerge dal frastuono del mondo attuale perché sta al di fuori della dimensione dell’utile. La parola non avrebbe profondità, se le mancasse lo sfondo del silenzio. La parola sorge dal silenzio.
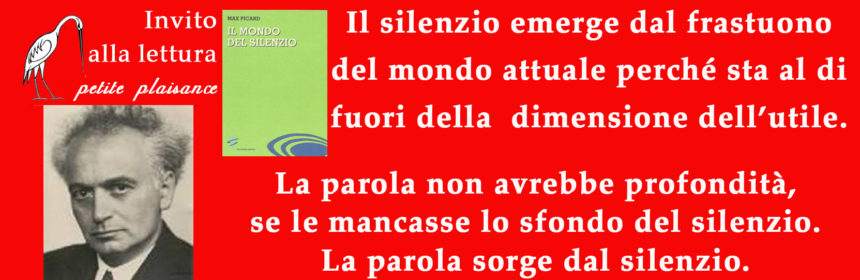
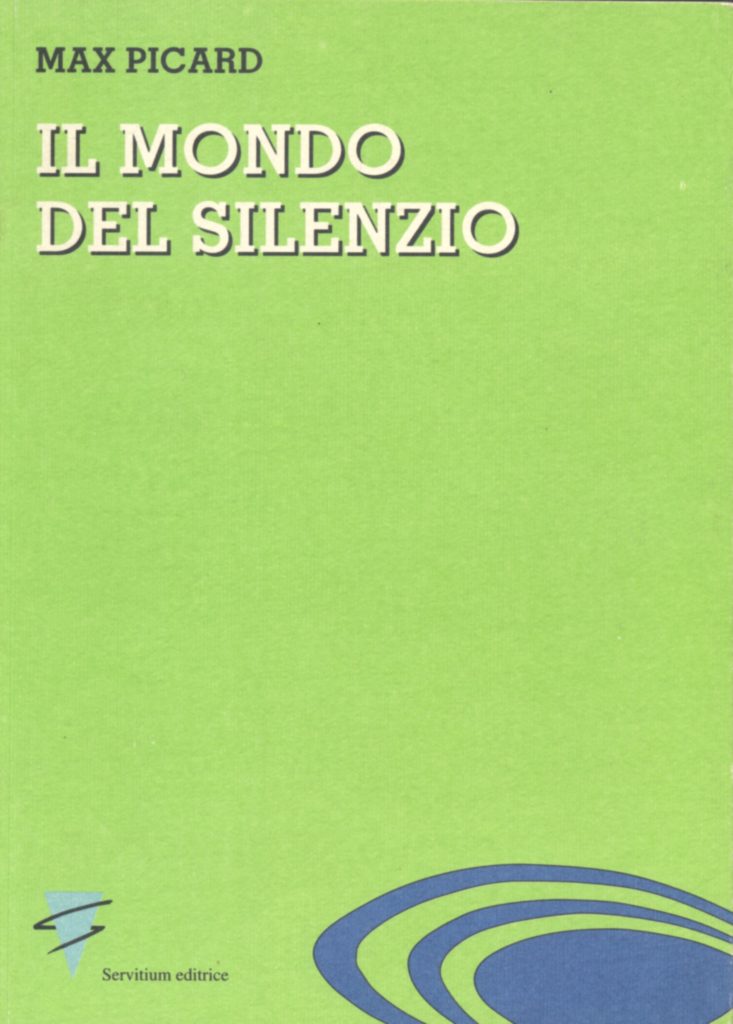

Max Picard, nato in Germania da genitori ebrei svizzeri, studiò medicina. Vicino al cristianesimo anche se rimase fedele all’origine ebraica. Abbandonò ben presto la pratica medica per dedicarsi interamente al pensiero filosofico. Tra i suoi libri più importanti, e tradotti in tutte le lingue europee e anche in giapponese, coreano e cinese, L’ultimo uomo (1921), La fuga davanti a Dio (1934), Hitler in noi stessi (1946), Il mondo del silenzio (1948), L’ultimo volto. Maschere mortuarie da Shakespeare a Nietzsche (1959).

Le grandi parole giungono nel delicato frullio quasi impercettibile di un’ala di colomba aveva già affermato Nietzsche. Max Picard (Schopfheim, 5 giugno 1888 – Sorengo, 3 ottobre 1965) è uno degli eroi gentili della filosofia, dimenticato da molti. Ma le sue parole, la sua vita attraversano lo spazio ed il tempo della tecnocrazia per parlarci ancora, se si intenziona l’udito per accogliere parole metafisiche, parole per la trascendenza. Il capitalismo assoluto impone capillarmente parole finalizzate esclusivamente al bisogno ed all’utile, ma le parole possono essere l’immagine profonda dell’essere umano, se muovono al desiderio della totalità, se mostrano che il bisogno ha legittimità ad esserci solo in tensione con la parola metafisica. Max Picard ha vissuto l’esperienza del silenzio profondo, della creazione metafisica con coerenza. La filosofia è prassi, comportamento consapevole e teleologico, altrimenti si è solo facitori di parole. Max Picard, laureato in medicina e medico di valore, dinanzi al cartesianesimo della medicina, al rifiuto di ogni approccio sistemico, ha rinunciato alla professione medica per vivere nel Ticino. Cercava luoghi dove il silenzio fosse ancora possibile per vivere la sua umanità. Il silenzio non divide, ma unisce alla comunità, alla natura, a Dio.
Lo scandalo del silenzio

Il silenzio è scandalo per il capitalismo assoluto, perché dove il silenzio prende dimora, appare l’essere umano. Nel silenzio della parola tacciono le parole dell’utile, della televendita perenne, dell’onnipresenza dell’immagine allo scopo di muovere i bisogni per necrotizzare il desiderio metafisico dell’altro e di sé.
Il silenzio è scandalo, perché non si può vendere. Il silenzio favorisce l’unità, palesa la menzogna quotidiana del frastuono delle merci che tutto silenziano con la violenza dell’astratto che annichilisce la vita:
«Il silenzio è oggi l’unico fenomeno “senza utile”. Esso non conviene al mondo di oggi che è mondo dell’utile, non ha nulla di comune con questo mondo, sembra privo di qualsiasi scopo, non si presta allo sfruttamento. Il mondo dell’utile si è annessi tutti gli altri grandi fenomeni. Persino lo spazio fra cielo e terra è ridotto oggi a un pozzo luminoso che serve solo a far volare gli aeroplani. L’acqua e il fuoco, gli elementi, sono assorbiti dal mondo dell’utile e considerati solo in quanto prendono parte alla vita di questo mondo, perduta ormai ogni esistenza indipendente da esso. Invece il silenzio sta al di fuori del mondo dell’utile, non è possibile “farsene” nulla, dal silenzio non si ricava nulla nel vero senso della parola; il silenzio è improduttivo e quindi privo di qualsiasi valore».[1]
Frastuono e parola
Il silenzio è proprio dell’umano. La parola necessita del silenzio perché crei ed autocrei se stessa. Malgrado la pervasività del chiasso, il silenzio resta sul fondo della natura umana come la sua possibilità più propria. Il furore del mondo, con i suoi ritmi poietici, non può azzerare la forza della parola parola, che indica la non verità del rumore dell’utile, le sue dissonanze, la sua aggressività ideologica. Il bisogno necessita del gesto, del meccanicismo, il cui fine è assicurare la sopravvivenza. In tal senso l’essere umano è simile agli altri animali non umani. Ma la parola non ha la sua genealogia nel gesto, nella biologia, perché è creatività, impalpabile presenza tesa verso la totalità:
«Il silenzio emerge dal frastuono del mondo attuale come alcunché di remoto. Non però come una cosa morta, bensì come un giacente ma vivo animale preistorico. Si scorge tuttora il dorso possente del silenzio, ma l’intero corpo affonda sempre più in mezzo alla sterpaglia degli odierni clamori e come se quell’animale di altri tempi affondasse lentamente nel limo del proprio silenzio. Eppure tutto il frastuono di oggi sembra solo un mormorio di insetti ronzanti intorno all’immane dorso di quell’animale preistorico, il silenzio».[2]
Gesto e parola

La parola non è mera attività fonetica, la sua genesi non è meccanicamente legata agli apparati fonatori. La parola ha come radice il silenzio. L’essere umano è un albero le cui radici sono nel metafisico: l’immagine metafora di Platone nel Timeo rende la verità della parola. Essa si genera in modo libero per entrare nella contingenza della storia. L’utile teme la parola. La riduzione della libera parola in spazi sempre più ristretti rivela la verità del capitalismo assoluto: la libertà, la parola che genera mondi in una ascesi erotica verso un universale irraggiungibile svela la verità dell’essere umano. L’umanità non è semplicemente un legno storto, secondo la definizione di Kant, o un lupo, secondo la metafora di Hobbes. L’essere umano è sempre oltre i semplicismi ideologici che imprigionano la parola in angusti recinti interiori, mentre lo lasciano “libero” di perdersi negli spazi della globalizzazione:
«Il silenzio può stare senza la parola, ma la parola non può stare senza il silenzio. La parola non avrebbe profondità, se le mancasse lo sfondo del silenzio. Tuttavia il silenzio non è superiore alla parola, ma anzi il silenzio in sé e per sé, il mondo del silenzio senza la parola, è solo qualche cosa di precedente alla creazione, è creazione non ancora compiuta, creazione imminente. Proprio perché la parola sorge dal silenzio, il silenzio passa dallo stato di pre-creazione a quello di creazione, dal non storico allo storico umano, e in prossimità della parola diventa parte dell’uomo e parte integrante e indispensabile della parola. Ma la parola è superiore al silenzio anzitutto perché solo in essa la verità si fa immagine. L’uomo diventa tale per mezzo della parola».[3]
La catabasi del silenzio

Il frastuono divide. La parola, nella forma della riduzione dell’altro a strumento per i propri bisogni, non è parola, ma estroflessione dei bisogni. Di conseguenza non può esserci, in questa circostanza/contingenza, che l’atomismo sociale: solitudini speculari che raccontano la stessa storia. La parola, il logos, che si prepara nel silenzio, in una dimensione distante dal fenomeno, è già comunità, perché nel silenzio-parola gli esseri umani ritrovano il volto dell’altro ed il proprio.
L’alienazione è il rumore che distrae da sé e dagli altri per vivere mille vite al giorno nell’ottica dell’utile senza toccare, mai, neanche per un attimo se stessi e gli altri. Nel silenzio il soggetto umano si scopre parte di una totalità storica, contingente eppure metafisica. La catabasi (κατάβασις “discesa”, da κατα- “giù” e βαίνω “andare”), la responsabilità politica, non può che iniziare con l’anabasi (ἀνάβασις, der. di ἀναβαίνω «salire») del silenzio:
«Dove arriva il silenzio, l’individuo non avverte nessuna opposizione fra sé e la comunità, poiché individuo e comunità non sono reciprocamente opposti, ma entrambi opposti al silenzio, e quindi la differenza fra individuo e comunità vien meno di fronte al potere del silenzio. Oggi di fronte al silenzio non sta più l’individuo, né la comunità ma un frastuono generale, e individuo è solo colui che non ha più il frastuono, il frastuono comune, ma non ha nemmeno il silenzio. È isolato dal rumore e isolato dal silenzio, è un derelitto».[4]

Affinché ci sia rivoluzione necessitiamo di riascoltare il silenzio, per discernere il bene dal male, il senso dal non senso. Il silenzio rivela che l’essere umano è abitato dalla trascendenza nella sua pluralità di forme.
Salvatore A. Bravo
[1] Max PIcard, Il mondo del silenzio, Edizioni Comunità, 1951, p. 10.
,[2] Ibidem, p. 16.
[3] Ibidem, p. 23.
[4] Ibidem, pp. 73-74.
***********************************************
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.