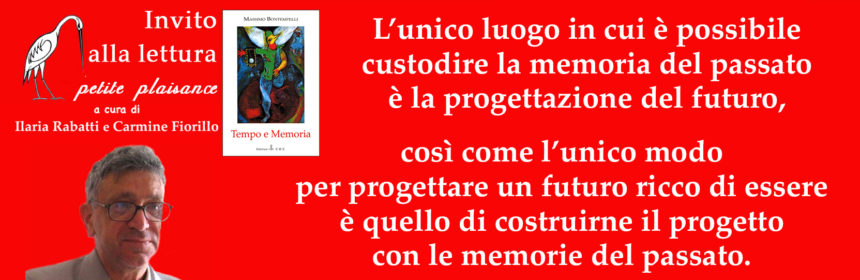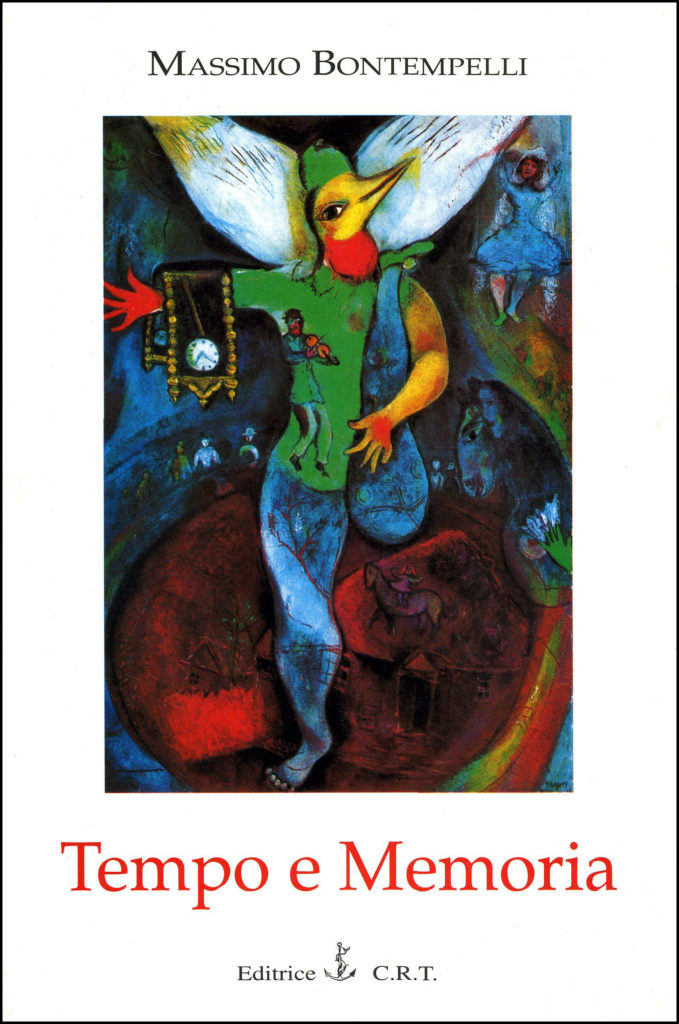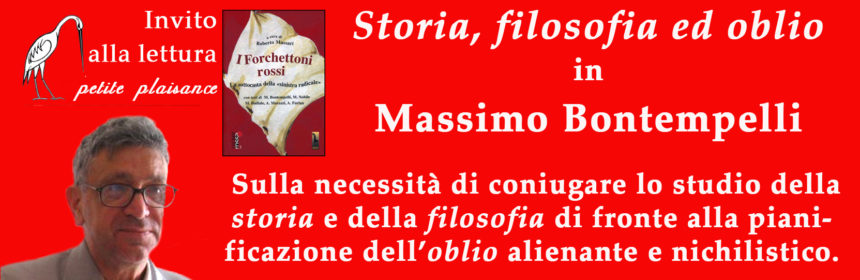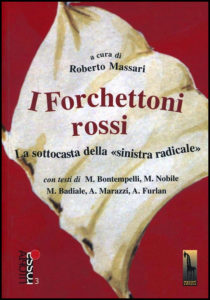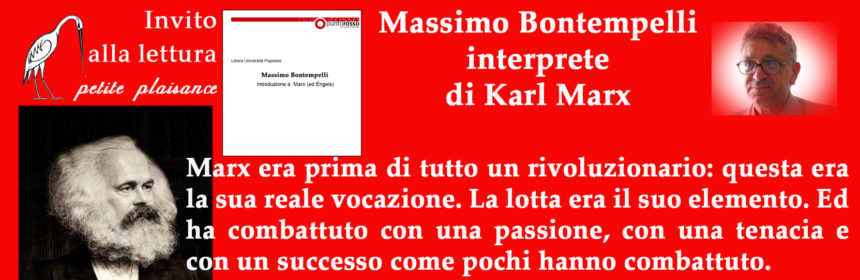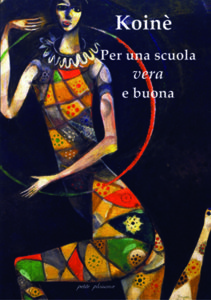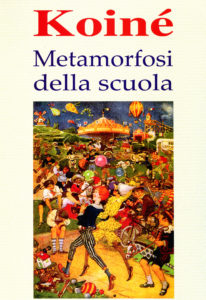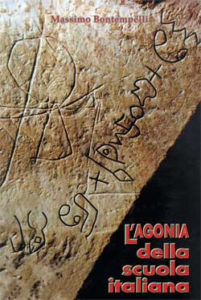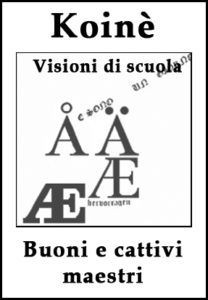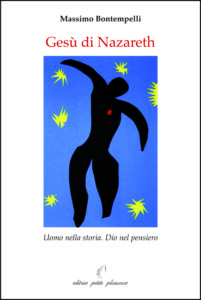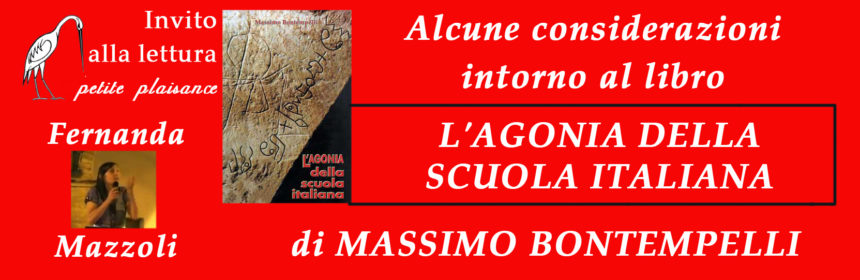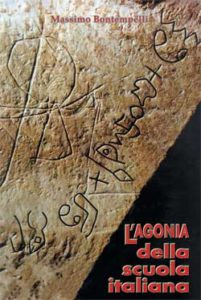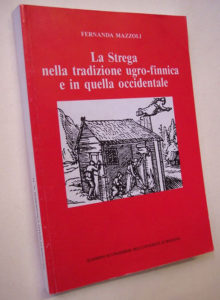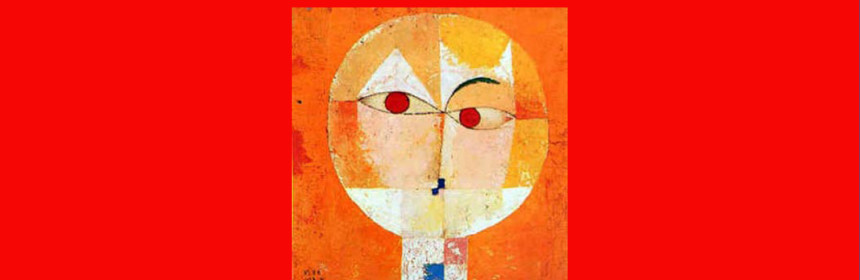Salvatore Bravo – L’irrazionale-razionale del capitalismo si palesa con la legge della “nuova civiltà”: l’arbitrarismo.

Salvatore Bravo
L’irrazionale-razionale del capitalismo si palesa
con la legge della “nuova civiltà”: l’arbitrarismo
L’irrazionale razionale del capitalismo
La legge della “nuova civiltà” è l’arbitrarismo
Il concetto di «arbitrarismo»
False soluzioni
Città senza cittadinanza
La verità del traffico veicolare
La funzione “dis-educativa” del traffico veicolare
Riforma del paradigma privatistico
Conclusione
L’irrazionale razionale del capitalismo
L’irrazionale razionale è la cifra del capitalismo assoluto. La definizione è del filosofo Massimo Bontempelli. L’irrazionale-razionale del capitalismo assoluto lo si può cogliere in ogni aspetto del quotidiano: è sufficiente seguire il filo d’Arianna della categoria della totalità per mostrare quanto la “razionalità” del capitalismo assoluto, se ricondotta al concreto, palesi la sua irrazionalità. Nell’immediato, la razionalità comporta il calcolo delle azioni da effettuare per ottenere il plusvalore. In realtà, se il cono di luce allarga il suo raggio di visuale, l’irrazionalità del razionale capitalistico si svela nella sua violenza: il consumo diviene dispendio di risorse umane ed ambientali, l’accumulo si ribalta in irrazionalità, perché nega il fine per il trionfo del mezzo. Il capitalismo è irrazionale perché antimetafisico.
Il capitalismo speculativo è la realizzazione compiuta della logica del plusvalore, il quale si muove in due direzioni per occupare ogni spazio fisico e mentale. Il plusvalore relativo è finalizzato ad occupare ogni spazio della coscienza saturandola con l’intromissione di parole per il solo calcolo e rappresentazioni di sole merci, la mente si trasforma in semplice specchio dell’immediato, mentre il plusvalore assoluto sfrutta la forza lavoro, precarizza. Il plusvalore relativo, con i suoi sogni mediatici addomestica le masse, il popolo da demos (δῆμος) consapevole e disposto all’agire della prassi è sostituito dal laos (λαός), ovvero dalla massa depauperizzata della coscienza che si rimette alle parole del “ministero della verità” perennemente in azione con il fine di sussumere e reificare. Il popolo, privo e deprivato di domande, si rimette al capo, inneggia all’uomo forte, è pronto a seguirlo, “educato” ad essere oggetto della storia.
La legge della “nuova civiltà” è l’arbitrarismo
La guerra è lo stato perenne dei popoli proni al “ministero della verità”. Si manifesta, in modalità esponenziali, in circostanze che necessitano l’abbattimento del nemico che si oppone al nuovo ordine del discorso. Ma la guerra è la condizione quotidiana delle nuove plebi. Essa si manifesta nella competizione senza limite, nell’ossessione individualista e narcisista, nel riduzionismo generalizzato. L’io minimo è perennemente belligerante, poiché sostituisce la ricerca di sé con le operazioni di acquisizione. I popoli sono in guerra, perché senza domande. Ogni epochè dell’agire acquisitivo è messo alla pubblica berlina. Alla parola che unisce dev’essere sostituita la violenza della parola che divide, alla relazione umana il libero scambio quale religione unica ed assoluta della globalizzazione. La legge della “nuova civiltà” è l’arbitrarismo, come l’ha definita Massimo Bontempelli. In assenza di vincoli comunitari ed assiologici, ogni esperienza umana e luogo di condivisione sono sussunti alla logica acquisitiva.
Il concetto di «arbitrarismo»
Attraverso il traffico veicolare e lo spazio che esso occupa Massimo Bontempelli denuncia l’arbitrarismo, una nuova forma di nichilismo acquisitivo e proprietario con il quale lo spazio pubblico è svuotato del suo senso per essere occupato dai privati, fino ad essere pubblico in senso formale, ma di fatto è privatizzato a spese del pubblico:
«Basta ragionare, per capire quale sia questo presupposto: è quella forma di nichilismo che abbiamo chiamato arbitrarismo, qui espressa nella concezione secondo cui è un diritto della persona libera quello di usare a piacere lo spazio pubblico per spostarvisi con un proprio privato abitacolo semovente».[1]
Lo sfruttamento si concretizza per sottrazione: erodere ogni spazio pubblico e sostituirlo con il mercato, che in modo capillare cancella nel concreto lo spazio pubblico per eliminare dalla comunità la disposizione alla condivisione. Si opera sulla percezione concreta dello spazio vissuto che dev’essere occupato dal traffico veicolare per essere anche mercato espositivo gratuito perennemente in azione delle auto. I veicoli nelle pubbliche strade muovono al desiderio di acquisto irriflesso dei pedoni e non. Lo sfruttamento del popolo si manifesra anche nella forma dell’occupazione dello sguardo che essendo esposto al traffico veicolare in modo continuo, introietta l’acquisto e l’uso delle auto come una necessità irrinunciabile. Lo spazio si deforma, in quanto è vissuto come oggetto da conuistare e non da conoscere e vivere. Lo sguardo, l’udito, il tatto diventano i canali in cui la merce penetra ed occupa il corpo vissuto. Ci si abitua alla normalità del rumore come dei gas di scarico, si naturalizza l’artificiale. Il traffico occupa lo spazio come l’aria, anche quest’ultima è al servizio degli esiziali interessi privati, è “occupata” dai gas come dall’inquinamento sonoro. Si deve mutare l’olfatto e l’udito, affinchè l’innaturale sostituisca le condizioni che consentono la socializzazione e la dialettica del pensiero. Lo spazio cittadino da agorà dell’incontro diventa mercato totale.
La violenza del traffico è l’espressione immediata del capitalismo speculativo, risponde ad esigenze immediatamente razionali, ma in realtà ha l’effetto – nel suo moltiplicarsi incontrollato – di occupare ogni spazio fisico e mentale fino al loro annichilimento.
False soluzioni
Il traffico può procurare fastidio in alcuni, si possono denunciare gli effetti immediati, ma tali critiche non colgono la profondità del problema, restano all’interno dell’empirico, registrano i dati dell’inquinamento, ma non colgono la verità del fenomeno traffico, gli interessi privati che si celano dietro l’occupazione del suolo pubblico:
«Un po’ tutti si lamentano del cosiddetto traffico, sia pure a livelli diversi, corrispondenti a diversi gradi di sensibilità. Le persone di più consistente spessore umano non sopportano il sequestro allucinante di tutte le strade in tutte le ore alla socialità comunicativa, ad opera dei veicoli che invadono ogni spazio, lo percorrono spesso in modo pericoloso, lo ammorbano di gas, lo rendono costantemente pericoloso». [2]
Le critiche, le lamentale, non turbano i poteri, in quanto esse non producono alternative, poiché non sono estranee al problema nella sua abissale profondità, e non conducono alla prassi, anzi, le critiche impotenti sono sollecitate, perché sono l’orpello della democrazia formale.
Si cerca di risolvere il problema senza cambiare gli equilibri sociali, senza mettere in discussione la struttura economica e la sovrastruttura culturale. Si sposta il traffico in altre zone della città, si libera una parte minuscola della città rappresentandola come svolta green, come l’inizio di un nuovo modo di vivere e di abitare la città per lasciare tutto inalterato, anzi si ammorbano maggiormente parti della città, spesso abitate dai ceti meno abbienti subiscono gli effetti del dirottamento ecologico. Il consumo del territorio, l’inurbamento di aree sempre più ampie, in presenza di calo demografico, comporta la costruzione di strade su cui percorrere distanze sempre più ampie. Le strade attraggono auto, sono il segno che invita al loro uso, alla cultura del dominio e della sottomissione del suolo:
«Succede, però, che l’ampliamento degli spazi a disposizione delle automobili attira nuove automobili, ed i problemi di scorrevolezza si riproducono con il passare del tempo identici, ma con quantità maggiori di veicoli, e quindi con più devastanti effetti ecologici». [3]
Lo spazio liberato dal traffico è diversamente sussunto alle logiche acquisitive: si eliminano le auto per sostituirle con il traffico dei consumatori. Lo spazio di vita dev’essere sotto l’imperio della reificazione, per cui le zone liberate dal traffico sono occupate dalla medesima logica acquisitiva: nessuno spazio deve sfuggire allo scambio mercantile.
Città senza cittadinanza
Le soluzioni propagandate come ecologiche ed innovative, riproducono la struttura gerarchica dell’integralismo economico, la città è divisa in due strati: la superficie per gli automobilisti, sotto terra – con la costruzione delle metropolitane – i pedoni. La divisione degli spazi spesso coincide con la subalternità dei pedoni all’automobilista. Si gerarchizzano gli spazi: le auto sempre più costose per il loro mantenimento sono dei più ricchi, di coloro che non sono ancora del tutto precarizzati, mentre i pedoni chiusi nel loro buio orizzonte, nella caverna metropolita giudicano naturale la propria condizione:
«Per migliorare la circolazione urbana, si sono costruite metropolitane, ma in questo modo, dirottando i pedoni sotto terra , si è resa più forte l’idea che le città appartengono agli automobilisti, e si sono creati nuovi flussi di traffico da e per le stazioni delle metropolitane». [4]
Il traffico educa all’isolamento gli automobilisti rinchiusi ed al sicuro nell’abitacolo del veicolo imparano l’atomistica delle solitudini, i pedoni subiscono l’occupazione dello spazio pubblico, si abituano alla privatizzazione dello Stato. La città – curvata al solo valore di scambio – è città senza agorà e dunque è lo spazio realizzato del nichilismo, poiché lo spazio non è per gli esseri umani, ma è finalizzato allo scambio mercantile, alla violenza del plusvalore. Le violenze che attraversano le città contemporanee sono l’epifenomeno della negazione della città come convivialità e comunità, al suo posto non vi è che la violenza sulle ruote e del cemento. Il cittadino non è parte della comunità cittadina, ma assiste e serve la bestia selvaggia del mercato. Si assiste alla costruzione della spazialità piena, ingombra di merc. Il traffico diviene modello spaziale, per cui l’unico spazio possibile e vivibile è nella sola pienezza delle merci.
La verità del traffico veicolare
L’auto è la cinghia di trasmissione della privatizzazione. L’automobilista occupa lo spazio pubblico in modo diretto, e ne è separato, chiuso e racchiuso in un abitacolo che lo divide e che gli impedisce il contatto percettivo con il mondo esterno, lo guarda velocemente alla ricerca della sua meta, la quale è sempre funzionale ai suoi calcoli privati: il mondo intero è cancellato in nome dei personalissimi intendimenti privati:
«L’automobile, invece, essendo un abitacolo chiuso, sposta l’individuo attraverso lo spazio pubblico mantenendolo estraneo. Essa, cioè non è soltanto un mezzo privato di circolazione nello spazio pubblico, ma è anche uno spazio privato nello spazio pubblico, come fosse una piccola casa semimovente, o una stanza distaccata della casa spostabile nelle strade. […] L’automobile, quindi, determina la privatizzazione dello spazio pubblico non in quanto è un mezzo di proprietà privata, ma in quanto è uno spazio privato che si mantiene tale nello spazio pubblico. La privatizzazione dello spazio pubblico determinata dall’automobile ha creato modelli di comportamento collettivo che sono aberranti, e tuttavia generalmente accettati come normali».[5]
Lo spazio sotto l’effetto del traffico manifesta la verità della città nel tempo del capitalismo assoluto: non è più luogo della dialettica dell’incontro, ma è nella sua interezza valore di scambio, mercificazione totale degli spazi i quali sono occupati in nome della violenza del valore di scambio. La città non è più abitata, non ha più storia, ma è solo un immenso spazio espositivo per consumatori senza speranza.
Il gigantismo delle auto, inoltre, è l’espressione dell’onnipotenza del privato sul pubblico: auto dall’aspetto sempre più minaccioso palesano la potenza del privato. Il corazzamento veicolare causa l’espulsione dalla strada del pedone, che si ritrae dinanzi alla possibilità d’essere schiacciato dalla potenza automobilistica, la quale perde la sua funzione di spostamento veicolare per sottolineare la tracotanza sociale dei nuovi padroni sui normali pedoni. La minaccia è anche nel rumore assordante, vero strumento di inibizione del pensiero libero. Le città si estendono divorando suolo e spingendo folle umane verso la marginalità urbana. La violenza del sistema capitale si svela e nel contempo si struttura come abitudine intrascendibile.
La funzione “dis-educativa” del traffico veicolare
Il sistema del capitalismo assoluto si regge sulla divisione, sulla deformazione dei sensi come dei sentimenti: si deve imparare ad inseguire solo gli interessi privati ed a cancellare il pubblico. L’automobilista rappresenta il microcosmo del capitalismo assoluto, egli è astratto dalla realtà concreta e sfrutta la strada pubblica per fini privati. Gli automobilisti “rischiano” di diventare il mezzo con cui il capitalismo estende le sue logiche:
«L’automobilista, in realtà, è una figura la cui logica di comportamento replica su scala di massima quella dell’imprenditore capitalistico, caratterizzata dall’uso privato di risorse pubbliche (nel caso dell’automobilista dello spazio stradale), e dell’esternalizzazione dei costi della sua attività (nel caso dell’automobilista la circolazione), che diventano così da privati costi sociali».[6]
La privatizzazione della vita negli ultimi anni si è estesa con mezzi ulteriori. Si pensi ai telefoni cellulari, allo sguardo perennemente rapito da immagini e messaggi, spesso vacui, che corrono sulle linee telefoniche. Anche il pedone non guarda la strada, ma costantemente resta legato alla catena della sua vita astratta, separata dalla collettività. Le nuove catene invisibili si moltiplicano, ed in esse ci si avvolge con la stessa normalità con cui si respira. L’auto prepara l’imprenditore, poiché forma all’occupazione del suolo pubblico, al suo sfruttamento, mentre il pedone prepara il precario, poiché formato alla passività ed alla naturalizzazione delle gerarchie sociali.
Riforma del paradigma privatistico
Risolvere il problema del traffico è possibile solo se si cambia paradigma di lettura del reale. Le soluzioni messe in atto in nome della svolta ambientale, stile Greta, hanno il fine solo di perpetuare lo stato di cose attuale. Il paradigma può cambiare solo se la consapevolezza, sempre collettiva (Geist), diviene motore di un cambiamento della struttura e della sovrastruttura. Si assiste invece a cambiamenti parziali per occultare il macrodato che il pianeta non regge a tali logiche arbitraristiche. Massimo Bontempelli propone, così, la sostituzione del traffico con il rafforzamento dei mezzi pubblici espressione di un senso della comunità ritrovata:
«I problemi creati dall’automobile, cioè, non possono essere sensatamente affrontati se non con nuovo paradigma di pensiero che legittimi livelli progressivi di interdizione e penalizzazione del mezzo automobilistico. Occorre, in primo luogo, contrariamente, a quanto suppone il senso comune, smettere subito di potenziare la rete stradale, e sviluppare invece il trasporto su rotaia. […] Alle crescenti difficoltà di usare le automobili si dovrebbe rispondere con l’offerta di migliori e più convenienti trasporti pubblici». [7]
Conclusione
L’analisi del traffico veicolare denota e connota il capitalismo assoluto, capace di produrre ricchezza e nel contempo di distruggere – con la sua irrazionale razionalità – l’ambiente e la socialità.
Le miserie del capitalismo speculativo sono innumerevoli, producono miseria materiale nelle nazioni che subiscono il neocolonialismo, ma anche forme di miseria ambientale ed etica che non rientrano nei pubblici dibattiti nei paesi ad economia avanzata. L’integralismo economico è per sua istituzione e storia adialettico al punto che il silenzio di ogni opposizione è oggi denominata inclusione:
«Il modo di produzione capitalistico ha ormai storicamente svelato la sua natura spaventosamente distruttiva su molteplici piani. Esso ha creato ricchezza economica ad un livello mai raggiunto da alcun sistema precedente. Ma la creazione capitalistica di nuova ricchezza ha dimostrato di essere, allo stesso tempo, creazione di nuove povertà, distruzione della socialità degli esseri umani, della loro sanità psichica, dell’ambiente naturale adatto alla loro vita biologica, delle risorse per il loro futuro. Esso è ormai la maledizione del genere umano, che è condannato, per creare e distribuire ricchezza secondo i rapporti di produzione capitalistici, in maniera sufficiente a mantenere un minimo di equilibrio sociale, a vivere in modo sempre più distruttivo nei confronti della natura e di se stesso».[8]
Il breve scritto di Bontempelli, dunque, non è solo una riflessione sul traffico, ma insegna a filosofare, ad assumere un comportamento antidogmatico, a pensare per agire e vivere diversamente. L’attività filosofica consiste nell’interrogare il noto, per scoprire che è sconosciuto. Tale processo implica il passaggio da uno stato di passività ad uno di attività consapevole e concettuale.
Se i tempi paiono lontani dalla rivoluzione del paradigma, i testi di Bontempelli consentono comunque di far rimanere in vita idee e concetti che possono essere ritrovati e avere nuova fioritura, in quanto ciò che ora appare come intrasmutabile con la propagandata «fine della storia» ideologicamente onnipresente nei ministeri della (falsa) verità del capitalismo, già lavora per il suo superamento anche se in tempi non profetizzabili.
Salvatore Bravo
[1] Massimo Bontempelli, L’arbitrarismo della circolazione autoveicolare, C.R.T.- Petite Plaisance, Pistoia 2001, pag. 7.
[2] Ibidem, pag. 5.
[3] Ibidem, pag. 6.
[4] Ibidem.
[5] I Ibidem, pp. 9-10.
[6] Ibidem, pp. 11.
[7] Ibidem, pp. 12-13.
[8] Massimo Bontempelli – Marino Badiale, Per salvare la vita. 28 tesi contro la barbarie.