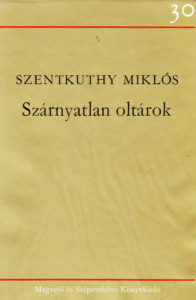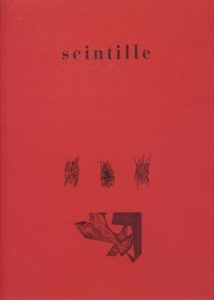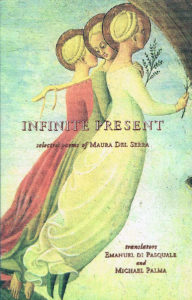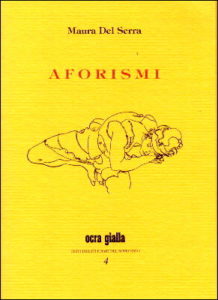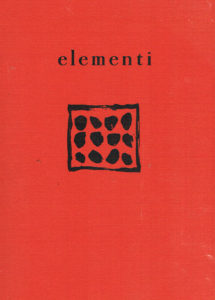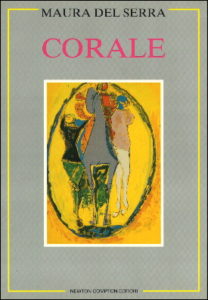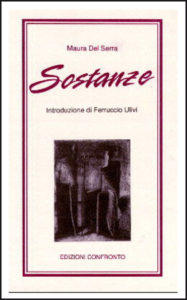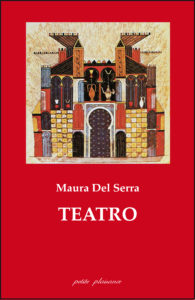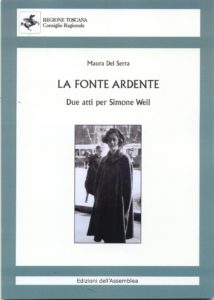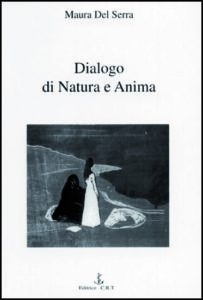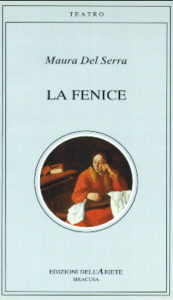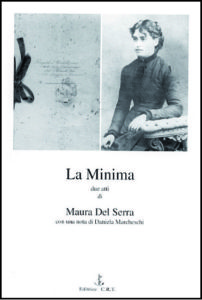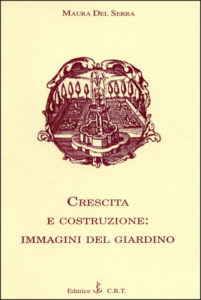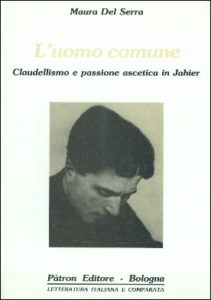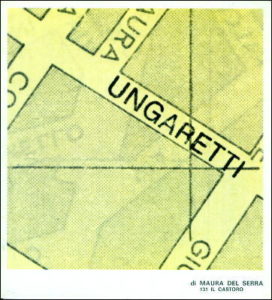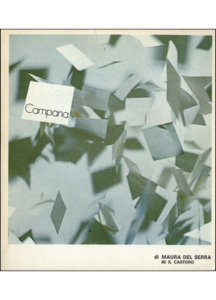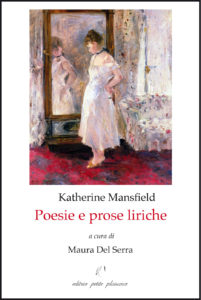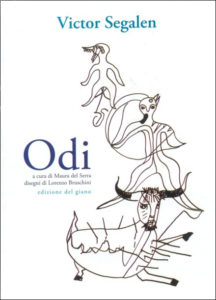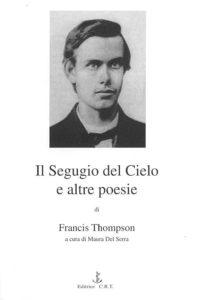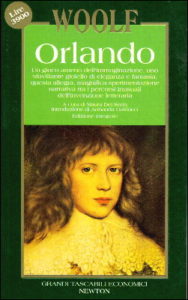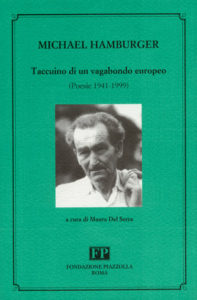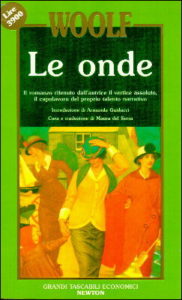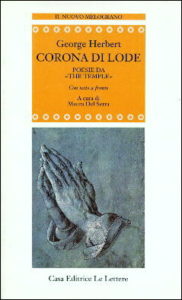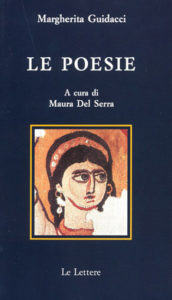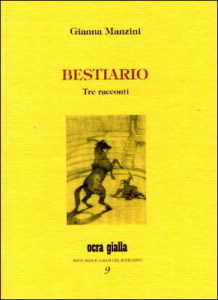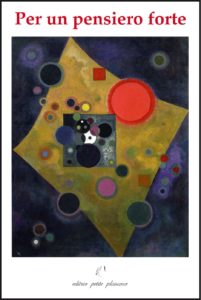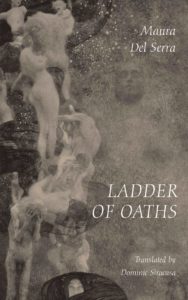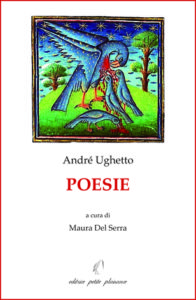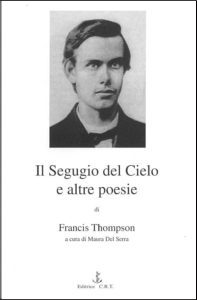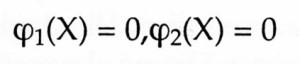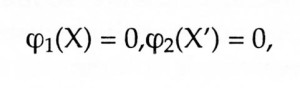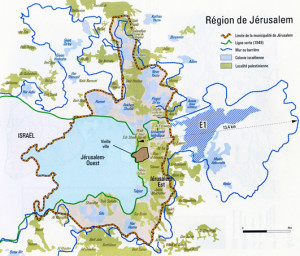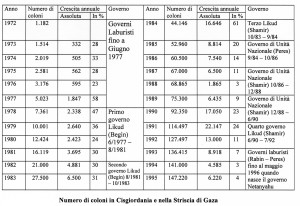«Fermate la colonizzazione di Gerusalemme Est»
Premessa
- La colonizzazione dei territori occupati
- Lo studio sulla colonizzazione di Gerusalemme-Est
- La documentazione UE su Gerusalemme-Est
- L’insabbiamento della documentazione
- Conclusioni
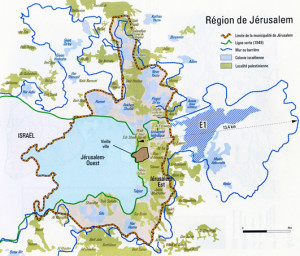
- Premessa
Era mia intenzione affrontare in questo saggio la colonizzazione di Gerusalemme-Est, senza per questo dimenticare la violenta e sempre operante colonizzazione, da parte degli israeliani, di tutta la Cisgiordania. E avevo anche deciso di non prendere in considerazione tutto il rumore propagandistico che si nasconde dietro le due formule ormai stantie (e soprattutto false!) “Processo di pace” e “Due popoli, due Stati” dal momento che, vuote entrambe ormai, e da tempo, di contenuto, avrebbero finito col nascondere nella sostanza la barbarie che si sta consumando in Palestina da parte dello Stato d’Israele nei confronti di un popolo che vive da quarantatre anni (!?) sotto occupazione militare.
Ma non ci sono riuscito! Troppo forte il rumore, troppo deformante la lettura dei fatti reali per non dover premettere qualcosa. Di qui, la modifica sostanziale del titolo, fuorviante in parte sul contenuto del saggio, ma teso ad evidenziare la colossale menzogna che si nasconde dietro alla riproposizione di un processo da tempo defunto e che di pace non ha mai avuto nemmeno la sembianza, se non nella formulazione originaria degli accordi di Oslo di un lontanissimo 1993. Ed era all’interno degli accordi di Oslo la formulazione “Due popoli, due Stati”. Di conseguenza …
L’ultima goccia, per un vaso che è traboccato almeno da 12 anni, è rappresentata da un evento molto recente, del 10 ottobre: l’approvazione della legge sul giuramento di fedeltà da parte del governo israeliano, avvenuto mentre riprendono le costruzioni di abitazioni nelle colonie, del tutto illegittime (sia le costruzioni sia le colonie!), e mentre, alla base della trattativa ripresa con l’ANP, Netanyahu ha posto il riconoscimento, da parte dei palestinesi, dello stato d’Israele come stato ebraico!
Ecco cosa ne pensa Gideon Levy, di quest’ultima goccia. L’articolo, apparso sul numero 868 (15-21 ottobre 2010) di Internazionale dal titolo assai significativo “La Repubblica ebraica d’Israele” è tratto da Haaretz, un coraggioso giornale progressista israeliano:
“Segnatevi la data. Il 10 ottobre è il giorno in cui Israele ha cambiato natura. E magari cambierà addirittura nome e si chiamerà ‘Repubblica ebraica d’Israele’, come la Repubblica islamica dell’Iran. D’accordo: la legge sul giuramento di fedeltà che il premier Benjamin Netanyahu ha fatto approvare al governo e ora vuol far votare dal parlamento riguarda, o almeno così dice, solo i nuovi cittadini israeliani non ebrei.
Ma in realtà avrà effetti sul destino di tutti. Perché d’ora in poi vivremo in un nuovo paese etnocratico, teocratico, nazionalista e razzista. E chi pensa che la cosa non lo riguardi si sbaglia. Già, perché in Israele c’è una maggioranza silenziosa che accetta tutto questo con un’allarmante apatia. Invece chiunque creda che dopo l’approvazione di questa legge il mondo continuerà a considerare Israele come una qualsiasi democrazia non ha capito cos’è questa legge: è un nuovo grave danno all’immagine d’Israele.
Il premier Netanyahu ha dimostrato di essere come Avigdor Lieberman, il suo ministro degli esteri e leader del partito di estrema destra Yisrael Beitenu. Il parttito laburista ha dimostrato di essere solo uno zerbino. E Israele ha mostrato la sua indifferenza. La diga è crollata, minacciando di annegare ogni traccia di democrazia, fino al punto in cui forse finiremo per ritrovarci in uno stato ebraico, la cui natura nessuno capisce veramente, ma che di sicuro non sarà democratico.
Si prevede che la Knesset, nella sua sessione invernale, discuta un’altra ventina di disegni di legge anti-democratici. L’Associazione per i diritti civili in Israele ha appena pubblicato una lista nera di provvedimenti che comprende: una legge sul giuramento di fedeltà per i parlamentari, una legge sul giuramento di fedeltà per i produttori cinematografici, una legge sul giuramento di fedeltà per le associazioni senza fini di lucro. E ancora: un provvedimento che vieta ogni proposta di boicottaggio e un provvedimento sulla revoca della cittadinanza. Siamo di fronte a un pericoloso balletto maccartista, da parte di parlamentari ignoranti che non hanno capito cos’è la democrazia.
Non è difficile giudicare il duo Netanyahu-Lieberman: sono due fanatici nazionalisti, quindi nessuno può pretendere che capiscano che democrazia non significa solo potere della maggioranza, ma anche – anzi soprattutto – diritti delle minoranze. E’ molto più difficile da capire, invece, l’inerzia dei cittadini. Le piazze di tutte le città israeliane avrebbero dovuto riempirsi di persone che rifiutano di vivere in un paese dove la minoranza è oppressa da leggi severissime come quella che le obbligherebbe a prestare un falso giuramento di fedeltà ad uno stato ebraico. E invece quasi nessuno sembra pensare che la cosa lo riguardi. E’ sbalorditivo.
Ci siamo dedicati per decenni al futile dibattito su cosa significhi essere ebrei. Un interrogativo che a quanto pare ci impegnerà ancora per molto tempo. Cos’è infatti lo “stato della nazione ebraica”? Appartiene forse agli ebrei della diaspora più che ai cittadini arabi d’Israele? E i cittadini arabi potranno decidere delle sue sorti, così che la nostra si possa chiamare ancora democrazia? Cosa caratterizza l’ebraicità? Le festività? Le prescrizioni alimentari della kasherut? L’aumento del peso politico dell’establishment religioso, come se non fosse già sufficiente a distorcere la democrazia?
L’introduzione di un giuramento di fedeltà allo stato ebraico ne deciderà il destino. E rischia di trasformare Israele in una teocrazia simile all’Arabia Saudita. E’ vero: per il momento giurare fedeltà allo stato ebraico è solo uno slogan ridicolo, e non esistono tre ebrei che riescano a mettersi d’accordo su come dovrebbe essere uno stato ebraico. Ma la storia ci ha insegnato che la strada per l’inferno può essere lastricata anche di slogan inutili. Nel frattempo, la nuova legge non farà altro che aggravare il senso di estraneità degli arabi israeliani e finirà per alienare le simpatie nei confronti d’Israele di settori ancora più vasti dell’opinione pubblica mondiale.Ecco cosa succede quando non si ha piena fiducia nella strada intrapresa. Solo questa sfiducia può indurre a presentare proposte di legge perverse come quella approvata il 10 ottobre.
Il Canada non sente il bisogno di che i suoi cittadini giurino fedeltà allo stato canadese, né lo richiedono altri paesi. Solo Israele. Questa decisione è stata pensata per provocare di nuovo la minoranza araba e spingerla a dimostrare ancora più distacco dal paese, così che un bel giorno venga finalmente il momento di disfarsene. Oppure per affossare la prospettiva di un accordo di pace con i palestinesi. Comunque sia, lo stato ebraico – come diceva Theodor Herzl – fu fondato nel primo congresso sionista, che si svolse a Basilea nel 1897. Il 10 ottobre invece è stata fondata l’oscurantista Repubblica ebraica d’Israele”.
Un articolo dignitosissimo che, se sottoscritto al 50% dalla classe politica italiana (di destra e di sinistra, centrista o radicale) mi riempirebbe veramente di gioia, ma temo che dovrò continuare a soffrire! Alla sordità della nostra classe politica si è contrapposto in questo frangente, un documento del Sinodo del Medio Oriente del 18 ottobre 2010.
Gli scopi del Sinodo dei vescovi per il Medio Oriente sono stati ribaditi dal relatore generale dell’assemblea, Antonios Naguib, patriarca di Alessandria dei Copti, che ha tenuto la ‘Relatio post disceptationem’ nella quale ha riassunto quanto emerso negli interventi dei padri sinodali la scorsa settimana. “Confermare e rafforzare i cristiani nella loro identità e rinnovare la comunione ecclesiale per offrire ai cristiani le ragioni della loro presenza, per confermarli nella loro missione di rimanere testimoni di Cristo”.
Naguib ha passato in rassegna la situazione dei cristiani in Medio Oriente evidenziando la necessità dell’essere missionari, e parlando di “laicità positiva”, ha ribadito che la “religione non deve essere politicizzata né lo Stato prevalere sulla religione. E’ richiesta una presenza di qualità perché possa avere un impatto efficace sulla società. Ciò che conta non è il numero di persone nella Chiesa ma che queste vivano la fede e servano onestamente il bene comune”.
“Per assicurare la sua credibilità evangelica – ha rimarcato il Relatore – la Chiesa deve trovare i modi per garantire la trasparenza nella gestione del denaro”.
Ripercorrendo le principali sfide che i cristiani devono affrontare, tra le quali i conflitti politici nella regione, il patriarca Naguib “pur condannando la violenza da dovunque provenga ed invocando una soluzione giusta e durevole del conflitto israelo-palestinese”, ha espresso la solidarietà del Sinodo al popolo palestinese, “la cui situazione attuale favorisce il fondamentalismo. Chiediamo alla politica mondiale di tener sufficientemente conto della drammatica situazione dei cristiani in Iraq. I cristiani devono favorire la democrazia, la giustizia, la pace e la laicità positiva. Le Chiese in Occidente sono pregate di non schierarsi per gli uni dimenticando il punto di vista degli altri”.
Nella Relatio il Sinodo condanna anche “l’avanzata dell’Islam politico che colpisce i cristiani nel mondo arabo” poiché “vuole imporre un modello di vita islamico a volte con la violenza e ciò costituisce una minaccia per tutti” e la limitazione dell’applicazione di diritti quali la libertà religiosa e di coscienza che comporta anche, ha ricordato il patriarca, “il diritto all’annuncio della propria fede”. Conseguenza delle crisi politiche, del fondamentalismo, della restrizione delle libertà è l’emigrazione, che pur essendo “un diritto naturale”, interpella la Chiesa che “ha il dovere di incoraggiare i suoi fedeli a rimanere evitando “qualsiasi discorso disfattista”. […] “Le nostre chiese rifiutano l’antisemitismo e l’antiebraismo”: riafferma il Sinodo dei vescovi per il Medio Oriente.
“Le difficoltà dei rapporti fra i popoli arabi ed il popolo ebreo sono dovute piuttosto alla situazione politica conflittuale. Noi distinguiamo tra realtà politica e religiosa. I cristiani hanno la missione di essere artefici di riconciliazione e di pace, basate sulla giustizia per entrambe le parti” ribadisce il testo che, parlando di dialogo interreligioso, ricorda le iniziative pastorali di dialogo con l’ebraismo, come ad esempio “la preghiera in comune a partire dai Salmi, la lettura e meditazione dei testi biblici”.
Per il Sinodo il dialogo interreligioso e interculturale tra cristiani e musulmani “è una necessità vitale, da cui dipende in gran parte il nostro futuro”. E riprende le parole di Benedetto XVI a Colonia (2005) per riaffermare l’importanza del dialogo islamo-cristiano.
“Le ragioni per intessere rapporti con i musulmani sono molteplici, sono tutti connazionali, condividono stessa cultura e lingua, le stesse gioie e sofferenze. Fin dalla sua nascita l’Islam ha trovato radici comuni con Cristianesimo ed Ebraismo. Il contatto con i musulmani può rendere i cristiani più attaccati alla loro fede”. Per il Sinodo vanno, tuttavia, “affrontati e chiariti i pregiudizi ereditati dalla storia dei conflitti. Nel dialogo sono importanti l’incontro, la comprensione reciproca. Prima di scontrarci su cosa ci separa, incontriamoci su ciò che ci unisce, specie per quanto riguarda la dignità umana e la costruzione di un mondo migliore”.
“Serve – si legge nella Relatio – una nuova fase di apertura, sincerità e onestà. Dobbiamo affrontare serenamente e oggettivamente i temi riguardanti l’identità dell’uomo, la giustizia, i valori della vita sociale dignitosa e la reciprocità. La libertà religiosa è alla base dei rapporti sani tra musulmani e cristiani. Dovrebbe essere un tema prioritario nel dialogo interreligioso”.
- La colonizzazione dei territori occupati
Dopo questa corposa premessa, entrerò nel merito dell’argomento che intendo trattare in questo che temo ormai non possa costituire un piccolo saggio. Partirò con il fornire l’elenco dei testi su cui ho basato questo lavoro. Sostanzialmente quattro, senza ovviamente citare quanto personalmente ho scritto in precedenza sull’argomento. Un volume dal titolo “Palestine, la depossession d’un territoire”, realizzato da Pierre Blanc, Jean-Paul Chagnollaud e Sid Ahmed Souiah, per la casa editrice L’Harmattan, del 2007, “Jerusalem le rapport occulté”, con sottotitolo Rapports 2005 et 2008 des diplomates de l’Union Européenne en poste a Jerusalem, con la presentazione di René Backmann, delle edizioni Salvator del 2009, “Gaza, le livre noir” che raccoglie rapporti e documenti di diverse associazioni, a cura di Reporters sans frontières, del 2009, il numero di Limes “Il buio oltre Gaza” del gennaio 2009 e il quaderno speciale di Limes del luglio 2010.
Il primo di questi testi mi è servito per sviluppare il paragrafo numero 3, il secondo per sviluppare i paragrafi 4 e 5 e gli altri due costituiscono un riferimento importante rispetto agli eventi riguardanti Gaza e il terrorismo di Stato israeliano, che avrei voluto trattare ma che ho deciso di non scrivere per le ragioni indicate all’inizio delle conclusioni.
In questo paragrafo ripercorrerò, sia pure sinteticamente, la colonizzazione dei territori occupati che ho trattato diffusamente sia in “Quale processo di pace?” del 1998, che ne “La nuova Intifada” del 2001. Sostanzialmente, cercherò di rendere ragione del perché, in un territorio totalmente abitato da palestinesi, quali la Cisgiordania e la striscia di Gaza, prima della guerra del 1967, fatta eccezione per Gerusalemme Ovest, si sia ormai giunti ad una presenza israeliana tra le 500.000 e le 550.000 persone, Gerusalemme Ovest inclusa.
Intendo inoltre mettere in evidenza un’esasperazione di lunga durata per il popolo palestinese, dovuta ad un articolato quanto iniquo sistema “legale” di sottrazione del territorio da parte dello Stato d’Israele, a danno dei palestinesi. Dopo aver analizzato le forme “legali” dell’espropriazione della terra, già in uso del resto dal 1948, procederò a quantificarla, a partire dal 1967. E, per quanto riguarda in particolare la colonizzazione di Gerusalemme-Est, sarà il testo di Chagnollaud a precisarla nei minimi particolari.
Occorre in ogni caso non dimenticare mai che si è trattato (e si tratta) di un processo di colonizzazione in piena regola, con un suo armamentario specifico di confische di terre, di distruzioni di case e di abbattimento di alberi, con la requisizione della terra, per motivi di sicurezza, come chiave di volta. Il mio timore è che oggi questo processo possa sfociare in una seconda e più feroce pulizia etnica. Si, è proprio ad una seconda Nakba che penso, quando vedo l’opera dell’esercito israeliano, sempre più vicino alla logica dell’espulsione dei palestinesi dalla loro terra, la costruzione del Muro e quel carcere a cielo aperto, rappresentato dall’intera striscia di Gaza! Ho trattato con dovizia di particolari ne “La colonizzazione sionista della Palestina” i vari aspetti dello spossessamento dei palestinesi da parte dei sionisti prima e dello Stato d’Israele poi, ma ritengo importante riassumerne gli aspetti essenziali.
Le forme “legali” per l’appropriazione delle terre.
Dopo il 1967, è passata sotto il controllo israeliano, fra terre demaniali confiscate, recintate e soggette ad acquisto forzato, e terreni di privati, “neutralizzati” e resi indisponibili per lo sviluppo urbanistico palestinese, più del 55% della Cisgiordania. Ciò è avvenuto attraverso tre procedure fondamentali: l’assenza, l’acquisto di terre e l’esproprio. Ma prima di tutto, voglio analizzare l’elemento dominante nella requisizione delle terre:
La sicurezza
Si tratta del noto vessillo agitato, da sempre, dallo Stato d’Israele (e anche da altri, sia chiaro!), divenuto in Italia la bandiera dell’improntitudine. Le autorità israeliane hanno sempre sostenuto che le requisizioni di terre per la costruzione di colonie, (o per qualsiasi altro motivo), sono effettuate nel pieno rispetto della legalità. Cosa che si spiega facilmente, pensando al ruolo che la nozione di stato di diritto occupa sia nell’ideologia dominante sia nella realtà del sistema politico di questo paese. E poi, portare un dibattito di questo tipo sul terreno giuridico permette di superare più facilmente i problemi difficili ed imbarazzanti circa la vera natura di queste appropriazioni coprendole della neutralità apparente e della rispettabilità formale della norma giuridica.
Conviene perciò cercare di capire meglio cosa nasconde la nozione di legalità. Partendo, come criterio di differenziazione, da come vengono prodotte le norme, occorre distinguere la legalità internazionale e quella interna. Per definizione, la legalità internazionale esiste al di fuori di ogni Stato preso separatamente. Come qualsiasi altro attore del sistema internazionale, lo Stato d’Israele si trova in presenza di un complesso di regole giuridiche, che esiste indipendentemente da lui. Certamente, in qualche modo, può rifiutare di sottoscriverlo ma non avrà mai il controllo assoluto della sua elaborazione, ma gli resta, in ogni caso, il potere di interpretazione. Vediamo quali sono le tesi israeliane sulla Cisgiordania e Gaza, come sulla questione più specifica delle colonie.
In sostanza Israele, avanzando dei diritti legittimi sui territori occupati, sostiene di non occuparli (nel senso del diritto internazionale) ma soltanto di amministrarli in attesa di uno statuto definitivo da assegnare loro, al termine di un processo di negoziati. Le colonie poi, sempre secondo il governo israeliano, non contravvengono alla legalità internazionale, nonostante la posizione adottata all’unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione del 1° marzo 1980, secondo la quale esse costituiscono “una flagrante violazione della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949…”.
Altra cosa invece è la legalità interna che il governo può non solo interpretare, ma anche, e questa è la differenza fondamentale, creare come vuole, in funzione degli obiettivi politici che intende perseguire, a condizione tuttavia di tenere conto della giurisprudenza di una giurisdizione del tutto indipendente: la Corte Suprema d’Israele. La requisizione di terre nei territori occupati, ma non annessi, è avvenuta essenzialmente per motivi di sicurezza. La base giuridica di queste operazioni si trova nelle ordinanze promulgate dai britannici all’epoca del Mandato, e che sono rimaste in vigore dopo la creazione dello Stato d’Israele. In particolare l’articolo 125 delle Defence Emergency Regulations del 1945 che permette al Comandante regionale di vietare l’accesso in qualsiasi zona che si trovi sotto il suo controllo, per motivi di sicurezza.
Da allora, più nessuno può penetrarvi, senza aver ottenuto preliminarmente un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente. Queste pratiche non sembrerebbero in ogni caso contrarie al diritto internazionale, dal momento che, in questo ambito, le regole del diritto hanno soprattutto per obiettivo di proteggere l’interesse dello Stato occupato e quello dei singoli. Per questo vietano qualsiasi forma di sostituzione di proprietà e non ammettono che un uso provvisorio di esse. E dunque l’occupante non può essere che l’amministratore e l’usufruttuario dei beni dello Stato occupato. La confisca dei beni dei privati è rigorosamente proibita dall’articolo 46 del Regolamento dell’Aja (1907) che recita:
“L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata così come le convinzioni religiose devono essere rispettate”. Sono lecite soltanto le requisizioni poiché, entro certi limiti, rappresentano delle “prestazioni forzate in natura o servizi forzati, richiesti unicamente per i bisogni dell’esercito d’occupazione“.
Questo è un processo cominciato fin dai primi anni dell’occupazione; prima in forma occulta, trasformando l’installazione militare insensibilmente in insediamento civile. Poi, soprattutto dopo la guerra del 1973, in modo sempre più esplicito. Da quel momento in poi la colonizzazione è apparsa in tutta la sua forza e la sua ampiezza. Facciamo un passo indietro: sia la Gran Bretagna che la Giordania avevano avviato il censimento sistematico di tutti i titoli di proprietà. Ma questa operazione, indispensabile oltre che complessa, si basava sull’effettività del possesso e dell’uso, che ciascuno poteva provare in diversi modi. Proprio per questo, un tale processo, estremamente lento, era ben lungi dall’essere stato completato nel 1967, e dunque la più gran parte delle terre non era ancora stata censita. Uno dei primi provvedimenti delle autorità israeliane d’occupazione fu quello di bloccare brutalmente queste attività di censimento anche nei settori dove era praticamente terminato. Una decisione di una portata politica importantissima. A questo proposito Dany Rubistein, noto giornalista israeliano, su Davar del 20 marzo 1981, scrisse: “minore è il numero di beni immobili registrati al catasto e di terreni la cui proprietà è chiaramente definita, più numerose sono le aree suscettibili d’essere proclamate beni dello Stato“.
L’assenza
Alla conquista del 1967, seguì subito dopo l’insediamento di un governatore militare nei territori occupati. Il Comandante regionale (nome ufficiale del governatore), pubblicò, il 23 luglio 1967, l’ordinanza n° 58, riguardante lo statuto della proprietà degli assenti. Per questa ordinanza, l’assente rispondeva ad una definizione molto estensiva. Si trattava in sostanza di chi, allo scoppio della guerra, nel giugno 1967, aveva lasciato la Cisgiordania. Così era già avvenuto nel 1950, quando la Knesset, il parlamento israeliano, adottò un provvedimento della stessa natura per tutte le proprietà abbandonate nel 1948 dai palestinesi. Il governatore sosteneva che l’obiettivo dell’ordinanza fosse quello di proteggere i beni di coloro che erano stati costretti a fuggire allo scoppio della guerra.
Vediamo come funziona quest’ordinanza. Il Comandante regionale nomina un “Guardiano della proprietà abbandonata”, cui compete il ruolo di prendere in carico l’insieme di questi beni. All’inizio la semplice assenza del proprietario non basta per trasferire il controllo dei beni al Guardiano. È necessario anche che non ci sia nessun parente prossimo, un membro della famiglia ad esempio, in grado di assicurarne la gestione secondo il diritto vigente. Non si tratta dunque di un vero e proprio trasferimento di proprietà: il Guardiano agisce in qualità di depositario della proprietà dell’assente fino al suo ritorno e deve anche conservare per il proprietario, tutti i redditi eventuali che può aver realizzato, diminuiti delle spese di gestione. Se il proprietario ritorna, il Guardiano gli deve restituire l’esercizio di tutti i suoi diritti. Ma tra il dire e il fare…
Esistono due questioni di fondo, che portano ad una realtà sensibilmente diversa da quella del discorso giuridico ufficiale. Infatti il Guardiano dispone in pratica di un potere discrezionale per quanto riguarda l’uso dei beni abbandonati. Nessuna transazione è valida senza la sua autorizzazione e nessun articolo limita le sue possibilità d’azione. In tali condizioni, il ruolo effettivo del Guardiano è anche quello di contribuire con efficacia agli insediamenti israeliani soprattutto nella valle del Giordano dove si trovano numerosi beni abbandonati, dal momento che questo settore è stato il più coinvolto dall’esodo della popolazione nel 1967. Ed eccoci così ad uno dei problemi chiave del conflitto israelo-palestinese e cioè quello del Ritorno. E qui il cerchio si chiude. Il contadino palestinese che ha attraversato il Giordano nel 1967, si è “sistemato” provvisoriamente a qualche decina di chilometri dalle sue terre, ormai occupate da una colonia israeliana. È perciò considerato assente sul piano giuridico poiché gli è vietato l’attraversamento del Giordano in senso inverso. Vi sembra un problema giuridico? Ma nemmeno per sogno! Questo è il risultato di un rapporto di forze. Il responsabile delle colonie israeliane della valle del Giordano si esprime a questo proposito in modo molto chiaro:
“Qui, nella valle, noi lavoriamo su migliaia di dunum che appartengono – perché non dirlo? – a degli arabi. Arabi, per la maggior parte assenti, abitanti di Nablus o di Tubas… che sono fuggiti durante la guerra del 1967. Queste persone non possono tornare in Giudea-Samaria perché i loro nomi figurano su di una lista ai posti di frontiera sui ponti [sul Giordano]”. E così, questa legislazione ha generato situazioni kafkiane. Il caso classico? Un proprietario che, rientrato sulle sue terre senza autorizzazione, finisce davanti ad un tribunale, accusato d’effrazione di proprietà di un assente!
Gli acquisti di terre
Per affrontare quest’altra questione, è necessario distinguere fra le istituzioni ufficiali autorizzate ad effettuare transazioni fondiarie e i privati che all’inizio, fino al 1979, non ne avevano diritto. A partire dal 1967, l’amministrazione del demanio (Israel Land Administration, I.L.A.) e il Fondo Nazionale Ebraico (K.K.L.), hanno concepito ed attuato una politica sistematica di acquisti di terre nei territori occupati. Queste due istituzioni hanno potuto così acquistare importanti superfici, soprattutto nella regione di Gerusalemme. Le decisioni sugli acquisti vengono prese dai due direttori delle istituzioni appena citate, che definiscono le loro scelte in funzione di dati forniti da una rete d’informazioni molto estesa, riguardante diversi paesi stranieri, dove si trova la parte più consistente dei venditori potenziali. L’operazione viene condotta in porto tramite la società Hemnutah, la cui creazione risale all’epoca del Mandato britannico (1938) quando il suo compito era quello di favorire il trasferimento dei capitali degli ebrei tedeschi. Le transazioni vengono fatte nel più gran segreto non solo per evidenti ragioni politiche ma anche perché sono molto forti le minacce di rappresaglie nei confronti dei proprietari palestinesi. Fino al 1979, gli acquisti di terre da parte di privati erano vietati nonostante le molteplici pressioni esercitate sui vari governi.
L’esproprio
Non parliamo qui di un generico spossessamento ma di quello effettuato per motivi di interesse generale. È in questa prospettiva limitata che le autorità israeliane intendono collocarsi, quando sottolineano l’indispensabile rispetto dei principi fissati dal diritto internazionale. E così l’esproprio è lecito per la realizzazione di obiettivi di interesse pubblico nelle forme previste dal diritto locale e con la condizione del pagamento di un’indennità al proprietario. La legislazione giordana, relativa alla procedura d’esproprio, era stata concepita in modo da non limitare in alcun modo la sua attuazione. La nozione d’interesse pubblico viene definita dalla constatazione della volontà del potere politico. Un interesse pubblico è, a termini di legge, “qualsiasi interesse che il governo, con il consenso del Re, ha deciso di considerare come pubblico“. Le autorità israeliane ironizzano su questa formulazione per poi precisare che, nonostante l’ampiezza discrezionale, le autorità militari utilizzano la procedura d’esproprio in maniera molto restrittiva. (Quando si dice la democrazia!). E mettono in evidenza come tale procedura non sia mai stata impiegata per insediamenti civili nei territori occupati. Si è fatto ricorso ad essa, soltanto per servire l’interesse generale in senso stretto. Per la costruzione e l’ampliamento di strade o la costruzione di edifici pubblici, ad esempio!
Si ritrova perciò un dato evidente: in ogni situazione d’occupazione il diritto è sempre al servizio di una politica. Se la nozione stessa di Stato di diritto è centrale in Israele, essa non ha quasi più senso aldilà della linea verde. L’elemento dominante della colonizzazione sionista dopo la guerra del 1967 è caratterizzato proprio dal fatto di verificarsi in una società sotto occupazione e dunque completamente sottomessa all’arbitrio dello Stato d’Israele. In queste condizioni, l’occupazione non riguarda soltanto questo o quell’aspetto della vita quotidiana, ma è invece al centro di tutto, in tutti i settori d’attività. Costituisce un sistema globale coerente, che non lascia sfuggire nessun dettaglio al suo controllo, neppure il colore delle targhe delle automobili.
Dopo il 1967, strettamente connesso con il processo di colonizzazione continuò il processo di espropriazione della terra. In questo ambito è praticamente impossibile disporre di cifre precise. Bisogna distinguere fra terre coltivate e terre riservate alle colture o agli insediamenti futuri. Una fonte israeliana parla, per tutti i territori, di 118 chilometri quadrati (11.800 ettari, pari a 118.000 dunum) di terre ebraiche coltivate. La superficie delle terre confiscate, in vista di utilizzo futuro da parte dei coloni, sarebbe salita a 3.000 chilometri quadrati, di cui 1.200 sul Golan, e 1.800 in Cisgiordania, ovvero il 31,5% del suolo. Anche se fino al 1977 queste terre “redente” si trovavano soprattutto ad oriente, e si trattava di zone aride e spopolate, la violenza inflitta alla popolazione araba non era per questo meno severa: ad esempio, il livello dell’acqua si abbassò pericolosamente in alcuni villaggi arabi della valle del Giordano a causa della creazione di pozzi artesiani negli insediamenti israeliani vicini!
Evidenti gli effetti nefasti della colonizzazione israeliana sulla popolazione palestinese, i cui mezzi di sussistenza tradizionali erano progressivamente minacciati e che veniva sottoposta ad un processo di proletarizzazione. La perdita di terre coltivate spingeva infatti i contadini palestinesi ad abbandonare l’agricoltura e così molti di loro andavano a lavorare come manodopera non qualificata nell’economia israeliana. L’acquisto di terre assunse proporzioni ancora più allarmanti dopo il 1977, e riguardò molto di più campi e piantagioni palestinesi, esasperando la tendenza ad una compartimentazione dei centri di popolazione locale.
Se è vero che la colonizzazione non aveva raggiunto, nel 1977, proporzioni irreversibili, è altrettanto vero che nella pratica non c’è stato nessun aspetto della politica colonizzatrice successiva di Begin che non avesse avuto un precedente nel periodo laburista, in particolare nella sua ultima fase. Dopo il 1967, a tutto il 1985, passano sotto diretto controllo israeliano, fra terreni demaniali, confiscati, recintati, e soggetti ad acquisto forzato, un totale di 2.268.500 dunum, pari al 41% dell’intera Cisgiordania. Poiché le autorità israeliane “neutralizzano” altri 570.000 dunum, dichiarandoli indisponibili per lo sviluppo urbanistico palestinese, complessivamente l’area soggetta a requisizioni o restrizioni ammonta a 2.838.000 dunum pari al 52% della Cisgiordania. Nella striscia di Gaza, con la stessa logica, nascono 16 insediamenti ebraici. Nei primi dieci anni di occupazione nascono 24 insediamenti. Dopo ne sono sorti altri 118, distribuiti in modo da impedire qualsiasi futuro ritiro di Israele dalla Cisgiordania, se non dalla striscia di Gaza.
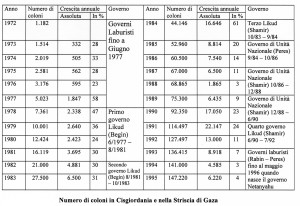
Insieme con gli insediamenti, è cresciuto il numero dei coloni. Dalla tabella si vede come questi siano passati da 1.182 nel 1972 a 27.500 nel 1983. Se si confrontano i dati del periodo 1967-77 con quelli relativi al periodo successivo (1977-1983), quando il Likud è al governo, appare evidente una rapida crescita del numero dei coloni che passano dai 5023 del 1977 ai 27.500 di cui si parlava prima. Il partito della “Grande Israele”, che punta ad una Palestina tutta ebraica si fa più forte e prepotente. Con l’avvento della destra al governo, sono nate in Israele due tesi. La prima punta ad utilizzare i territori come “materiale” di scambio, per la pace. La seconda, oltranzista, basandosi sulla potenza militare d’Israele e sull’incondizionato appoggio degli Stati Uniti (anche nel Medio Oriente la “guerra fredda” funziona!), intende appropriarsi di tutta la Palestina del Mandato, e oltre.
“La colonizzazione della terra d’Israele è un diritto e un aspetto determinante della sicurezza del paese che sarà difeso ed esteso”.
È ancora e sempre questo, uno degli obiettivi principali del programma di governo presentato l’8 giugno 1990. Il che significa che l’insediamento di colonie di popolamento, strumento essenziale della politica di colonizzazione, continuerà a svilupparsi, a danno dei palestinesi, con lo spossessamento continuo della loro terra. Il governo di Unità nazionale cade il 15 marzo 1990. Tre mesi dopo nasce un nuovo governo, diretto sempre da Shamir, con la partecipazione di tre formazioni di estrema destra. Si tratta del governo più a destra, più estremistico e più legato agli ambienti religiosi della storia d’Israele. Ariel Sharon, ministro degli Alloggi, dirige questa nuova tappa della colonizzazione. Fino a quel momento s’intende! Ma poiché il peggio non è mai morto, dopo la parentesi laburista, nel maggio 1996, nasce il governo Netanyahu. E poi il governo Barak e poi il governo Sharon e poi il governo Olmert …
Ufficialmente, non viene creato nessun nuovo insediamento, per tenere buoni gli Stati Uniti, ma i fatti sono diversi. Nascono nuove colonie ma questi insediamenti vengono mascherati da artifici amministrativi come dimostra il rapporto del Dipartimento di Stato: “[…] costruendo su quei siti che, da un punto di vista amministrativo, dipendono da un insediamento già esistente, anche se si trovano in realtà a distanza di chilometri. E così si vedono nascere cantieri in massa su località abbandonate da tempo, che ampliano i limiti di colonie già esistenti […]. E così si capisce perché la presenza israeliana nei Territori occupati continua a crescere a un ritmo altissimo. In meno di due anni, Ariel, il secondo insediamento della Cisgiordania per dimensioni, mette in cantiere 1.400 appartamenti; il più grande, Ma’ale Adumim, vicino Gerusalemme, ne costruisce attualmente un migliaio” (“Report on Israeli Settlement Activity in the Occupied Territories”, consegnato al Congresso americano il 20 marzo 1991).
Nel 1991, circa 200.000 coloni risiedevano in circa 200 colonie (197.000 abitanti in circa 150 colonie in Cisgiordania, e di questi 120.000 insediati nella città di Gerusalemme-Est annessa nel 1967, e 3.000 nelle 15 colonie a Gaza). Secondo uno studio del Dipartimento di Stato americano del 20 marzo 1991, essi rappresentavano il 13% della popolazione totale dei territori occupati, mentre il 50% delle terre della Cisgiordania erano state confiscate per la colonizzazione. A Gaza, un terzo del territorio abitabile era riservato ai coloni. Il movimento cresce dopo il 1990, con 10.000 nuovi arrivati in un anno. La natura degli insediamenti è ancora più significativa, se si pensa che non si tratta più della creazione di piccole unità che raggruppano alcune centinaia di persone ma di veri e propri centri urbani, il più vicino possibile ai grandi agglomerati israeliani. Non si tratta più di modeste colonie a vocazione rurale. L’ambizione è quella di costruire delle cittadine.
E’ importante ricordare la classificazione ufficiale delle zone d’insediamento. Queste si dividono in tre settori, a seconda dell’importanza della domanda di abitazioni: forte, media o debole. La zona di forte domanda comprende tutti i luoghi situati al massimo a mezz’ora da Tel Aviv e a venti minuti da Gerusalemme. Quella di domanda media comprende, a parte la precedente, tutte le località situate al massimo a cinquanta minuti da Tel Aviv e a trentacinque da Gerusalemme. La terza infine comprende il resto della Cisgiordania. In funzione di questa divisione, i grandi progetti si trovano concentrati nella zona di forte domanda. E così al centro di questo settore viene costruito Ariel, il più vasto insieme urbano, concepito per accogliere più di 100.000 abitanti. L’obiettivo politico implicito è quello di fare di questa zona una specie di cerniera che fissi strettamente la Cisgiordania a Israele. Sono questi gli aspetti più importanti per cercare di capire il “senso” del processo di pace.
Riepilogando, nel periodo (1967-1977) i laburisti hanno dato la priorità assoluta a Gerusalemme. Si sono annessa non soltanto la parte araba della città, ma anche importanti superfici di terre prese dai villaggi dei dintorni per creare un vasto agglomerato urbano. All’interno di questi nuovi limiti, sono stati costruiti grandi insiemi di immobili riservati alla popolazione ebraica a Nord, a Est e a Sud (Ramot, Talpiot, Gilo…).In alcuni anni i rapporti demografici sono stati rivoluzionati con tutte le conseguenze sociologiche e politiche che si possono immaginare (nel 1976 le statistiche ufficiali parlano di una popolazione di 264.000 ebrei e di 92.000 arabi). Oltre a Gerusalemme, i governi laburisti hanno avuto tre priorità: la valle del Giordano, il Golan e il Sinai; queste tre regioni hanno una caratteristica comune: sono poco popolate; il Sinai perché è un deserto, le altre due perché la maggior parte degli abitanti che vi risiedevano sono fuggiti durante la guerra del 1967. Gli insediamenti realizzati nelle zone a forte densità di popolazione palestinese furono poco numerosi, il più significativo di questi fu quello di Kiriat Arba alle porte di Hebron.
A partire dal 1975, sotto il governo Rabin, il processo si è accelerato ed esteso. Oltre alle sue iniziative, il Primo Ministro lascia fare al Gush Emunim la cui politica consiste nel creare insediamenti dappertutto, in particolare al centro della Cisgiordania. Come a Sebastia (vicino Nablus), dove il Gush Emunim riesce a spuntarla nell’installazione importante che intendeva realizzare. Nel periodo (1977-1984), con il governo del Likud vengono realizzati numerosi insediamenti. Il suo governo sviluppa quelli esistenti e soprattutto ne crea di nuovi. A questo proposito la formulazione del suo programma è molto semplice: “il territorio di Cisgiordania e di Gaza appartiene al popolo ebraico, è quindi legittimo creare degli insediamenti che dovranno permettere l’installazione di centinaia di migliaia di Ebrei”. Tuttavia, a causa dei negoziati avviati a Camp David, questa politica non troverà immediata applicazione sul terreno, si dovrà attendere il 1980 e soprattutto il 1981, data in cui Begin vince per la seconda volta le elezioni legislative, perché il processo di colonizzazione conosca una spettacolare accelerazione.
Con il Likud ormai la priorità delle priorità è la Cisgiordania (la Giudea e la Samaria); mentre i laburisti, in dieci anni, avevano creato una decina di siti, il governo del Likud ne costruisce più di una cinquantina in cinque anni. Se alla fine del 1976, c’erano circa 5.000 abitanti ebrei in Cisgiordania (senza contare Gerusalemme), nel 1983 sono vicini a 30.000. Tutti i dati statistici evidenziano l’importanza di questo salto qualitativo: un numero molto più grande di colonie e di abitanti, proprio nel cuore della Cisgiordania, rispetto all’epoca dei laburisti.
Nel periodo (1984-1988) i laburisti e il Likud si ritrovano in una situazione d’equilibrio elettorale tale da doversi rassegnare a formare un governo di unità nazionale, dopo aver tentato invano, per diverse settimane, di mettere in piedi delle coalizioni omogenee. Per giungere a questa formula, si sono fatte concessioni da una parte e dall’altra soprattutto a proposito degli insediamenti. Su questo punto, l’accordo di governo ha cercato di gestire le posizioni delle due parti in modo che ciascuna possa dare l’impressione di non aver ceduto nulla di essenziale. In applicazione di questo accordo è stata annunciata la creazione di sei nuove colonie; verranno installate in Giudea-Samaria al limite dei settori inclusi nel piano Allon, cosa che permette al Likud di affermare che il governo continuerà a creare insediamenti “dappertutto” e al partito laburista di mostrare di restare fedele alla sua posizione basata sulla ricerca di un compromesso territoriale. Nella pratica il ritmo della colonizzazione si è un po’ rallentato perché il governo non attribuiva a questo problema il ruolo prioritario che aveva in precedenza ma anche perché il numero delle persone che desideravano installarsi al di là della linea verde diminuivano sensibilmente.
Nel luglio del 1988, in una intervista alla rivista Nekuda, una delle figure di punta del movimento di colonizzazione, il rabbino Levinger, faceva un bilancio in questi termini: “Dopo le elezioni del 1984, siamo stati tra coloro che chiedevano un governo di unità nazionale. Noi lo abbiamo fatto perché l’unità della nazione è un principio non meno importante del processo d’insediamenti; per preservare questa unità abbiamo accettato di sacrificare l’insediamento di nuove colonie… Anche se la nostra influenza su un (tale) governo era inferiore rispetto a quella su di un governo diretto dal Likud”.
Che questa politica non avesse avuto più, dopo il 1984, l’intensità che l’animava all’inizio, non significa però che si sia veramente indebolita. Il risultato? Dal 1983 al 1986 il numero delle colonie è cresciuto del 118%, quello degli abitanti del 45 % e l’investimento pubblico del 56 %. Alla vigilia dello scoppio dell’Intifada, il processo di colonizzazione è un fatto politico che secondo molti osservatori ha tutte le possibilità di svilupparsi ancora, anche se si svolge ad un ritmo meno sostenuto che in precedenza. Nel suo rapporto del 1987, Meron Benvenisti valuta che ci sono 65.000 ebrei in Cisgiordania (esclusa Gerusalemme) e 2.700 nella striscia di Gaza e che fino alla metà degli anni 1990 il numero annuale di nuovi arrivati sarà dell’ordine di 10.000; tutta questa popolazione sarà concentrata negli insediamenti urbani situati attorno alle metropoli di Tel Aviv e Gerusalemme, a danno degli insediamenti rurali. Se non si sono raggiunti gli obiettivi ambiziosi sognati dagli ispiratori di questo processo, né gli scopi del piano progettato dal Likud, a medio termine, l’installazione di 100.000 coloni sembra già di un’importanza considerevole.
Per rendersene conto non basta del resto far riferimento soltanto alle statistiche sulle persone insediate; occorre prendere in considerazione altre due dimensioni essenziali. La prima attiene all’ampiezza delle superfici delle terre confiscate o requisite per questi insediamenti e più in generale per tutta una serie di motivi a cominciare da quelli invocati dalla sicurezza militare: più della metà della Cisgiordania si trova così oggi sotto il controllo assoluto d’Israele. È in questo senso che è giusto parlare di una vera appropriazione dello spazio con le molteplici conseguenze che ne derivano. Ciò significa soprattutto che queste terre sono state prese a degli uomini che ci vivevano e che in molti casi le coltivavano. Essi sono stati espulsi dal loro universo familiare, allontanati dai loro utensili di lavoro, dalla loro terra d’origine cui sono ormai costretti a girare intorno come se fossero degli stranieri. Non c’è da meravigliarsi, in queste condizioni, se la battaglia per la terra sia divenuta l’ossessione di molti; la posta in gioco si rivela fondamentale perché rinvia all’essenza stessa del conflitto che oppone i Palestinesi agli Israeliani.
La seconda dimensione riguarda le profonde trasformazioni che questi insediamenti inducono nella vita quotidiana. Per un palestinese dei territori è impossibile circolare senza passare vicino ad una colonia o senza sentirne la pesante presenza. In alcuni settori, come a Hebron per esempio, la tensione che ne consegue è difficilmente sopportabile e talvolta, in questa o in quella occasione, degenera in scontri. In ogni caso il rapporto di forze non può essere analizzato soltanto in termini di numeri. Anche se è assai minoritario in rapporto alla popolazione locale, il colono vuole sempre dimostrarsi come il padrone delle zone presso le quali abita. Ciò si materializza in particolare con il portare sistematicamente le armi che, soltanto a lui, esprime una realtà: l’atteggiamento arrogante di colui che esibisce il suo fucile sulla spalla basta per far capire molte cose. Non bisogna credere, tuttavia, che tutti i coloni siano degli ideologi determinati, costi quel che costi, a battersi in favore della grande Israele; questi ci sono, ovviamente, ma non rappresentano, secondo un’inchiesta effettuata nel 1983, che una minoranza valutata al 17% dell’insieme. Gli altri hanno scelto di vivere nei territori occupati in virtù dei prezzi molto competitivi degli appartamenti e della qualità della vita che si trova in regioni situate a qualche decina di minuti da Gerusalemme o da Tel Aviv.
Ciò non toglie che, al di là di queste constatazioni, la volontà politica affermata una volta da alcuni attivisti si sia ormai tradotta nei fatti, al punto tale da essere riuscito a creare una stretta rete d’influenze e d’interessi, capace di pesare sulle scelte fondamentali dello Stato. I sostenitori della Grande Israele attraverso lo sviluppo massiccio di insediamenti nei territori palestinesi occupati non erano infatti, trentanove anni fa, che dei gruppi relativamente periferici. Poi il loro progetto è stato facilitato dalle esitazioni e dalle contraddizioni del partito laburista. Così il Likud ha conosciuto uno sviluppo spettacolare che ne fa oggi una delle due grandi formazioni politiche del paese, cosa del tutto impensabile alla fine degli anni ‘60. In altri termini, il problema degli insediamenti non è più appannaggio di gruppi della società civile con scarsi addentellati politici; ormai, da trent’anni, esiste un’efficace articolazione fra questi gruppi di pressione e potenti formazioni politiche.
Ci si rende conto perciò di quanto l’appropriazione dello spazio costituisca, ad un tempo, fattore decisivo di esasperazione della popolazione palestinese e ostacolo importante a qualsiasi ricerca di una soluzione politica negoziata. Ecco perché, lo ripetiamo ancora una volta, questa occupazione non è un’occupazione come le altre.
Dopo gli accordi di Oslo, non solo la colonizzazione non ha subito alcun rallentamento ma addirittura c’è stata una forte accelerazione sia sotto i governi laburisti (Rabin, poi Peres ed infine Barak) sia, ovviamente, sotto i governi Netanyahu, Sharon e Olmert. Tutto è avvenuto come se “la corsa contro il tempo“, non fosse mai cessata, per accumulare fatti compiuti su fatti compiuti, e trovarsi così in posizione di vantaggio, all’apertura dei negoziati sullo statuto finale, previsti per il 4 maggio 1996 (pensate, più di quattordici anni fa!) Con il ritorno dei laburisti al governo nel 1992, sembrava che le cose stessero cambiando. Nel luglio del 1992, Rabin decise il congelamento della colonizzazione. Sembrava! Questa decisione bloccò soltanto i nuovi progetti, ma non fermò quanto era già avviato, in particolare tutta la colonizzazione intorno a Gerusalemme, e tutta la costruzione della rete stradale, decisiva nel vasto processo di appropriazione della terra. Rabin, in realtà, non ha mai cercato di bloccare la colonizzazione, ha soltanto dovuto tener conto dei vincoli imposti dagli americani al governo Shamir, secondo i quali la concessione di garanzie bancarie a prestiti privati, per l’ammontare di più di 20.000 miliardi di lire, era condizionata dal blocco della colonizzazione.
E così, il numero di coloni, dal 1992 al 1996, è passato da 100.000 a 151.000. Il ministro per le Abitazioni in carica nel governo Rabin (poi ministro della difesa nel governo Sharon) Benyamin Ben-Elieser, così commentava allora il suo lavoro: “Dal momento in cui ho il completo consenso del Primo ministro, io costruisco tranquillamente senza far rumore … Per me è importante costruire con grande slancio a Givat Ze’ev, Maale Adumim e Beitar… colonie che fanno parte di Gerusalemme. Per me ciò che conta è costruire, costruire e ancora costruire…”.
Per i dirigenti laburisti, il programma è chiaro: moltiplicare i fatti compiuti nelle zone che si vogliono conservare, mentre si negozia molto lentamente l’accordo di ripiegamento rispetto a quelle zone che si intendono evacuare comunque lentamente, per aver il massimo tempo possibile per controllare la doppia operazione. Facciamo ora un altro esercizio. Confrontiamo la carta di Oslo II con quelle dei piani Allon e Drobless. Si capisce, abbastanza presto, che si fondano su alcune logiche comuni. La carta di Oslo II evidenzia la divisione della Cisgiordania in tre zone. Non si infastidisca il lettore. È vero, per alcuni versi ci stiamo ripetendo, ma vedrà, che alla fine dell’esercizio, avrà un quadro più ampio, e non soltanto tecnico degli accordi di Oslo II.
La zona A riguarda le città palestinesi, da anni ormai circondate dalle colonie e tornate nel 2002 sotto il controllo dell’esercito israeliano. La zona B riguarda i villaggi, dove vive la massima parte dei palestinesi, e che sono assai spesso separati gli uni dagli altri da colonie o da strade di aggiramento, meglio sarebbe dire di accerchiamento. La zona C rappresenta tutto il resto del territorio, dove si trovano tutte le colonie, dalla più grande alla più piccola, oltre alle basi militari.
Quando il Likud, nel maggio del 1996, a sorpresa torna al governo, si trova in una situazione radicalmente diversa dal 1992. Dal momento che gli accordi di Oslo sono anche il portato della comunità internazionale e poi c’è stato il riconoscimento reciproco tra israeliani e palestinesi, la sua scelta pragmatica è quella di fare di tutto per piegare le cose nella direzione desiderata. La posizione di Benyamin Netanyahu viene formalizzata nel piano “Allon plus” (1997). Ironia delle parole: il piano va oltre, plus, un altro piano, fuori uso dal 1975, opera dei laburisti!
Quattro sono i punti essenziali di questo piano.
In primo luogo, l’instaurazione della sovranità israeliana su di una fascia larga 15 chilometri (dal Giordano alla cima delle montagne ad ovest).
In secondo luogo, l’estensione dei limiti territoriali di Gerusalemme con l’annessione a nord delle colonie di Givat Ze’ev, a est di Maale Adumim e a sud del blocco Etzion.
In terzo luogo, la rottura della continuità territoriale palestinese con l’attivazione di colonie ebraiche sotto la sovranità israeliana e la creazione di quattro corridoi di larghezza indeterminata (?!) che colleghino Israele alla valle del Giordano secondo l’asse est-ovest.
In quarto luogo, la rottura della continuità territoriale per la popolazione palestinese che si trova a cavallo della linea verde, secondo la logica del piano Seven Stars. La maggior parte delle 140 colonie (esclusa Gerusalemme-Est) con i suoi 160.000 coloni saranno annesse ad Israele. Di fatto, si tratta dell’annessione di circa il 60% della Cisgiordania con il controllo totale delle risorse in acqua. Quando Netanyahu lascia il governo, dopo aver fatto ricorso alle elezioni anticipate per bloccare i negoziati con i palestinesi e portare avanti, indisturbato, la colonizzazione, il bilancio “coloniale” è impressionante. Migliaia di appartamenti costruiti e migliaia di nuovi coloni insediati, in particolare nel settore della Grande Gerusalemme.
È la volta di Barak come Primo ministro. Questi, alla fine del mese di giugno del 1999, s’impegna a garantire la sicurezza dei coloni e a fornire loro “i servizi necessari alla vita quotidiana e al loro sviluppo”. E, dopo quella data, la colonizzazione prosegue a ritmo sostenuto. Ma il quadro della colonizzazione sarebbe sicuramente sbiadito, se non si parlasse specificamente di Gerusalemme, del resto al centro della nuova Intifada, chiamata dai palestinesi intifada Al-Aqsa, (La Lontana), dal nome di una delle moschee della Spianata, e terzo luogo sacro dell’Islam, che si trova appunto a Gerusalemme.Lo statuto finale della città di Gerusalemme ha rappresentato (e rappresenta) uno dei temi, forse il tema più importante, che divide, da sempre, israeliani e palestinesi.
Vista l’importanza di Gerusalemme, ripercorreremo la sorte di questa città, (che in ogni caso riprenderemo al paragrafo 3) per grandi linee, dalla fine del Mandato alla guerra dei sei giorni del 1967, per poi analizzarne le modifiche in termini di distruzioni e di colonizzazione apportate dalla potenza occupante, assai poco interessata al diritto internazionale e alle risoluzioni dell’ONU. Data di partenza, il mese di maggio del 1947, quando all’ONU, inizia il dibattito sul piano di spartizione della Palestina del Mandato. Gerusalemme è una città di 165.000 abitanti che si estende su di un’area di circa 30 kmq. È costituita dalla Città Vecchia, (poco più di un chilometro quadrato, densissimo di valori però per le tre religioni monoteiste), e da numerosi quartieri ebraici della Città Nuova, sviluppatisi, dopo il 1860.
Gli ebrei costituiscono il 60% degli abitanti. Del resto, dal 1875, sono sempre stati in maggioranza a Gerusalemme.Il 29 novembre 1947, l’ONU vota, come è noto, la spartizione della Palestina mandataria in due Stati, uno ebraico ed uno arabo. Gerusalemme dovrà costituire un corpus separatum internazionalizzato che comprende, dal punto di vista dello spazio, “la municipalità attuale di Gerusalemme, i villaggi e centri circostanti, il più orientale dei quali sarà Abu Dis, il più meridionale Betlemme, il più occidentale Ein Karim (compreso l’agglomerato di Motsa) e il più settentrionale Shu’fat” L’allargamento tende a realizzare un relativo equilibrio dal punto di vista demografico, con 100.000 ebrei e 105.000 arabi (di cui 65.000 musulmani e 40.000 cristiani).
Ovviamente, i primi essenzialmente concentrati nella Città Nuova ad ovest, dove si trovavano anche molti arabi. I secondi nella Città Vecchia e nei quartieri extra muros ad est, con qualche sacca ebraica, il Monte Scopus, in particolare. Tutti i villaggi intorno, Betlemme compresa, erano abitati da arabi. Dal punto di vista amministrativo, Gerusalemme doveva finire:“sotto un regime speciale amministrato dalle Nazioni unite… Lo statuto sarà in principio in vigore per un periodo di dieci anni… al termine del quale… le persone aventi la residenza nella Città saranno allora libere di far conoscere con un referendum i loro suggerimenti relativi ad eventuali modifiche al regime della Città”. In seno all’Agenzia ebraica, la spartizione venne celebrata come una grande vittoria. Totale fu il rifiuto nel mondo arabo.
Il Vaticano, che aveva avuto un ruolo importante nel progetto, risultava di fatto il vero beneficiario, perché quello statuto gli avrebbe permesso di esercitare un’influenza decisamente superiore a quella che avrebbe potuto esercitare nel caso in cui Gerusalemme fosse diventata una città araba o ebraica. Dopo la guerra 1948-1949, oltre a non nascere lo Stato arabo, di Gerusalemme come corpus separatum nemmeno l’ombra. Le disposizioni, mai annullate, non verranno mai applicate. Mistero onusiano!
Dal settembre 1948 in poi, i sionisti assumono una posizione molto rigida. Si oppongono all’internazionalizzazione di Gerusalemme, preferendo accordarsi con Abdallah di Giordania su di una tacita spartizione, da verificare successivamente con le armi! In realtà, Gerusalemme sarà sì un corpus separatum, ma soltanto nel senso che invece di essere un corpo a sé stante, sarà un corpo fatto a pezzi! Nascono così, Gerusalemme-Ovest, in mano agli israeliani e Gerusalemme-Est in mano ai giordani (e anche questa in fondo è una spartizione…). Gli israeliani, fin dal gennaio del 1950, dichiareranno Gerusalemme capitale dello Stato ebraico. I giordani, rimasti padroni della Città Vecchia, cacceranno gli ebrei che vi abitavano. La frontiera è un dato di fatto militare, e cioè la linea di demarcazione definita all’atto del cessate il fuoco del novembre 1948, la famosa linea verde. Subito dopo il 1967, il Vaticano non proporrà più l’internazionalizzazione, ma uno statuto internazionale garante dei Luoghi Santi. Con la vittoria del 1967, gli israeliani si impadronirono dell’intera città e, il 27 giugno dello stesso anno, estesero ad essa legge, giurisdizione ed amministrazione dello Stato d’Israele. Scomparve così la municipalità palestinese, in funzione dal 1948. E, fin da subito, iniziò la colonizzazione della Gerusalemme araba, di Gerusalemme-Est, che comportò la distruzione, via bulldozer, del quartiere maghrebino, (prima ancora che la guerra finisse), per far posto ad un enorme piazzale, antistante il Muro del Pianto, oltre che la restaurazione del quartiere ebraico. Ne fecero le spese più di 5000 palestinesi, espulsi dalla Città Vecchia. A questa “pulizia etnica” seguì un’astuzia amministrativa. I confini municipali della città furono arbitrariamente dilatati fino a comprendere un territorio dodici volte più grande, per quanto riguardava Gerusalemme-Est (da 6 a 72 kmq) e, complessivamente, 108 kmq, l’equivalente della superficie di Parigi! L’astuzia consistette nel realizzare un’operazione chirurgica sul territorio, che comportò l’esclusione di importanti comunità palestinesi dalla vita di Gerusalemme, pur comprendendone le loro proprietà! In questo modo, si evitò di aggiungere 80.000 palestinesi alla già numerosa popolazione araba di Gerusalemme, gettando le basi, allo stesso tempo, per una successiva confisca delle proprietà private dei palestinesi. Tale confisca si è puntualmente verificata, e su quelle terre sono state costruite colonie ebraiche, veri e propri quartieri residenziali come Gilo ad esempio, chiamate eufemisticamente in Israele “dintorni”, quartieri limitrofi. In trentatré anni, (dal 1967 al 2000), più di 27.000 dunum (27 kmq, pari a più di quattro volte le dimensioni di Gerusalemme-Est) di proprietà di palestinesi subiscono la stessa sorte: confiscati per “pubblica utilità”. Peccato che l’aggettivo “pubblica” è riferito soltanto agli ebrei, quanto al sostantivo “utilità” è poi riferito alla costruzione di colonie residenziali o di colonie tout court, che hanno accerchiato le zone abitate dai palestinesi nella città. Ai palestinesi di Gerusalemme-Est è toccata anche la brutta sorte di diventare poveri, Infatti, oltre ad essere stati espropriati e soppiantati dagli israeliani, hanno anche perduto terre per un valore di due miliardi di dollari USA (più di 4.000 miliardi di vecchie lire italiane).
Vediamo ora più in dettaglio la cronologia delle confische e degli espropri. La parte più cospicua è avvenuta agli inizi degli anni Settanta ed Ottanta ma confische ed espropri sono continuati negli anni Novanta e continuano ancora …
Per riassumere: nei mesi di gennaio e di aprile del 1968, furono confiscati 4.800 dunum; nell’agosto del 1970, 13.800; nel marzo 1980, 4.500; nell’aprile del 1991, 1840; nell’aprile del 1992, 2400 dunum vennero definiti green zone (zona verde) e dunque non utilizzabili dai palestinesi per costruire. Con il completamento di Har Homa (Jabal Abu Ghneim per i palestinesi), la più provocatoria iniziativa di Netanyahu, i 200.000 palestinesi di Gerusalemme-Est sono circondati da tutte le parti. Si tratta di una serie di fatti compiuti che hanno ignorato, anzi hanno approfittato del processo di pace, in aperta violazione del diritto internazionale e delle Risoluzioni dell’ONU. Oltre alle Risoluzioni 242 e 338, riguardanti l’insieme dei Territori occupati, ci sono altre specifiche Risoluzioni che condannano esplicitamente l’attività colonizzatrice israeliana a Gerusalemme-Est. In particolare la 252 del maggio 1968, la 279 del 15 settembre 1969, la 446 del 22 marzo 1979, la 476 del 30 giugno del 1980 e la 478 del 20 agosto del 1980. Della Risoluzione 476 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riportiamo qui di seguito un estratto.
“Deplorando che Israele continui a modificare il carattere fisico, la composizione demografica, la struttura istituzionale e lo statuto della Città santa di Gerusalemme.Gravemente preoccupato per le misure legislative adottate alla Knesset israeliana per modificare il carattere e lo statuto della Città santa di Gerusalemme.1. Riafferma la necessità imperiosa di mettere fine all’occupazione prolungata dei territori arabi occupati da Israele dopo il 1967 ivi compresa Gerusalemme […]3. Conferma di nuovo che tutte le misure e le disposizioni legislative e amministrative prese da Israele, la potenza occupante, per modificare il carattere e lo statuto della Città santa di Gerusalemme non hanno alcuna validità in diritto e costituiscono una violazione flagrante della convenzione di Ginevra relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra […]6. Riafferma la sua determinazione, nel caso in cui Israele non si conformi alla presente risoluzione, di prendere in esame in conformità alle pertinenti disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, i mezzi pratici per assicurare l’applicazione integrale della presente risoluzione”.
Ho usato spesso l’espressione “fatto compiuto“. Se qualcuno non sapeva cosa fosse, ora lo sa! In realtà, non c’è da meravigliarsi che Israele non abbia rispettato le Risoluzioni dell’ONU relative a Gerusalemme. Dal momento che non ne ha rispettata nessuna, compresa quella che ha dato vita allo Stato d’Israele, e non intende nemmeno rispettare la Risoluzione 194 relativa al diritto al ritorno dei rifugiati. In fondo, a che serve questo diritto internazionale, quando si dispone di un padrino come gli USA, maestro nell’infischiarsene e di un contesto internazionale prono ai piedi del padrino? Una volta l’Italia veniva accusata di essere favorevole ai palestinesi, ora questo rischio non lo corre più, dal momento che, con l’Europa, ignora la tragedia palestinese ha dato credito al macellaio di Sabra e Chatila, che bombardava tutti i giorni le misere case e le caserme palestinesi, (tutte piene di terroristi, intenti a confezionare ordigni micidiali), circa la sua buona volontà di riprendere le trattative, come continua a farlo con Netanyahu, sempre che cessi la violenza!
Vorrei invitare i lettori che hanno figli piccoli a non parlare loro di Esopo e comunque non della favola del lupo e dell’agnello! La pace in Israele/Palestina potrebbe esserci dal tempo, se il processo di pace fosse stato inteso, nel rispetto del diritto internazionale e delle Risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, come un processo graduale di restituzione dei Territori occupati, come un calendario di crescita di fiducia tra due popoli separati dalla nakba del 1948 e non invece come una serie di concessioni territoriali fatte dal più forte per legittimare la conservazione delle colonie, la rinuncia, da parte araba, a Gerusalemme-Est ed infine alla banalizzazione del problema dei rifugiati, come ricongiungimento di pochi nuclei familiari e senza nemmeno l’ammissione della ormai conclamata, anche da parte di storici israeliani, quelli “nuovi”, dell’espulsione di 750.000 palestinesi durante la guerra del 1948.
Saltiamo ora al 27 febbraio 2000, quando, all’Università palestinese di Bir Zeit, una sassaiola, opera di studenti, una sorta di mini intifada, costrinse ad una fuga ingloriosa Lionel Jospin, reo di aver accusato Hezbollah di terrorismo. Soltanto qualche mese prima, un ufficiale superiore dell’esercito israeliano aveva rilasciato al quotidiano Ha’aretz (La Terra, in ebraico), una dichiarazione di tutt’altro avviso:“Hezbollah non è un’organizzazione terroristica, ma un movimento di liberazione nazionale, che conduce operazioni di guerriglia. In queste condizioni, non abbiamo nessuna possibilità di farcela. Dobbiamo avere il coraggio di guardare la verità in faccia: noi non abbiamo più niente da fare in questo paese [il Libano]”.
Il 22 maggio Israele riceve un saggio della disfatta, con l’arrivo di Hezbollah alla frontiera. Viene liberato simbolicamente il villaggio di Hula. I mercenari si squagliano a tempo di record. Migliaia di libanesi ritornano in dodici villaggi abbandonati. L’aviazione israeliana fa cinque morti e più di trenta feriti.Gli Hezbollah, oltre ad avere una “fede incrollabile“, hanno in realtà goduto di un sostegno nell’opinione pubblica libanese che va ben oltre la comunità sciita da cui sono nati. Del resto, le “Brigate libanesi della resistenza”, cui diedero vita nel 1998, raggruppano oggi combattenti di tutte le confessioni, sunniti, drusi ed anche cristiani. Proprio per rafforzare il carattere nazionale del movimento lo sceicco Hassan Nasrallah, capo di Hezbollah dal 1992, si era opposto alla nascita di “brigate arabe”, come è avvenuto altrove, con il risultato che la maggioranza della classe politica libanese ha visto di buon occhio il movimento di resistenza. Ed ora Hezbollah spera forse in una pace totale, che porti ad un Libano liberato dall’occupazione israeliana ma anche siriana.
Nel frattempo israeliani e palestinesi si ritrovano nella base aerea americana di Bolling, vicino Washington, per cercare di definire, prima della fine di maggio, le grandi linee di un accordo globale che dovrebbe concludersi al massimo entro il 13 settembre 2000. Ma, nonostante l’impegno del mediatore americano Aaron Miller, che ha messo a disposizione delle due delegazioni anche la sua casa, le cose non vanno molto avanti. Si parla molto, ma Israele continua a non voler riconoscere la sua responsabilità sulla Nakba e, per quanto riguarda Gerusalemme Est, ripropone la solita autonomia amministrativa, mentre i palestinesi vogliono entrare nel vivo del contenuto dell’accordo quadro, e chiedono di definire con precisione le frontiere, lo statuto di Gerusalemme, la dimensione delle aree militari poiché definiti questi punti in termini percentuali, il resto dovrà essere trasferito a loro, con relativa scomparsa delle zone B e C.
Arafat, il 7 aprile, definisce i negoziati di Bolling una “perdita di tempo”.Sono giorni, questi, in cui si va sempre più deteriorando il rapporto tra Arafat e Barak. Quest’ultimo, mentre si prepara a partire (9 aprile) per Washington per incontrare Clinton, trova il modo di dichiarare che il blocco di colonie intorno a Gerusalemme (Maale Adumim, Pisgat Zeev, Ghilo e Ramot) resterà comunque sotto la sovranità israeliana. Dal Cairo, Arafat esprime un giudizio durissimo nei suoi confronti, sostenendo che è peggiore di Netanyahu. Ma il giorno dopo, Saeb Erekat parla dell’apertura di trattative segrete in Svezia. Per la Palestina c’è il presidente del parlamento, Ahmed Korei con Hassan Asfur, per Israele, Shlomo Ben-Ami e Gilad Sher, avvocato assai vicino a Barak.
Il 21 maggio, Barak intima ad Arafat di scegliere tra il negoziato e l’intifada e interrompe le trattative di Stoccolma. La situazione in Libano precipita. L’opinione pubblica palestinese rimane colpita dalla precipitosa ritirata dell’esercito israeliano. Molti confrontano ciò che Hezbollah ha ottenuto con la forza con quanto Arafat ha perso con i negoziati. Per Arafat, in visita a Madrid il 26 maggio, si tratta “innanzitutto di una vittoria della pace“, replicando così a chi chiama alla lotta armata. In una intervista alla televisione israeliana, forse per riesumare la 242, sostiene una tesi ardita e, a nostro modesto parere, totalmente errata, e cioè che Barak ha ordinato il ritiro non “a causa di Hezbollah” ma “per rispettare la risoluzione 425“!
La risposta del capo di Hamas, lo sceicco Ahmed Yassin, non si fa attendere. Per lui, il 29 maggio annuncia la nascita di “una nuova era“, sostenendo che gli avvenimenti libanesi “dimostrano che la resistenza è la sola via possibile. Quale che sia l’equilibrio tra le forze, la determinazione di un popolo prevale sempre sulla potenza militare“. Sicuramente giusta l’analisi rispetto al Libano, purtroppo soltanto affermazione di principio rispetto ad una situazione, quella palestinese, non immediatamente riconducibile, per motivi storici, politici e militari alla situazione libanese. Questo sempre a nostro modesto parere.Gli avvenimenti precipitano. IL 4 giugno l’OLP prepara la proclamazione dello Stato palestinese, prevista per il 13 settembre. La Albright è a Ramallah il 6, per incontrare Arafat. L’incontro è burrascoso. Alla conferenza stampa, il ministro degli esteri americano annuncia il ritorno dei negoziati a Washington, dopo il fallimento di Eilat e il ricevimento di Arafat alla Casa Bianca, il 14 giugno. In sostanza, il 6 giugno, ad Arafat venne proposto-imposto un vertice a tre a Washington. Arafat riteneva che le condizioni non fossero mature non avendo gli israeliani mantenuto gli impegni presi ad Eilat e in quello stesso giorno, nel corso del pranzo in onore degli americani, a Ramallah, Arafat si rivolse così alla Albright:
“Signora segretario di Stato, se convocate un vertice e questo fallisce, la speranza dei nostri popoli di vedere instaurare la pace diminuirà ancora. Sarebbe saggio non deludere ancora questa speranza“.
La Albright non tenne conto dei dubbi espressi, nella riunione pomeridiana, anche dai negoziatori palestinesi, incontrò la sera Barak e, dopo essersi consultata con i suoi collaboratori, comunicò a Clinton di ritenere opportuna la convocazione del vertice. Cominciò, con la decisione della Albright, un tour de force per Arafat. Il 15 giugno incontra di nuovo Clinton, che dice di “voler finire il lavoro puntualmente” e s’impegna a far rispettare la scadenza finale del 13 settembre. Subito dopo, sospese i negoziati di Washington, dopo l’annuncio israeliano della liberazione di 3 (tre) prigionieri al posto di 230 e del trasferimento all’ANP dell’1% del territorio, quale ultimo ritiro dalla Cisgiordania, mentre l’accordo interinale prevedeva il 10% prima del 23 giugno.
Il 7 giugno Madeleine tornò in Israele per preparare il vertice a tre a Camp David, per i primi di luglio, continuando ad ignorare il parere dei palestinesi circa il sicuro fallimento dello stesso. A portare all’incandescenza il clima dovuto alle forti pressioni e alle reiterate inadempienze contribuì non poco l’intervento del procuratore israeliano Eliyakim Rubistein. Costui giudicò le risoluzioni 242 e 338 non applicabili, in quanto, all’atto dell’adozione delle risoluzioni, l’ANP non esisteva e che in esse, i palestinesi venivano menzionati soltanto come rifugiati! Bella mossa! E così viene di nuovo a galla la tesi del “buon cuore israeliano”. Secondo la quale, lo Stato palestinese non ha fondamento nel diritto internazionale, ma soltanto nella benevolenza israeliana, che occorre sapersi guadagnare. Si sta creando il contesto del vertice.
Americani a premere, al servizio delle tesi israeliane o servendosi delle stesse, sui palestinesi, perché accettino ancora una volta, ma questa volta senza più poter recriminare, un accordo che cancelli la Nakba, la realtà araba di Gerusalemme e anche la perdita definitiva di una parte del loro territorio residuale, per poter dar vita (sarebbe vita?) ad uno Stato di Palestina senza reale sovranità.Clinton chiama di nuovo Arafat, che lo invita a convocare negoziati preparatori e non un vertice. Il 4 luglio, Clinton, “portavoce” di Barak, dice ad Arafat che il Premier israeliano è contrario a negoziati preparatori, ma che ha “cose nuove da proporre”. Arafat non si arrende, mette di nuovo in guardia sui rischi di un fallimento, ma Clinton ormai è finito nella trappola dei “funzionari dell’impero” che lo hanno convinto della possibilità di incastrare i palestinesi! Partono gli inviti per l’undici luglio, a Camp David”.Come sono andate le cose dopo, e come vanno oggi lo sappiamo. Ma l’11 settembre diventa sempre di più una scusa che un evento epocale!
- Lo studio sulla colonizzazione di Gerusalemme-Est
Lo studio che viene qui proposto (pagg. 85-108 del testo richiamato all’inizio del paragrafo 2), è opera di Jean Paul Chagnollaud, cui devo moltissimo sia per quanto riguarda le mie conoscenze sulla colonizzazione sionista in Palestina sia per quelle relative all’Intifada del 1987. Io penso che sia lo studioso che con maggiore sistematicità abbia affrontato il dramma del popolo palestinese, restando sempre lontano da un coinvolgimento ideologico. Forse è questa la ragione per cui i suoi testi non hanno trovato nessun editore in Italia! Sono perciò entusiasta di poter proporre, ancora una volta le sue argomentazioni e, in questo caso, un testo essenzialmente suo. Qualsiasi modifica fatta da me, nel quadro della traduzione è dovuta soltanto al mio tentativo di rendere più chiaro il testo ad un pubblico non sempre esperto della materia trattata. Spero di essere riuscito nell’intento, senza però aver tradito l’autore. Ed ora diamo la parola a Jean Paul!
Il processo di annessione unilaterale di Gerusalemme
Quando si arriva a Gerusalemme provenendo dall’aeroporto di Tel Aviv, si incontra prima la sua parte Ovest, abitata da israeliani e strutturata in vasti quartieri moderni con scuole, ospedali, grandi alberghi, ristoranti come all’incirca in qualsiasi altro agglomerato al mondo. Poi si arriva vicino alla città Vecchia, circondata dalle sue imponenti mura, attraversate da alcune grandi porte, le più importanti delle quali sono quella di Jaffa a ovest e quella di Damasco a est. Discendendo dall’una all’altra, si scopre rapidamente la parte Est della città, abitata da palestinesi, con la sua principale arteria, Salahedin street. In pochi minuti si potrebbe pensare di aver individuato le tre componenti principali di questa città. In realtà, il visitatore non ha visto quasi niente, dal momento che la città si estende in molteplici direzioni per inglobare zone assai differenti e soprattutto assai contrastanti. Si colgono almeno due grandi tipi di urbanizzazione.
Nella parte centrale di Gerusalemme-Est (da nord a sud) vasti complessi abitativi costruiti dagli israeliani, che non sono altro che colonie come ce ne sono tante altre nei Territori occupati e che sono riservati alla popolazione ebraica israeliana. Queste costruzioni moderne, abitate ciascuna da migliaia di persone, godono di un’ottima manutenzione, sono servite da buone strade e da buoni servizi di trasporto.
Alla periferia, ci sono alcuni villaggi o quartieri palestinesi che fanno pensare di trovarsi in una città di quello che veniva chiamato una volta terzo mondo, dove le strade sono quasi impraticabili, dove spesso si incontra, qui e là, spazzatura venuta non si sa da dove, che il vento sparpaglia in tutte le direzioni. Nessuna traccia di commercio o di servizi o quasi. Questi posti, che rassomigliano a terre di nessuno, sono abitati da migliaia di uomini e donne dagli abiti malandati, dalle automobili ammaccate e dagli sguardi tristi, che danno un’idea di quanto debba essere difficile la loro vita quotidiana, soprattutto dopo la costruzione del Muro della vergogna, che li pone in situazioni impossibili.
E tuttavia, questi spazi così diversi sono sotto l’egida della stessa municipalità creata dopo la guerra del 1967 dal governo che aveva ben presto decretato l’annessione de facto della città, dotandola di limiti municipali che andavano ben al di là di quelli esistenti sotto il regime giordano. Quelli cioè della Gerusalemme storica. Questa configurazione apparentemente caotica non deve nulla al caso. Al contrario, essa è il risultato di una politica coerente e sistematica il cui obiettivo è chiarissimo: fare in modo che Gerusalemme occupi il più vasto spazio possibile con il minor numero di palestinesi, per realizzare il sogno di una Gerusalemme “riunificata”, popolata da una larga maggioranza ebraica. Gerusalemme costituisce senza alcun dubbio il cuore del conflitto israelo-palestinese, poiché vi si trovano condensate tutte le sue dimensioni storiche, politiche, demografiche e religiose. Per gli uni come per gli altri, essa deve essere la capitale del loro Stato, cosa che, sia pure formalmente, la comunità internazionale continua a rifiutare allo Stato d’Israele (che l’ha proclamata unilateralmente dal 1950), e che gli israeliani rifiutano ai palestinesi che non hanno nemmeno più, da tempo, il diritto elementare di accedervi, se non sono residenti.
Durante la guerra del 1948, per conquistare questa città popolata da 205.000 abitanti (circa 100.000 ebrei e 105.000 palestinesi, di cui 60.000 musulmani e 45.000 cristiani), ci fu uno scontro durissimo tra l’esercito israeliano e la Legione araba giordana, e al cessate-il-fuoco le due forze in campo si trovarono faccia a faccia vicino alle mura della città Vecchia, che rimase sotto la dominazione giordana, mentre gli israeliani si installarono in tutti i quartieri della parte Ovest della città compresi quelli interamente popolati da palestinesi, costretti a lasciare le loro case. Questo flusso di profughi costituì una parte importante dell’esodo palestinese del 1948 e la prima tappa dell’attivazione del progetto israeliano di giudaizzazione della città, mentre alcune migliaia di ebrei che risiedevano nella città Vecchia subirono lo stesso destino, raggiungendo la parte Ovest della città. Negli anni successivi, la giudaizzazione di Gerusalemme-Ovest è avvenuta senza un’importante opposizione, poiché i palestinesi l’avevano abbandonata per esiliarsi a qualche chilometro dall’altra parte, o addirittura a poche centinaia di metri per quelli che, ad esempio, abitavano nei pressi della Porta di Jaffa e che si installarono nella città Vecchia.
Ma è con la guerra del giugno 1967 che la situazione precipita poiché, da quel momento, Israele controlla tutta la Palestina compresa perciò Gerusalemme. Immediatamente, la città viene percepita da una grandissima maggioranza di israeliani in maniera del tutto differente dal resto dei territori palestinesi appena conquistati. Se i vari governi succedutisi hanno esitato sulla politica da tenere rispetto ai nuovi territori, questo non è avvenuto in relazione a cosa era necessario decidere per Gerusalemme. Da allora, e senza che questo fatto abbia avuto mai una smentita, esiste un forte consenso tra i partiti di destra e di sinistra per farne una grande metropoli dove gli ebrei siano largamente in maggioranza.
Tutto questo trova d’altronde una prova immediata il 27 giugno 1967, con un voto della Knesset che stabilisce: “La legge, la giurisdizione e l’amministrazione dello Stato si estenderanno a qualsiasi porzione di Eretz Israel indicata per decreto governativo”. Molto rapidamente vengono insediati a Gerusalemme-Est numerosi servizi amministrativi municipali e, qualche anno più tardi, nel luglio 1980, la Knesset adotta una legge fondamentale secondo la quale “Gerusalemme riunificata è la capitale d’Israele… (e) la sede del presidente dello Stato, del governo e della Corte Suprema”.
Questo vasto progetto, che s’inquadra pienamente nella logica sionista, è oggi, nel 2010, praticamente realizzato. Esso è costituito da quattro grandi articolazioni strettamente intrecciate le una con le altre e cioè l’estensione del perimetro dello spazio della città e fuori della città; la chiusura della città con un immenso muro di cemento che la separa dall’habitat palestinese, integrandola con l’hinterland israeliano; lo spossessamento fondiario dei palestinesi, con relativa costruzione di vaste colonie ebraiche; il logoramento sistematico degli abitanti palestinesi di Gerusalemme.
L’estensione del perimetro dello spazio della città e fuori della città
Questa estensione si è svolta in tre grandi tappe strettamente legate tra di loro anche se, ogni volta, di natura differente. La prima è consistita in una modifica unilaterale del perimetro originario della città, La seconda si è svolta all’esterno dei nuovi limiti con la creazione di una nuova colonia a meno di dieci chilometri da Gerusalemme. La terza ha riguardato una “nuova” forma di gestione del territorio, in realtà un progetto di sviluppo di una vasta metropoli: la “grande Gerusalemme”.
La modifica unilaterale dei limiti municipali
Sulla base di un testo di legge votato dalla Knesset nel mese di giugno 1967, il governo ampliò in misura spropositata il perimetro urbano della città, ben al di là dei limiti urbani di Gerusalemme-Est e dunque al di là della linea verde che costituiva la linea di demarcazione relativa alla guerra del 1948. Questa iniziativa unilaterale va considerata di fatto come una forma mascherata di annessione di nuovi territori assolutamente contraria al diritto internazionale, come ha ribadito il Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione 252 del 1968. Per attivare questo progetto, era necessario confiscare terre arabe, evitando il più possibile d’integrare, con la stessa operazione, nuove popolazioni nella città che non potevano che essere palestinesi o giordane. Servivano le terre ma non i loro abitanti e di conseguenza ecco i nuovi limiti municipali che fanno lo slalom tra questi vincoli demografici per giungere ad una nuova geografia della città particolarmente sinuosa, ricca di gomiti e di incavi, stirandosi verso sud e allungandosi lungo la verticale verso il nord, quasi fino alla periferia di Ramallah. Una metafora sessuale, ispirata alla forma assunta dai nuovi confini municipali, fa pensare ad un enorme fallo che stupra il cuore della Palestina. La superficie di Gerusalemme-Est passò così da 6 (sei) chilometri quadrati (che comprendevano anche il chilometro quadrato relativo alla città Vecchia) a circa 70 (settanta) kmq. Sommata alla parte Ovest della città, la superficie totale di Gerusalemme risulta essere di 108 kmq, abitata da 266.000 persone, per tre quarti ebree.
La costruzione di Ma’ale Adumim
La colonia di Ma’ale Adumim, situata a pochi chilometri da Gerusalemme in direzione di Gerico, ha conosciuto all’inizio una storia assai contrastata, prima che il Likoud, arrivato al governo nel 1977, non la classificasse in zona di sviluppo prioritario, dopo averla legalizzata, in modo da permetterle di beneficiare di sovvenzioni per gli alloggi, di riduzioni di tasse e di prestiti agevolati. Dopo dieci anni, questa nuova colonia, consacrata ufficialmente nel 1992 prima città ebraica dei territori, è in piena espansione con circa 15.000 abitanti. Nel 1994, e cioè quando erano stati da poco firmati gli accordi di Oslo, il governo di Yitzhak Rabin, che intendeva continuare in maniera intensiva la politica dei fatti compiuti sul terreno, malgrado i negoziati con i palestinesi, prese la decisione di allargarne i limiti molto ampiamente, aggiungendo nuove riserve fondiarie, di fatto terre espropriate a cinque villaggi: El-Eisawiyeh, El-Tour, El-Eizariyeh, Anata e Abu Dis. Si trattò di una sorta di misura conservativa, che permise ad Israele di prendere tempo e di conservare per un uso successivo queste terre, dal momento che all’epoca, non fu presa alcuna decisione concreta.
Occorrerà infatti aspettare il 2005 perché il governo di Ariel Sharon decida di utilizzare questa riserva fondiaria per lanciare uno dei più grandi progetti di costruzione di colonie. Una prima fase, 3.500 nuovi alloggi e l’installazione del quartier generale della polizia per la Cisgiordania. I piano in questione si chiama “E1”, comporta anche una zona di sviluppo economico, zone commeciali, alberghi, istituti d’insegnamento superiore, un cimitero e un ampio parco che circonderà il tutto. La sua superficie totale è dell’ordine di 50 kmq e si stende praticamente da Gerusalemme a Gerico. La sua realizzazione deve collegare Ma’ale Adumim alle altre colonie di Gerusalemme-Est come Psigat Omer, Neve Yaacov e French Hill, creando così una continuità territoriale tra tutti questi quartieri ebraici.
Di fronte alle proteste americane ed europee (si fa per dire!) il governo ne ha congelato per qualche tempo l’applicazione, ma, dalla fine del 2006 sono state prese le prime misure effettive, con l’insediamento in particolare del centro di polizia. All’inizio del 2007, la zona si è trasformata in un immenso cantiere, con lavori di terrazzamento e l’apertura di nuove infrastrutture stradali. E oggi se ne vedono i risultati !
Ariel Sharon aveva preso questa decisione perché il piano s’inseriva perfettamente nella strategia di frantumazione del territorio palestinese, che puntava (e punta) a creare svariati cantoni isolati gli uni dagli altri. Questo progetto è assai vicino ad essere realizzato, e permette fin d’ora di collegare fisicamente Gerusalemme e Ma’ale Edumim con zone abitate esclusivamente da ebrei, di intercludere villaggi palestinesi come Abu Dis e Al-Eizariyeh, ormai soffocati tra il Muro della vergogna e Ma’ale Adumim, di isolare Gerusalemme dal resto dell’hinterland palestinese e, infine e forse soprattutto, di tagliare in due la Cisgiordania, separando i distretti palestinesi del Nord da quelli del Sud.
Questa separazione è già da oggi operante nei fatti. L’esercito impedisce qualsiasi forma di circolazione ai palestinesi tra il Nord e il Sud della Cisgiordania e, in sovrappiù essi non possono nemmeno accedere alla vallata del Giordano, ormai limitata ai soli residenti.
Una simile configurazione, cui vanno aggiunte le innumerevoli restrizioni alla libertà di movimento di cui sono vittime i palestinesi, rende impossibile la creazione di uno Stato palestinese dotato di continuità territoriale. A questa obiezione il governo israeliano replica che costruirà… un tunnel per renderla un giorno possibile, un chiaro modo per confermare questa politica di frammentazione dello spazio palestinese per favorire un dominio incontrastato degli israeliani.
Quasi a voler sigillare il tutto – nel senso proprio del termine -, è previsto che il Muro in cemento che circonda completamente la parte Est di Gerusalemme, venga prolungato tutto intorno a Ma’ale Adumim passando molto a sud per inglobare alcune piccole colonie come Kedar e molto a nord oltre Almon e Kefar Adumim.
Il progetto della Grande Gerusalemme
Questo progetto rappresenta un’importantissima estensione dell’annessione già realizzata nel 1967 quando lo Stato d’Israele aveva del tutto unilateralmente ridisegnato i limiti municipali della parte Est della città. In seguito, la colonizzazione in Cisgiordania aveva portato alla costruzione di grandi blocchi di colonie intensamente popolate tutto intorno a Gerusalemme, per meglio garantirne il controllo politico e demografico. Lanciato da Benjamin Netanyahu nel 1995, questo progetto riguarda un vasto territorio che va a nord fino a Ramallah, a sud di Betlemme senza includerla e a est verso la periferia di Gerico. Comporta un forte sviluppo di quattro blocchi di colonie che si trovano al di là dei limiti della città di Gerusalemme e che la circondano da nord-ovest, da nord-est, da est e da sud. Queste colonie sono tutte collegate a Gerusalemme-Ovest da una rete stradale efficiente e sofisticata che permette collegamenti rapidi tra i diversi punti di questo spazio ampio, di cui Gerusalemme-Ovest costituisce il cuore, per l’offerta relativa al lavoro e ai servizi (istruzione, salute, alimentazione e tempo libero).
Il fatto nuovo ed essenziale è che questo complesso che inghiotte tutta una parte centrale della Cisgiordania è ormai separato fisicamente dal resto del territorio palestinese dal Muro il cui tracciato ha qui la funzione evidente di fissare una vera frontiera di cemento per consacrare l’annessione unilaterale di questo complesso allo Stato d’Israele.
Il primo blocco si situa a est, intorno a Ma’ale Adumim, punto cardine di questo dispositivo, con, a nord della strada che collega Gerusalemme a Gerico, una serie di piccole colonie che dipendono dal consiglio regionale di Mate Binyamin: Mizpe Yeriho, Kefar Adumim e Almon (3 600 abitanti). A sud-est di Ma’ale Adumim, si trova la colonia di Qedar (450 abitanti). Il complesso, con una superficie di circa 70.000 dunam, si estende fino alla periferia di Gerico e rinforza così la spaccatura tra il Nord e il Sud della Cisgiordania.
Il secondo blocco di colonie si situa a nord-ovest con in particolare Giv’on e Bet Horon che fanno anche loro parte del consiglio regionale di Mate Binyamin e Giv’at Ze’ev che è un consiglio locale. I limiti di queste colonie sono vicini a Ramot che si trova all’interno dei nuovi limiti municipali di Gerusalemme. Un pò più lontano si trova la colonia di Har Adar (circa 2000 abitanti) de facto incorporati allo Stato d’Israele da un tracciato del Muro che si allontana anche qui, deliberatamente, dalla linea verde. Il complesso è servito da strade che collegano questo settore all’autostrada Gerusalemme-Tel Aviv e al centro-città.
Il terzo blocco di colonie si situa a nord-est con in particolare le colonie di Kokhav Ya’akov, Tel Zion e anche Geva Binyamin, che dipendono tutte dal consiglio regionale di Mate Binyamin. Qualche chilometro più a nord, ci sono le colonie di Pesagot e Bet El che fanno parte di un altro sistema ma che, allo stesso tempo, sono vicinissime a questa metropoli. Questi due blocchi, entrambi situati a nord della città, costituiscono una specie di barriera che separa Gerusalemme da una decina di villaggi palestinesi. Più di 30.000 abitanti palestinesi sono così estraniati da quello che è sempre stato il loro centro urbano di riferimento.
Il quarto blocco si trova più a sud, vicino Betlemme. Comprende Betar Illit con 16.000 abitanti, Efrat e una serie di piccole colonie che dipendono dal consiglio regionale di Gush Etzion. Benché sia abbastanza lontano da Gerusalemme, questo settore si integra con la metropoli grazie ad una strada che la collega direttamente con il centro della città, evitando zone popolate da palestinesi. Del resto, come gli altri blocchi di colonie, esso contribuisce alla frammentazione dello spazio palestinese poiché impedisce lo sviluppo dei villaggi palestinesi e limita fortemente la libertà di movimento dei suoi abitanti. In totale, i limiti municipali di queste colonie nella Grande Gerusalemme si estendono per circa 130.000 dunum, due terzi dei quali rappresentavano nel 2002 una riserva fondiaria per progetti futuri, con una popolazione di circa 250.000 abitanti, con l’ambizione di raccogliere nella zona mezzo milione di israeliani per pesare nel rapporto di forze demografico nel cuore dei territori palestinesi.
Gli abitanti di queste colonie, sommati ai 200.000 di Gerusalemme-Est, costituiscono un insieme comparabile con la popolazione palestinese che, per di più, è fisicamente suddivisa tra diverse enclave dovute alla strutturazione spaziale indotta dalle nuove costruzioni israeliane e dal Muro che spezza in modo brutale tutto uno spazio in precedenza continuo.
Il Muro intorno a Gerusalemme
Tutta l’operazione costruita in parecchi anni a partire da piani, tutti rigidamente centrati sull’idea di realizzare una maggioranza ebraica nell’insieme della città, ha trovato una forma di completamento con la costruzione del Muro a partire dal 2003. Ovviamente le conseguenze della costruzione del Muro hanno coinvolto (e coinvolgono) tutta la Cisgiordania. Qui di seguito studieremo le implicazioni relative alla sola Gerusalemme.
Questo mostro di cemento e di acciaio (si tratta in realtà di un’alternanza di un vero e proprio muro di cemento e, per la più gran parte del percorso, di una barriera, limitata da una parte e dall’altra da una rete metallica di circa tre metri di altezza, controllata elettronicamente, ma assai larga, dai 45 ai 100 metri. Questo spazio compreso tra le due reti è occupato da reticolati, da un fossato che impedisce il passaggio ad eventuali veicoli, un sistema di rilevazione di intrusioni e almeno una strada di pattugliamento), il Muro della vergogna, serpenteggia per decine di chilometri intorno a Gerusalemme, schiacciando tutto al suo passaggio, mutilando il paesaggio come un’enorme cicatrice, ferendo le magnifiche colline di Gerusalemme e imponendo una separazione di una violenza estrema che sconvolge letteralmente la vita di decine di migliaia di palestinesi ormai separati gli uni dagli altri, isolati dai loro cari, staccati dal loro ambiente naturale e anche, per molti di loro, rinchiusi in una sorta di ghetto, le cui uniche uscite sono dei tunnel!
L’argomentazione secondo la quale il Muro è stato costruito per ragioni di sicurezza non regge all’analisi precisa del suo tracciato in Cisgiordania. Nel caso di Gerusalemme, l’argomentazione regge ancora di meno tanto è evidente che la decisione di circondare la città con un muro risponde fondamentalmente alla volontà politica di annettersi le più ampie superfici possibili attorno a Gerusalemme e di crearvi un rapporto di forze demografico favorevole agli israeliani ebrei. Si ritrova qui l’ossessione demografica in tutta la sua ampiezza: bisogna fare tutto perché Gerusalemme sia a maggioranza ebraica. E nel quadro di questa ossessione, la Grande Gerusalemme completa in maniera decisiva i dispositivi che permettono di frammentare al massimo il territorio palestinese per impedire qualsiasi possibilità di creazione di uno Stato palestinese vivibile.
All’inizio del 2007, per capire il tracciato del muro e le relative conseguenze, occorre tenere ben separati i limiti municipali della città e la Grande Gerusalemme. I due progetti sono strettamente legati tra loro e sono anche complementari (dal momento che la Grande Gerusalemme consolida, con un’ampia estensione, i limiti iniziali della città) ma non procedono con lo stesso ritmo. Uno è completato mentre l’altro non lo è ancora, soprattutto perché la comunità internazionale ha condannato a più riprese il progetto di una Grande Gereusalemme. Detto questo, le implicazioni per i palestinesi sono più o meno le stesse e si possono individuarne almeno tre tipi : l’esclusione, la chiusura e la separazione.
L’esclusione
Il principio stesso dell’esclusione è semplice: estendere al massimo lo spazio urbano di Gerusalemme espropriando terre palestinesi, includendovi il minor numero possibile di palestinesi. Il caso più flagrante e senza dubbio più importante è quello del circondario di Shu’fat. In questo settore, dove vivono circa 50.000 palestinesi, ovverosia un quarto della popolazione palestinese della parte orientale della città, il tracciato del Muro opera un gran giro per “tirare fuori” questa popolazione della città, lasciandola fuori dal muro, nonostante che si trovi all’interno dei limiti municipali! Il circondario di Shu’fat comprende il campo profughi di Shu’fat, Ras Hamis, Ras l’Shehada, e i quartieri di Dahiyat al-Salaam. Si trova al limite nord-est di Gerusalemme, a sud della colonia Pisgat Ze’ev e a est della colonia French Hill e del villaggio di Isawiya. La grande maggioranza degli abitanti del settore è costituita da residenti di Gerusalemme, e alcuni sono cittadini israeliani. Si noti che la residenza di Gerusalemme è considerata come equivalente allo statuto di “residente permanente” e, in quanto tali, i suoi detentori godono della maggior parte dei diritti e servizi di cui godono i cittadini israeliani, in particolare, hanno il diritto di voto alle elezioni municipali, ma non a quelle parlamentari
Il campo-profughi di Shu’fat fu il primo campo ufficiale. Fu costruito tra il 1964 e il 1966 per ospitare i profughi di Gerusalemme-Ovest che vivevano nel quartiere ebraico della città Vecchia dopo la guerra del 1948.
La popolazione del campo (circa 10.000 rifugiati registrati ai quali conviene aggiungere dalle 10 alle 15 mila persone che non sono rifugiati ma che vivono là) si è sviluppato nel corso degli anni, mentre altri quartieri sono sorti intorno al campo negli anni 1970 e 1980 poiché la popolazione di Gerusalemme-Est aumentava e i residenti cercavano terreni liberi su cui insediarsi. L’ONU fornisce dei servizi di base ai rifugiati, mentre la municipalità di Gerusalemme e lo Stato d’Israele hanno l’obbligo di far fronte ai bisogni di tutti gli altri residenti di Gerusalemme all’interno del campo. In linea generale, le condizioni di vita dei residenti del capo sono decisamente modeste.
Proprio come per il campo di Shu’fat, la municipalità di Gerusalemme è responsabile della fornitura dei servizi per i qurtieri esterni al campo: Ras Hamis, Ras I’Shehada e Dahiyat al-Salaam dove vivono circa 10.000 persone. Tutto questo settore soffre di un’infrastruttura sottosviluppata. Poche strade, poca o nessuna raccolta di spazzatura e assenza qusi totale di illuminazione pubblica. Non ci sono scuole municipali, non ci sono parchi, non ci sono centri sociali e nessun ufficio postale. Per questi quartieri non esiste alcun piano urbanistico, la qual cosa impedisce ai residenti di depositare richieste per costruire. A titolo di confronto, il quartiere vicino di Pisgat Ze’ev, una colonia israeliana fondata nel 1982 a Gerusalemme-Est con i suoi 45.000 abitanti, dispone di una decina di scuole, di diverse cliniche, di un centro sociale, così come di strade, di lampioni, di parchi e di pianificazione paesaggistica. I residenti beneficiano dei vantaggi dei piani urbanistici approvati, della polizia, dei pompieri e di servizi di pronto soccorso. Nel gennaio 2004, Israele ha cominciato a confiscare la terra per la costruzione del Muro sul settore di Shu’fat. Il tracciato previsto lo ha circondato completamente, isolandolo dalla città, limitando de facto l’accesso degli abitanti al resto di Gerusalemme attraverso un solo check-point. Malgrado i ricorsi depositati dai palestinesi, la costruzione del Muro, alla fine del 2005, era già avviata.
La chiusura
Un altro segmento della popolazione palestinese, che viveva al di fuori del perimetro della città, si trova letteralmente chiuso da un muro che si è inserito tra quello delle frontiere municipali e quello della Grande Gerusalemme! Si tratta di quattro villaggi palestinesi che si trovano a nord-ovest della città tra le colonie israeliane di Giv’at Ze’ev e di Ramot Allon: Al-Judeira, Al-Jib, Bir Nabala e Al-Balad. A lavori finiti, i loro abitanti non potranno più uscire da questa enclave se non attraverso tunnel controllati evidentemente dalla polizia israeliana.
Dall’altro lato di Gerusalemme, in prossimità della nuova colonia di Har Homa, alcune centinaia di palestinesi del villaggio di Nu’man vivono da anni un vero incubo. In seguito ad un errore commesso dall’amministrazione israeliana, gli abitanti di questa zona erano stati giuridicamente come residenti della Cisgiordania, mentre erano all’interno del nuovo perimetro di Gerusalemme. A questo titolo, avrebbero dovuto beneficiare dello statuto di residenti di Gerusalemme. Finché il Muro non esisteva, la loro situazione era difficile ma non drammatica, poiché potevano circolare alla meno peggio sia verso Gerusalemme sia verso la Cisgiordania. Con la costruzione del Muro, tutto è cambiato, dal momento che sono ormai bloccati all’interno della città senza disporre però dei documenti che li autorizzino a circolare da questa parte del Muro. Si trovano dunque in una situazione kafkiana poiché non hanno il diritto di stare legalmente nelle loro case e nello stesso tempo non possono più andare dalla parte palestinese a causa del Muro. Gli abitanti hanno depositato diversi ricorsi, ma senza alcun risultato, a tutt’oggi.
La separazione
L’insieme della zona compresa tra Ramallah, Gerusalemme e Betlemme ha sempre rappresentato un bacino di popolazione e di impieghi indivisibile dove la circolazione e gli scambi erano tanto più facili in ragione delle brevissime distanze : alcuni chilometri soltanto separano Ramallah da Betlemme. La decisione israeliana di vietare ai palestinesi di Cisgiordania di andare a Gerusalemme all’inizio degli anni 1990 ha costituito una prima rimessa in discussione di questa unità. Questo divieto, applicato in modo rigorosissimo, isola i palestinesi gli uni dagli altri con tutto ciò che comporta per la vita quotidiana, per le famiglie che non possono più incontrarsi dove desiderano, per i credenti che non possono più recarsi alla moschea di Al-Aqsa, per i commercianti e i lavoratori che non possono più servirsi dell’attività di un centro urbano importante.
Il Muro rafforza violentemente questa separazione perché ormai il minimo spostamento da Gerusalemme verso la Cisgiordania è un percorso di guerra mentre nel senso inverso sono impossibili del tutto percorsi discreti o clandestini che permettano ai palestinesi di andare a Gerusalemme. I pochi punti di passaggio esistenti dove si può superare questo Muro non sono semplici check-point ma veri terminali di frontiera con reti metalliche, porte di ferro e tornelli metallici mediante i quali si operano stretti controlli d’identità assai spesso umilianti per i palestinesi che devono passare uno alla volta davanti a vetri blindati dove i soldati israeliani la fanno da padroni assoluti.
Ci sono ormai anche diversi frammenti di popolazioni esplose: gli abitanti di Ramallah e di Betlemme sono separati, quelli di Gerico vivono in un’oasi circondata da una zona vietata, quelli di Abu Dis sono soffocati tra il Muro di Gerusalemme e presto quello di Ma’ale Adumim, quelli di Anata sono chiusi tra il Muro e una strada a diverse corsie, mentre quelli di Gerusalemme-Est sono praticamente agli arresti domiciliari dal momento che sono bloccati a casa loro in un perimetro sempre più ridotto, con la paura di perdere il loro statuto di residenti della città, nel caso in cui si allontanino per una qualsiasi ragione. Si potrebbe continuare facilmente questa enumerazione seguendo i contorni del Muro che ha accuratamente integrato le colonie israeliane e disintegrato le comunità dei villaggi palestinesi.
Una simile separazione pone molteplici e gravi problemi alla vita di tutti i giorni dei palestinesi, poiché spesso la famiglia, gli amici, il dispensario, la scuola, il centro per lo svago, il droghiere, il panettiere che prima erano a pochi minuti da casa, sono ormai quasi inaccessibili. La via principale di Abu Dis costituisce uno degli esempi che più colpisce: immaginate una larga strada che va dritta verso il centro di Gerusalemme spesso interrotta da un muro in cemento alto otto metri che trasforma quest’asse di vita e di attività in un sinistro vicolo cieco dove tutto deperisce.
Alcuni ricorsi depositati presso la Corte Suprema hanno portato qui e là ad alcune modifiche di tracciato ma mai ad una rimessa in discussione del principio stesso di questa barriera che chiude, esclude e separa una stessa popolazione. All’inizio del 2007 si poteva ancora vedere qualche breccia nel Muro, legate a decisioni provvisorie di sospensione, in attesa del giudizio definitivo. Ad esempio, esiste ancora un passaggio tra due villaggi che hanno sempre vissuto l’uno in rapporto all’altro: Jabal Mukabar (integrato dal Muro a Gerusalemme) e As-Sawahira (lasciato dal Muro all’esterno). Ma già, in attesa del verdetto della Corte, l’esercito ha attivato un check-point nella breccia per filtrare i passaggi. Siccome la circolazione delle automobili è vietata, gli abitanti di questi due villaggi sono costretti a passare a piedi per superare una distanza di trenta metri. Se la Corte autorizzerà la costruzione del Muro in quel punto, i due villaggi saranno separati, come tutti gli altri intorno a Gerusalemme, e tutta la vita di quella fino ad ora è una comunità, ne sarà sconvolta. Si vede bene con questi esempi come le argomentazioni che tentano di spiegare il tracciato del Muro con ragioni di sicurezza non reggano nemmeno per un minuto. Al contrario, l’esclusione, la chiusura e la separazione non possono che generare sofferenze e frustrazioni che un giorno, in un modo o in un altro, se la situazione permane, provocheranno violenze di ogni tipo soprattutto da parte dei giovani che non potranno che ribellarsi contro questa situazione di discriminazione che non esiste in nessun’altra zona al mondo.
Lo spossessamento fondiario
L’estensione continua dei perimetri fondiari controllati da Israele ha senso soltanto se accompagnata da una vigorosa politica di di cocostruzione di nuovi complessi abitativi riservati agli israeliani nella prospettiva di prendere definitivamente possesso di quelle terre per giudaizzare questo settore centrale e vitale dei territori palestinesi. Siamo di fronte, ancora una volta, al centro di una logica che rinvia ai principi fondamentali del sionismo e cioè di impadronirsi al massimo di terre per radicarvi popolazioni ebraiche.
La messa in opera di questa politica obbedisce ad altri principi altrettanto «classici»: si tratta di creare le condizioni di una continuità spaziale tutto intorno e all’interno di Gerusalemme-Est. Ciò implica immediatamente, di spingere i palestinesi alla periferia dal centro dove la popolazione ebraica deve essere maggioritaria – di qui in particolare il tracciato del Muro a est della città che opera inverosimili contorsioni per cacciare all’esterno il più gran numero possibile di palestinesi e di circondare le zone palestinesi del resto già frammentatissime. Queste costruzioni costituiscono del resto un perfetto esempio del modo in cui i governi israeliani sono riusciti, per mezzo di progetti urbani, a cancellare in molti posti ogni traccia della linea verde poiché molti quartieri come Talpiot Est o Ramot Eshkol sono costruiti in piena continuità territoriale con Gerusalemme-Ovest. Dal momento che stiamo prendendo in considerazione soltanto le costruzioni all’interno dei nuovi limiti municipali della città, occorre distinguere le colonie create a Gerusalemme-Est e le molteplici iniziative di insediamento nella città Vecchia.
Le colonie nel nuovo perimetro di Gerusalemme-Est
Una prima fase di costruzione è stata realizzata tra il 1968 e il 1970 per creare una continuità spaziale ebraica dal monte Scopus a Sanhedriya, lungo un asse est-ovest. Negli anni seguenti, un’altra tappa si è avviata con la creazione di nuovi quartieri (o colonie) alla periferia dello spazio centrale per controllarlo meglio e includerlo nel nuovo spazio israeliano: Neve Yaakov a nord dove vengono costruite quasi 4.000 residenze per 20.000 persone circa, Ramot Allon per la quale vengono confiscati più di 4.000 dunam per permettere a circa 40.000 persone di viverci, Gilo a sud che domina Beit Jala e Betlemme, Talpiot Est (1973) su una superficie di più di 2 000 dunum (15 000 persone).
Ad eccezione di Talpiot Est, che si trova sulla linea di demarcazione tra Israele e la Giordania dal 1949 al 1967, queste nuove colonie sono state costruite su terre confiscate a una trentina di villaggi palestinesi bloccando durevolmente così il loro potenziale sviluppo poiché si sono ritrovati privati di spazi fondiari necessari sia alla loro agricoltura che all’estensione del loro habitat.
In totale, esistono ormai dodici colonie che, dal punto di vista del diritto internazionale, hanno esattamente lo stesso statuto illegale di quelle impiantate in Cisgiordania o sul Golan anche se la più gran parte degli israeliani le considerano come quartieri di Gerusalemme alla pari degli altri, dove vivono circa 200.000 persone (2005). La storia di una delle più recenti, Har Homa, è assai rivelatrice del modo in cui il governo procede per queste colonie presenti a Gerusalemme-Est. Il processo si è svolto in tre tempi: 1967, 1991, 1997.
A partire dal 1967, tenuto conto della sua localizzazione (a sud della città), della sua configurazione (una bellissima collina che offre panorami superbi) e delle sue potenzialità fondiarie, questo settore è stato incluso nel nuovo perimetro urbano di Gerusalemme unilateralmente deciso da Israele, mentre in precedenza dipendeva dal governatorato di Betlemme. Successivamente, nel 1968, è stato classificato come zona verde, in modo da impedire ai proprietari palestinesi di costruirvi una qualsiasi cosa. Nel 1991, il governo ha espropriato queste terre essenzialmente proprietà degli abitanti del villaggio vicino Beit Sahour, ma anche di Betlemme, di Sur Baher e di Um Tuba. Infine, nel 1997, Benjamin Netanyahu ha deciso di farci costruire una prima rerie di alloggi rapidamente seguita da altri negli anni successivi. Nel 2007, questa colonia contava diverse migliaia di abitanti e ancora oggi i palestinesi assistono impotenti alla crescita inesorabile di queste costruzionic sulle loro terre. Inoltre, essi temono che questo insieme si estenda anche alle terre circostanti dal momento che ora il Muro passa a poche centinaia di metri dall’abitato, chiudendo così completamente l’accesso di questa piccola montagna, Jabal Abu Ghneim, agli abitanti vicini di Cisgiordania per i quali è stata a lungo una zona per trascorervi il tempo libero. Har Homa e il Muro separano ormai completamente villaggi che prima costituivano un medesimo insieme urbano distando gli uni dagli altri pochi chilometri oggi insuperabili.
Le installazioni nella città Vecchia
La città Vecchia è un universo unico dove ogni costruzione, quasi ogni pietra, conserva tracce di una memoria che si allunga su diversi secoli. L’intensità delle tracce lasciate dal tempo è tanto più forte, vista l’esiguità del perimetro di questo spazio così singolare dove tutto si mischia. Poche centinaia di metri soltanto separano il Santo Sepolcro dal Muro del Pianto che si trova perpendicolarmente alla Spianata delle Moschee… In una configurazione spaziale così esigua, impadronirsi di un semplice cortile diventa una posta importante tra palestinesi e israeliani che vogliono ad ogni costo esercitare il loro dominio sull’insieme della città che vogliono “riunificata”.
Una delle prime decisioni del governo immediatamente dopo la guerra del giugno 1967 è stata quella di radere al suolo le centotrenta case del quartiere maghrébino che si trovavano di fronte al Muro del Pianto per creare una vasta spianata dalla quale lo si può vedere interamente. Questa decisione si inseriva in un piano complessivo di rinnovamento e di estensione del quartiere ebraico vicino, che gli ebrei avevano dovuto abbandonare nel 1948 quando la Legione araba ne aveva assunto il controllo. E, da allora, e soprattutto dopo la vittoria del Likoud nel 1977, alcuni gruppi ultranazionalisti israeliani organizzati o che ispiravano al Goush Emunim hanno, a più riprese, tentato di acquistare immobili nel quartiere musulmano della città Vecchia.
Ateret Cohanim, diretto dal rabbino Shlomo Aviner, figura influente del campo nazionale religioso, è una delle organizzazioni radicali tra le più attive in questo ambito e ha la sua sede proprio in una yeshiva che si trova nel quartiere musulmano della città Vecchia, dove alcune decine di studenti si dedicano allo studio dei riti praticati nel Tempio di Salomone. E’ in parte grazie ad essa che Ariel Sharon, anche proprietario di una casa nei pressi della Porta di Damasco, ha fatto annunciare, en 2005, l’approvazione di un progetto di costruzione di un complesso di diversi edifici e di una sinagoga a Burj Al-Laqlaq su di una superficie di circa 11 dunum (11.000 mq) tra la Porta dei Leoni e la Porte di Erode suscitando immediatamente vivissime reazioni tra i palestinesi.
Nello stesso periodo sono state prese altre iniziative importanti. E così, diversi edifici imponenti, di cui alcuni come l’hotel Imperial, situati sulla piazza della Porta di Jaffa, che controlla l’entrata occidentale della città Vecchia, sono stati riacquistati in condizioni che restano assai oscure. Queste operazioni immobiliari condotte in gran segreto sembrano annunciarne altre, con gran soddisfazione di alcuni giornali israeliani come Maariv (18 marzo 2005) che fa questo commento: “Ultimamente due gruppi di investitori .ebrei stranieri hanno comprato in segreto i terreni del quartiere … hanno speso milioni di dollari con un obiettivo preciso: restituire Gerusalemme agli Ebrei”
Tenuto conto dell’importanza delle poste in gioco e delle passioni che suscitano, questo tipo di acquisizioni sono condotte nella più grande discrezione e molto spesso da società di copertura dove i coloni non compaiono. Una delle più note di queste società è la Atara Leyoshna che, in diversi anni, è riuscita a comprare numerose case e appartamenti nel quartiere musulmano. Gli inquilini palestinesi hanno finito con l’andarsene o perché stanchi delle svariate forme di logoramento, o perché hanno accettato sostanziosi compensi finanziari.
Nella stessa logica di questo tipo di iniziative, vanno collocate le decisioni del governo che hanno portato a spossessare i palestinesi di molte istituzioni a Gerusalemme-Est emblématiche del loro radicamento in questa città, la più importante delle quali è la presa di possesso con la forza e la chiusura (nell’agosto 2001) della Casa dell’Oriente aperta nel 1992 da Feisal Husseini, discendente di una grande famiglia dela città e responsabile politico inportante dell’OLP (morto nel 2001). Nel periodo degli accordi di Oslo, era diventata una specie di municipio ufficioso che rappresentava gli interessi della popolazione palestinese a Gerusalemme-Est e un centro di ricerca documentatissimo sulla colonizzazione della città da parte dello Stato d’Israelel. La Road map proposta dal Quartetto nel maggio 2003 comprende la sua riapertura, ma più tempo passa e più questa eventualità si fa remota e problematica.
Il logoramento sistematico degli abitanti palestinesi di Gerusalemme
Tutta l’urbanizzazione e, in senso più ampio, tutte le misure prese dalla municipalità di Gerusalemme, compreso il fatto che soltanto una modestissima componente del suo budget sia destinata ai quartieri palestinesi, sono condizionate da una vera e propria ossessione demografica. Non deve accadere che i rapporti di forze tra le due comunità possano risultare in favore dei palestinesi. Gli ebrei rappresentano il 72% della popolazione e questo rapporto deve restare immutato. In nessun caso, i palestinesi devono avvicinarsi al al “tetto” del 30% come viene detto in modo assolutamente esplicito in molti documenti ufficiali israeliani. Questo obiettivo porta ad esercitare una politica particolarmente repressiva nei confronti dei palestinesi per spingerli ad andarsene e, in ogni caso, per impedire loro di costruire.
Spingerli ad andarsene
Questa politica che non viene espicitata e che non viene ostentata in quanto tale, consiste nel far di tutto per rendere difficile la vita ai palestinesi di Gerusalemme che haano questo strano statuto di non essere alla fine né cittadini israeliani, come lo sono più di un milione di loro, discendenti di coloro che rimasero sulla loro terra (diventata territorio israeliano) dopo il 1948, né soggetti all’Autorità palestinese. Hanno una carta d’identità (bleu) che permette loro di vivere a Gerusalemme, ma non di votare in Israele, n* di avere un passaporto israeliano. Il rinnovo di questo documento presso il Ministero dell’Interno è complicatissimo da ottenersi e spesso umiliante, visto che alcune procedure recenti hanno, se possibile, inasprito il processo. Risultato: regolarmente alcuni sono costretti ad andarsene. La stessa cosa avviene migliaia di altri che hanno vissuto per un periodo prolungato fuori della città, per esempio per fare i loro studi all’estero. Se non hanno compiuto i passi necessari e ripetuti presso le autorità israeliane per ottenere il rinnovo dei loro documenti, si ritrovano stranieri a casa loro poiché non possono più rientrare se non con un’altra nazionalità. Essi tornano a vedere i propri caricon lo statuto di turisti stranieri!. Stessa situazione impossibile per le coppie, nelle quali un membro della coppia possiede una carta d’identità bleu e l’altro una verde (per la Cisgiordania). C’è un’incessante pressione burocratica sul loro statuto al quale malgrado tutto essi tengono, dal momento che con lo stato attuale della situazione rappresenta l’unico mezzo per poter continuare a vivere a Gerusalemme, e cioè a casa loro! Alla fragilità di questo statuto ibrido si aggiungono molti altri vincoli amministrativi da sopportare per numerose attività. Un semplice spostamento fuori città è fonte quasi sempre di noie e preoccupazioni che la costruzione del Muro ha ancor più aggravate poiché ormai i contatti con i palestinesi di Cisgiordania – dove si trovano necessariamente la famiglia, gli amici, i rapporti professionali … sono difficilissimi.
Impedire loro di costruire
Anche in questo caso si tratta di una politica che viene da lontano ! Dagli anni 1950, nei confronti degli arabi israeliani e dopo il 1967 nei confronti dei palestinesi di Cisgiordania. Da una parte, si è facilitata in tutti i modi possibili la creazione dell’habitat ebraico, al punto d’aver costruito, come abbiano visto, dodici colonie a Gerusalemme-Est dove vivono circa 200.000 persone (2005), dall’altra, l’habitat palestinese si scontra costantemente con ostacoli di ogni tipo, e alcuni di questi sono insormontabili. C’è infatti tutto un armamentario di regolamenti che avvolge i palestinesi in un mondo surreale e kafkiano al quale non hanno praticamente alcuna chance di sfuggire. Tra zone verdi e piani direttivi inesistenti, il loro percorso è praticamente senza sbocco, come lo mostra molto bene il rapporto dell’Unione europea: “Le autorità israeliane hanno attivato serie restrizioni sul rilascio di permessi di costruzione per i palestinesi di Gerusalemme-Est. Esse li rilasciano soltanto per località che hanno un piano direttivo relativo a certe zone. Ma la municipalità produce questi piani solo relativamente a zone di colonizzazione e non per le zone palestinesi. E così, ogni anno, i palestinesi ricevono meno di cento permessi per costruire per i quali hanno dovuto aspettare diversi anni”.
Bisogna precisare inoltre che le zone verdi possono evidentemente cambiare di statuto e un buon numero di palestinesi, ad esempio a Har Homa, hanno avuto la sorpresa di veder spesso una colonia costruita su terre “congelate” qualche anno prima per una simile destinazione. Secondo B’Tselem, le costruzioni palestinesi vengono autorizzate soltanto sul 7% di Gerusalemme-Est, e per la maggior parte delle volte in settori dove già esisteva un habitat palestinese. E anche in questi quartieri, rimane difficilissimo ingrandire la propria casa !
L’effetto perverso di questa politica ultra-restrittiva consiste nel fatto che i palestinesi che hanno, come tutti, esigenze impellenti di alloggio, finiscono per costruire senza permesso. A questo punto si trovano in difetto rispetto alla legalità israeliana che tuttavia non dovrebbe in ogni caso applicarsi, perché ai termini della Quarta convenzione di Ginevra del 1949, una potenza occupante non ha il diritto di estendere la propria giurisdizione ad un territorio occupato. Cresce dunque la fragilità, perché, in queste condizioni, le autorità israeliane hanno un facile pretesto per demolire queste costruzioni illegali. E così, ogni anno, decine di case private vengono distrutte, lasciando famiglie intere prostrate per aver visto brutalmente scomparire la loro casa per la quale avevano, in molti casi, investito quasi tutte le loro sostanze. Questa politica di distruzione dell’habitat palestinese illegale si è intensificata con la costruzione del Muro che schiaccia tutto ciò che trova sulla sua strada.
E, come fa notare il rapporto europeo da poco citato: “Queste demolizioni non obbediscono a nessun obiettivo apparente di sicurezza ma sono chiaramente legate all’espansione delle colonie … esse hanno conseguenze umanitarie catastrofiche e alimentano amarezza ed estremismo”.
A questo punto c’è da porsi una domanda essenziale: poiché i palestinesi non possono costruire per loro stessi, o molto poco, o fuori della legalità imposta dal governo, possono andare ad abitare nelle zone tenute dagli israeliani e in particolare nelle colonie ?
A priori, e fatte salve particolarissime eccezioni, i palestinesi non hanno alcuna voglia di andare ad abitare negli immobili degli insediamenti israeliani che percepiscono come vere enc1ave straniere che rappresentano a volte anche una minaccia per la loro vita quotidiana. L’ambiente culturale, sociale e soprattutto politico è tale che un simile approccio sembrerebbe inconcepibile. In queste condizioni ci si può aspettare rispetto a chi li circonda, che li evitino o che si sforzino di vivere ignorandoli ma non che cerchino di integrarsi. Ma, malgrado tutto, facciamo per un istante l’ipotesi di una famiglia palestinese che voglia affittare o comprare un appartamento in un quartiere ebraico. Sarebbe autorizzato a farlo ?
Sul piano del diritto positivo in vigore, non c’è, a quanto ne sappiamo, alcuna regola che vieti tale possibilità. Al contrario, è sicuro che i proprietari di beni immobiliari possono esigere un certo numero di condizioni per l’affitto o la vendita dei loro appartamenti, condizioni che i palestinesi non possono rispettare.
Per evitare facili polemiche su questo delicato argomento, la cosa migliore è quella di attingere alla giurisprudenza della Corte Suprema che ha avuto, almeno una volta, l’occasione di deliberare su questo problema. Essa è stata chiamata in causa da un richiedente che si era visto rifiutare il diritto di affittare un appartamento nel quartiere ebraico restaurato della città Vecchia, perché non ottemperava alle condizioni pretese dal venditore, e cioè di essere cittadino israeliano e di aver compiuto il servizio militare (o di esserne stato esentato o di aver servito in una organizzazione ebraica prima del 14 maggio 1948), o essere un nuovo immigrante ebreo residente in Israele. Dopo aver affrontato le questioni di competenza, illustrato le circostanze relative all’affare, trattato dei motivi sussidiari, la sentenza della Corte, redatta dal giudice Haim Cohen, va al punto essenziale, ovvero alla discriminazione determinata dalle condizioni imposte dal venditore, in questi termini:
“[…] Il richiedente riconosce di non essere cittadino israeliano, che non ha svolto servizio militare nelle Forze di Difesa d’Israele e di non essere un nuovo immigrante: è di nazionalità giordana e dichiara di aver sempre risieduto nella città Vecchia di Gerusalemme […] […] L’argomentazione principale del richiedente è che il difensore pratica una discriminazione illegale tra le persone […] in funzione della loro religione o della loro nazionalità poiché è pronto ad affittare degli appartamenti ad ebrei ma non a musulmani […] Io non sono convinto che la richiesta del difensore costituisca una discriminazione […] 1) in primo luogo, la nozione di cittadino israeliano include anche il non-ebreo: musulmano, druso o cristiano … quanto alla restrizione relativa al servizio militare si spiega con semplici considerazioni di sicurezza […] 2) in secondo luogo una discriminazione tra cittadini e non cittadini … non è necessariamente illegale … 3) in terzo luogo se il restauro del quartiere ebraico della città Vecchia è apparso indispensabile ciò è dovuto al fatto che la sua occupazione aveva portato all’espulsione degli ebrei, al saccheggio delle loro proprietà e alla distruzione delle loro case. E’ perciò nella natura delle cose che questo restauro comporti il ritorno all’antico splendore delle case ebraiche nella città Vecchia […] 4) in quarto luogo, nella misura in cui la discriminazione si fa nei confronti di un cittadino giordano che deve fedeltà al suo governo (come nel caso di specie) io considero questa discriminazione giustificata ed appropriata: noi deploriamo e protestiamo contro quello che i giordani hanno fatto contro di noi … ma non ci si può aspettare che noi apriamo con larghezza la strada per un loro ritorno ed insediamento, in particolare nel quartiere ebraico della città Vecchia. Una simile discriminazione è fondata e giustificat ad un tempo per considerazioni politiche e di sicurezza […[. L’appello è respinto.
Questo appello del 1978 presenta aspetti molto particolari perché attiene alla città vecchia di Gerusalemme, divisa in diversi quartieri da tradizioni antiche e complesse. Ma al di là di questa incontestabile specificità, se ne deduce una posizione di principio molto semplice: ognuno può stabilire le discriminazioni che vuole nella gestione delle sue proprietà restando comunque in un quadro di legalità. Secondo le parole del giudice Haim Cohen che ci commentava la sua decisione alcuni anni dopo:
“In una democrazia liberale, tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso … nessuno può impedirvi di fare quello che voi volete della vostra proprietà”.
Sul piano logico, questo ragionamento è totalmente inattaccabile ma, sul piano politico, porta ad una situazione contraria alle premesse su cui si basa. In nome del liberalismo, tutta una categoria di persone viene privata di una libertà elementare. E’ proprio per questo che il giudice Haim Cohen aggiungeva: “Noi dovremmo avere una legge per vietare questo tipo di discriminazioni … ma fino ad oggi non ce l’abbiamo”.
Ovviamente, ciò che è in discussione non sono soltanto le contraddizioni interne al liberalismo ma anche il suo utilizzo assai insidioso per appropriarsi di un territorio. Si ritorna così all’essenziale. La vera fonte di ogni discriminazione è rappresentata dal regime di occupazione. Se il problema di istallazione di palestinesi resta un’ipotesi formale, essa ci ha permesso di mettere l’accento sulla società duale attuata a Gerusalemme-Est come in Cisgiordania, nel rispetto e mediante il rispetto della legalità imposta dall’occupante, in violazione del diritto internazionale.
- La documentazione UE su Gerusalemme-Est
Per questo paragrafo, mi sono servito abbondantemente dell’introduzione di René Backmann al libro contenente la documentazione. Questo giornalista, redattore capo de le Nouvel Observateur, ha scritto un bellissimo libro (Un mur en Palestine) nel 2009. La sua dimestichezza con la documentazione, mi ha portato spesso a formulare, con le sue parole, le argomentazioni relative. Spesso!
Un diplomatico britannico, console generale del Regno Unito a Gerusalemme, ebbe per primo l’idea, all’inizio degli anni 2000, di redigere, con l’aiuto dei suoi colleghi rappresentanti i paesi dell’Unione europea, una specie di “stato delle cose” sistematico della situazione a Gerusalemme-Est. Per poter integrare i lavori dei diplomatici di stanza in Israele, con le informazioni raccolte da parte palestinese, fu richiesto un contributo dello stesso tipo ai capi dell’Ufficio dell’Unione europea a Ramallah, sede dell’Autorità palestinese.
Il metodo di lavoro adottato era assai informale. Gli scambi tra capi-missione portarono alla redazione di un progetto di testo, in inglese, affidato al diplomatico, che fece circolare il documento tra i suoi colleghi, raccolse proposte, suggerimenti, reticenze, opposizioni e produsse la versione finale, Dopo di che, questo documento validato dai rappresentanti dei 27 paesi dell’Unione, o almeno da coloro che si erano associati per redigerlo, venne trasmesso a Bruxelles.
Il rapporto del dicembre 2005 non entrava in particolari dettagli e conteneva relativamente pochi dati, ma presentava un quadro realistico della situazione sul terreno e dei rapporti di forza. E constatava soprattutto che la coniugazione delle politiche condotte da Israele nei diversi ambiti, riduceva le possibilità di raggiungere un accordo sullo statuto finale, che fosse accettabile dai palestinesi.
“Siamo convinti che la prosecuzione dell’annessione di Gerusalemme-Est derivi da una politica israeliana deliberata”, scrivevano gli estensori del documento. “Le misure prese da Israele rischiano anche – aggiungevano – di radicalizzare una popolazione palestinese di Gerusalemme-Est, fino a quel momento relativamente tranquilla”.
Si pensi all’uso che una diplomazia europea coerente, creativa, audace avrebbe potuto fare di un simile documento. Soprattutto, nel quadro di negoziati sullo statuto di partner preferenziale dell’Europa, sollecitato dal governo israeliano. Si pensi anche a quale sostegno avrebbe potuto avere il campo della pace israeliano, oggi moribondo, da un’Europa, che avesse continuato ad essere sempre risoluta nel difendere l’esistenza e la sicurezza d’Israele, ma altrettanto decisa nel rammentare ai vari governi israeliani che i palestinesi non erano i soli ad avere dei doveri… Si pensi infine quale sostegno avrebbe rappresentato per l’Autorità palestinese, un’Europa generosa, capace di dimostrare che la partigianeria in favore d’Israele di cui l’accusano gli islamici, era di fatto contraddetta da una denuncia argomentata degli atti e dei progetti israeliani. Chissà che un impegno più risoluto dell’Unione europea (e degli USA) non avrebbe potuto spingere Israele a decisioni meno unilaterali e l’Autorità palestinese a opzioni più creative, e avrebbe potuto evitare non la crescita di Hamas e la successiva vittoria elettorale nel gennaio 2006, ma certamente un rapporto più equilibrato con l’Anp.
Tre anni dopo, i capi-missione di stanza in Israele, inviano un nuovo rapporto a Bruxelles. Dopo tre anni, gli insegnamenti che si possono trarre dal confronto tra il rapporto del novembre 2005 e quello del dicembre 2008, lasciamo poche speranze. Sia sull’evoluzione della situazione sul terreno, così come emerge dalle analisi dei diplomatici, sia sull’impegno dell’Unione europea, sempre generosa nella sua strategia di cooperazione, ma disunita, e perciò senza voce sul piano diplomatico. Redatto in inglese, come il rapporto 2005 e nella sostanza più lungo del quello, il rapporto 2008 non rileva alcun segno, da parte israeliana, di una volontà di rianimare il processo di pace. Al contrario. In tutti gli ambiti passati in rivista dai diplomatici (colonizzazione, infrastrutture di trasporto, costruzione del muro, demolizioni di case, statuto dei residenti, atteggiamento di fronte alle istituzioni palestinesi, rispetto delle libertà religiose), il rapporto del 2008, rivela una regressione e una presa di distanza sempre più chiara rispetto agli obblighi assegnati dalla Road ma e ribaditi nel corso della conferenza di Annapo1is, nel novembre 2007. L’esempio più chiaro di questo atteggiamento israeliano è rappresentato dalla politica di colonizzazione del governo Olmert, continuata ed amplificata da Benyamin Netanyahou e dalla sua coalizione di estrema destra, al cui interno sono presenti (ed attivi!) i coloni. Un documento reso pubblico il 2 marzo 2009 dal movimento La Pace subito, conferma del resto che Israele ha intenzione di raddoppiare il numero dei coloni in Cisgiordania. I piani di colonizzazione del governo Netanyahou prevedono, secondo questo documento, la costruzione di 70.000 alloggi nei prossimi anni, di cui 5.700 nei quartieri annessi di Gerusalemme-Est.
Secondo il rapporto europeo del 2008, che si fonda sulle ricerche di La Pace subito e sui dati dell’Ufficio centrale di statistica israeliano, 190.000 dei 470.000 coloni censiti nel 2008 nei Territori palestinesi occupati vivono all’interno di Gerusalemme-Est e 96.000 nelle colonie che circondano Gerusalemme. E la costruzione di colonie, a Gerusalemme-Est e intorno a Gerusalemme, continua ad un ritmo elevato, contrariamente agli obblighi ai quali Israele sarebbe tenuto dal diritto internazionale e dalla Road map. Uno degli insegnamenti principali che fornisce su questo punto il confronto tra i due documenti è l’analisi dell’evoluzione del settore “E-l”. E-1, che sta per “Est-1”, è il nome dato dai pianificatori israeliani a una zona di colline sassose, di forte pendenza e con burroni, che si estende su un area di una decina di chilometri quadrati, a est di Gerusalemme tra la corona delle località palestinesi che raccoglie El-Azariyeh, At-Tor e lssawiya, e la colonia di Ma’ale Adoumim, la più popolosa della Cisgiordania, dove risiedono 31.000 israeliani. Questo settore “E-1” è destinato a prolungare verso ovest, Ma’ale Adoumim, e alla fine, ad attaccare il blocco di Ma’ale Adoumim, che copre una cinquantina di chilometri quadrati, a Gerusalemme. L’idea guida è quella di prolungare l’enclave di Gerusalemme fino ai confini della vallata del Giordano, la qual cosa comporterebbe la divisione in due della Cisgiordania e in particolare la strada tra due delle principali città palestinesi, Ramallah e Betlemme
Il rapporto del 2005 faceva già riferimento ai progetti degli urbanisti-colonizzatori israeliani per la zona “ E-1”. Alloggi per 815. 000 residenti, una zona di attività comprendente alberghi e un centro commerciale, un’università, un parco paesaggistico, un cimitero, una discarica e una costruzione destinata ad ospitare il quartier generale della polizia per la Cisgiordania. Quando il rapporto del 2005 era stato redatto, erano stati avviati soltanto pochi lavori di preparazione La cima di una collina era stata spianata ed era stata tracciata una pista per i camion e le macchine del cantiere. Ma, in seguito a fortissime pressioni diplomatiche, soprattutto americane, i lavori erano stati bloccati.
Tre anni dopo, la lettura del documento del dicembre 2008, mostra che le pressioni diplomatiche americane non erano risultate a lungo dissuasive. Infatti il quartier generale della polizia è stato completato ed è anche entrato in funzione nell’aprile 2008. Una parte dell’infrastruttura stradale del progetto « E-1 » è praticamente completata. I provvedimenti israeliani in corso nella zona di Ma’ale Adoumim-E-1, secondo gli estensori del rapporto, costituiscono una delle principali sfide al processo di pace israelo-palestinese. La continuazione della costruzione del muro e la realizzazione del piano E-1 determineranno una continuità territoriale israelianea tra il blocco di colonizzazione di Ma’ale Adoumim e Gerusalemme, dividendo in due la Cisgiordania e separando Gerusalemme-Est dal suo retroterra. La realizzazione di questo piano renderebbe impossibile lo sviluppo urbano ipotizzato dai palestinesi a Gerusalemme-Est, privando questa parte della città della maggior parte dei terreni disponibili per il suo sviluppo economico e demografico. Il 25 marzo 2009, mentre andavano avanti le trattative per la costituzione del governo Netanyahou, la radio dell’esercito israeliano ha rivelato che il capo del Likoud e il suo futuro ministre degli Esteri, Avigdor Lieberman, avevano concluso un accordo segreto che prevedeva la costruzione di 3.000 alloggi nella zona E-1
Dopo aver constatato e deplorato che i due “anelli” di colonie costruite intorno a Gerusalemme hanno continuato a svilupparsi, il rapporto 2008 evidenzia anche che il governo israeliano ha avviato la costruzione di una tramvia destinata a collegare le colonie di Pisgat Ze’ev (40.000 abitanti) e Neve Ya’acov (20.000 abitanti) al centro di Gerusalemme, includendo così nello schema urbanistico della città l’annessione di fatto delle terre della Cisgiordania sulle quali le colonie sono costruite. Il rapporto europeo non ne fa cenno, ma due imprese francesi, con l’avallo del governo francese, sono partner di questo progetto israeliano che se ne infischia delle Convenzioni di Ginevra, che definiscono i diritti e i doveri degli “Stati occupanti”. Nel capitolo sulle infrastrutture di trasporto, il rapporto 2008 parla anche della costruzione, ad est di Gerusalemme, di una strada di aggiramento che dovrebbe, alla fine, collegare, aggirando il muro di separazione e passando sotto la zona “E-1” con un tunnel, le località palestinesi situate a nord e a sud di Gerusalemme. L’obiettivo è, ancora una volta, chiarissimo e cioè quello di permettere in futuro al governo israeliano, di fronte alla comunità internazionale, di aver conservato la “continuità territoriale” della Cisgiordania. Pur avendo riunito Ma’ale Adoumim a Gerusalemme…
Dal momento che la lunghezza dei vari tronconi del muro di separazione in attività si è raddoppiata in tre anni, passando da 200 a 400 chilometri, il rapporto 2008, esamina più in dettaglio la realizzazione, e le conseguenze, di quest’altro grande progetto israeliano. Per constatare in particolare che quando il muro sarà finito (e la sua lunghezza sarà allora di 725 chilometri!), di fatto annetterà ben 80 colonie, e tra queste, anche le 12 situate alla periferia di Gerusalemme-Est. E così, i 385.000 israeliani che vivono nelle colonie a ovest, e cioè dalla parte “israeliana” del muro. Nella sola regione di Gerusalemme, il 3,9 % del territorio palestinese è già stato annesso di fatto dal tracciato del muro che “taglia” dalla Cisgiordania più di 280.000 palestinesi, tra i quali tutti quelli di Gerusalemme-Est. In aggiunta alla moltiplicazione di checkpoints e all’obbligo di ottenere un permesso per entrare a Gerusalemme, l’esistenza del muro ha trasformato la vita quotidiana dei palestinesi di Cisgiordania in un confronto permanente con la burocrazia poliziesca e militare israeliana, che obbliga ad esempio coloro che risiedono nelle regioni comprese tra il muro e la Linea Verde (si tratterà di circa 35.000 persone quando i lavori finiranno), a sollecitare un’autorizzazione di residenza per continuare a vivere a casa loro. Dal 2000, constatano gli autori del rapporto 2008, il numero degli studenti palestinesil dell’Università Al Quds, a Beit Hanina, è calato del 70 %. Un numero sempre decrescente di fedeli palestinesi cristiani e musulmani ha accesso ai Luoghi santi a Gerusalemme. Anche il tradizionale vino da messa di Betlemme, prodotto da 125 anni da un ordine cattolico, non è più autorizzato a superare il muro perché costituirebbe “un rischio per la sicurezza”.
La lezione essenziale della realtà, così come esiste sul terreno e come viene descritta da questi due documenti, è brutalmente semplice: tutto si svolge come se lo Stato d’Israele e i suoi governi che si succedono, lungi dall’avere per obiettivo di riavviare il processo di pace avviato dagli Accordi di Oslo o dalla Road map, abbiano deciso d’imporre, dall’inizio degli anni 2000, in particolare con la costruzione del muro e della barriera di separazione, e attraverso una molteplicità di iniziative, spesso spettacolari, altre volte appena percepibili se viste da lontano, una soluzione unilaterale del problema palestinese.
Questa soluzione si basa su di una concezione strategica e politica totalmente nuova: il muro e la barriera di protezione saranno domani, la frontiera tra il futuro Stato palestinese e lo Stato d’Israele. In altre parole, “il compromesso storico” accettato da Yasser Arafat, secondo il quale l’Organizzazione di liberazione della Palestina (OLP) accettava di costruire il suo Stato sulla Cisgiordania e la striscia di Gaza e cioè sul 22 % del territorio della Palestina mandataria non varrebbe più.
E’ sulla striscia di Gaza ed una parte soltanto della Cisgiordania, che questo Stato, sempre meno vivibile, con il procedere delle amputazioni, dovrebbe essere costruito. Sempre che venga costruito. Le colonie israeliane, almeno le più importanti di esse, non saranno né distrutte né consegnate all’Autorità palestinese. Esse costituiranno altrettante enclave strategiche collegate direttamente a Israele con una specifica rete stradale, conficcate come cunei nel cuore dello Stato palestinese da creare.
Propaganda palestinese? Estrapolazione azzardata? Paranoia militante? Purtroppo no ! Nell’agosto 2007, non è un rappresentante dell’OLP o dell’Autorità palestinese che ha fatto questa rivelazione a René Backmann, nel corso di una trasmissione di France Inter, ma l’ex ambasciatore d’Israele in Francia, Nissim Zvili. E un anno più tardi, come lo evidenzia il rapporto dei diplomatici, sarà il vice-primo ministro israeliano Haim Ramon, che dichiarerà: “La barriera è la nuova frontiera orientale d’Israele”. Da anni, ufficiali israeliani ripetono che la Linea Verde non è che una linea armistiziale, cosa vera del resto, che non è perciò sacra, e che nel quadro di un negoziato sullo statuto finale, scambi di territori potrebbero essere conclusi con i palestinesi.
Alla ricerca di soluzioni accettabili per la comunità internazionale, per ridurre la proporzione di non-ebrei tra la popolazione israeliana senza far ricorso alla pulizia etnica, (diffusa anche in altre regioni del mondo sia ben chiaro!), alcuni politici israeliani avevano anche ipotizzato di cedere ai palestinesi, come contropartita delle enclave costituite dalle nuove colonie, regioni d’Israele abitate da arabi israeliani. Va detto che questa ipotesi, che non teneva in nessun conto la volontà dei principali interessati, i palestinesi d’Israele, non era stata presa molto sul serio all’inizio. L’entrata nel governo israeliano dell’estremista Avigdor Lieberman, che sogna un Israele liberatosi del 20% dei suoi abitanti (i palestinesi), potrebbe provocare il ritorno di questo mercanteggiamento nel dibattito politico. Quello che i palestinesi si dichiaravano disposti a prendere in considerazione, nel quadro di un negoziato globale, era il principio di scambi limitati di territori di natura comparabile e di superficie equivalente, per permettere ad Israele di conservare le colonie vicine alla Linea Verde, e all’Autorità palestinese di ottenere terre destinate soprattutto a favorire una via di comunicazione tra la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Ma le tra modeste rettifiche di frontiera, mutuamente accettate e l’annessione autoritaria da parte israeliana dal 3 al 12 % del territorio palestinese, ce ne passa!
O piuttosto ce ne passava ! Forti della protezione di George W. Bush e dei suoi consiglieri likudnik, evangelisti e neocons, i dirigenti israeliani hanno creato una nuova dottrina, che volta le spalle risolutamente allo spirito di Oslo, i cui pilastri sono costituiti dalla priorità assegnata alla forza, al rifiuto del dialogo, alla identificazione della rivendicazione nazionale palestinese, (anche in assenza di violenza) al terrorismo e alla politica dei fatti compiuti. Dottrina che ha ricevuto la benedizione ed il sostegno di George W. Bush nell’aprile del 2004. In una lettera al Primo ministro del tempo, Ariel Sharon, il cui testo era stato solennemente approvato dal Senato (95 voti contro 3) e dalla Camera dei Rappresentanti (407 voti contro 9) il presidente americano sottolinea che Israele, “Stato ebraico”, deve avere frontiere sicure e riconosciute, risultato dei negoziati tra le parti, basato sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ma, aggiunge George W. Bush, che “alla luce delle nuove realtà sul terreno che che comprendono i principali centri della popolazione palestinese esistente, non è realistico sperare che i risultati dei negoziati sullo statuto finale costituiscano un ritorno integrale alla linea armistiziale del 1949; tutti i tentativi precedenti per negoziare una soluzione con due Stati portano a questa conclusione”. In altri termini: le colonie più popolate e i l5 blocchi principali di colonizzazione costituiscono delle “nuove realtà sul terreno” che restano fuori dal campo del negoziato.
Da questo punto di vista, le discussioni che hanno preceduto la conferenza di Annapolis, il 27 settembre 2007, hanno fornito indicazioni eloquenti. Sulla questione centrale “dei termini di riferimento”, i palestinesi hanno ripetuto che intendevano attenersi alle basi fissate durante gli incontri di Oslo nel 1993, arricchite e precisate negli incontri successivi. Non soltanto le risoluzioni 242 e 338 dell’ONU dunque, ma anche parte delle conclusioni di Camp David (luglio 2000) e di Taba (gennaio 2001), oltre all’iniziativa di pace araba di Beirut (2002) e alla procedura definita dalla Road map di George W. Bush (2003).
Fin dall’ottobre 2007, un mese prima che si tenesse la conferenza, il presidente dell’Autorità palestinese, Mahmoud Abbas, si era premurato di precisare, in un’intervista diffusa dalla televisione palestinese che il futuro Stato di Palestina avrebbe dovuto comprendere integralmente la striscia di Gaza e la Cisgiordania (6205 chilometri quadrati). Ma per la parte israeliana, e con l’assenso americano, le basi del negoziato erano decisamente differenti. Un diplomatico israeliano importante, una settimana prima della apertura della riunione di Annapolis si espresse così: “Oggi, non è più questione di Camp David, di Taba o dei parametri di Clinton del dicembre 2000. Le circostanze e gli interlocutori non sono più gli stessi. Si ricomincia da zero o quasi”. A parte le inaggirabili risoluzioni 242 e 338, sempre ritualmente citate ma mai rispettate e la Road map, il cui calendario era da tempo scaduto, ma i cui meccanismi erano ancora accettati dalle due parti, la delegazione israeliana aveva messo al centro delle sue argomentazioni la lettera indirizzata da George W. Bush a Ariel Sharon nell’aprile 2004.
Nel settembre 2008, un personaggio della società politico-militaire israeliana, il generale Giora Eiland, che aveva presieduto il Consiglio nazionale di sicurezza dal 2004 al 2006, dopo aver servito per trentatre anni nell’esercito, in particolare al comando del dipartimento di pianificazione strategica, pubblica uno studio di 35 pagine nel quale si pronuncia chiaramente in favore di una frontiera completata da una barriera di sicurezza. E la nuova frontiera che egli propone nei due scenari studiati annette, come quella che è in costruzione, la maggior parte dei blocchi di colonizzazione della Cisgiordania. In contropartita, il generale Eiland propone diverse possibilità di scambio di territori, compreso un baratto triangolare Israele-Palestina-Egitto. Per Giora Eiland, la diffidenza, se non addirittura l’ostilità tra israeliani e palestinesi è tale che ogni negoziato sullo statuto finale deve prevedere l’esistenza di una barriera di sicurezza. Dopo il fallimento del processo di Oslo, la seconda Intifada e l’emersione potente di Hamas, l’opinione pubblica israeliana, sostiene il generale, è sempre meno favorevole al principio “la terra in cambio della pace”. Ed è quello che conferma un’inchiesta dell’Istituto Nazionale degli Studi Strategici (INSS) di Tel Aviv secondo il quale la percentuale della popolazione ebraica di Israele favorevole a questo principio è scesa tra il 1977 e il 2007 dal 56 % al 28 %.
Altri strateghi vanno ancora più lontano. In un documento reso pubblico nel 2007, tre ex-ambasciatori e un generale, direttore dell’Istituto di Difesa nazionale valutano che la frontiera costituita dall’insieme muro-barriera non sia sufficiente. Una frontiera difendibile dovrebbe comprendere, secondo loro, una linea di separazione spinta verso l’est, fino alle alture e alle “regioni vitali dal punto di vista militare”. Questa frontiera dovrebbe conservare a Israele il controllo della vallata del Giordano, comportare l’allargamento del corridoio Gerusalemme-Tel Aviv e la creazione di una zona di difesa di Gerusalemme. Questi progetti attirano poco l’attenzione, se non tra i palestinesi. Ma, a parte i palestinesi e i difensori dei diritti umani, chi se ne preoccupa? Di fatto, i dirigenti israeliani, incoraggiati dalla loro impunità quando ignorano il diritto internazionale, le risoluzioni dell’ONU e anche i loro stessi impegni, sono convinti che tutto ciò che utile alla sicurezza d’Israele sia loro permesso. Ed è proprio in virtù di tale convinzione che lo Stato Maggiore e il governo israeliano hanno scatenato nel 2002 l’operazione “Baluardo”, nel dicembre 2008 l’operazione “Piombo fuso”, contro la striscia di Gaza, nel corso della quale, in tre settimane, 1.330 palestinesi, per più della metà civili, e 13 israeliani, di cui 10 soldati, sono stati uccisi. Ufficialmente, si trattava di porre fine ai tiri di razzi e di mortai sul sud d’Israele, dalla striscia di Gaza, sotto il controllo di Hamas. L’esame attento della cronologia dei fatti ha mostrato che nella rottura del cessate-il-fuoco fissato nel giugno 2008, le responsabilità non erano certo del campo palestinese. Ma questo piccolo dettaglio è scomparso, seppellito dalla riprovazione che provocano in Europa e negli Stati Uniti le tesi ed i metodi di Hamas. La divisione tra i palestinesi, gli scontri tra al-Fatah e Hamas, l’esistenza di due entità territoriali palestinesi distinte, una, la striscia di Gaza (386 chilometri quadrati), sotto il controllo di Hamas, l’altra, la Cisgiordania (venti volte più grande della striscia!), sotto il controllo di al-Fatah, così come il rifiuto di una parte della comunità internazionale, tra cui l’Unione europea, d’intrattenere relazioni con Hamas, hanno svolto un ruolo importante nel fornire ad Israele argomentazioni che le hanno permesso di mettere in atto e di difendere le sue scelte unilaterali.
Nella visione mediatica del conflitto, estremamente approssimativa, la responsabilità israeliana, la scelta deliberata della forza contro il negoziato è stata eclissata dalla diffidenza, direi l’ostilità che suscita Hamas, di cui non si discutono mai le spesso ragionevoli argomentazioni, e di cui si dimentica di essere il legittimo rappresentante del popolo palestinese, avendo stravinto le elezioni nel 2006. Si sperava nell’arrivo al potere di Barack Obama, ma la canzone non è cambiata e nemmeno i ritornelli! Ci si aspettava uno sguardo americano più critico sulla politica israeliana, ma nulla di tutto questo è successo. Un solo esempio. Rispondendo a Benyamin Netanyahou, che ripeteva, appena eletto, il suo rifiuto circa la creazione di uno Stato palestinese, Barack Obama ha ricordato, subito imitato dal Segretario di Stato Hillary Clinton, che la soluzione per gli Stati Uniti si fonda sull’esistenza di due Stati. E’ stato tirato in ballo George Mitchell come inviato speciale del presidente in Medio Oriente, ma dopo due anni tutto è praticamente fermo, se si eccettua la colonizzazione! E l’Europa tace. I due documenti dei capi delle missioni diplomatiche a Gerusalemme e a Ramallah potevano far sperare forse in una riflessione. L’Europa ufficiale ha preferito tenerli nel cassetto.
- L’insabbiamento della documentazione UE
Torniamo al 2005, quando i diplomatici di stanza in Israele spedirono il primo rapporto a Bruxelles. Qual era il loro intento? Almeno una parte dei suoi promotori speravano che questo “Rapporto su Gerusalemme-Est” avrebbe contribuito a tenere vivo un dibattito, in seno alla Commissione, o meglio ancora, nel Parlamento europeo, che portasse alla definizione di una politica comune in Medio Oriente. Secondo loro, in ogni caso, questo lavoro comune non doveva restare confidenziale. Una nobile ambizione democratica. Ma questi ottimisti dovettero ben presto ricredersi! Con sorpresa e anche delusione per alcuni di loro, fin dalla trasmissione a Bruxelles del rapporto del novembre 2005, Javier Solana, responsabile per la politica estera e della sicurezza comune, condusse l’offensiva contro la pubblicazione ufficiale del documento. La sua motivazione, secondo un diplomatico a conoscenza del dossier, era semplice, dal momento che il testo non raccoglieva un larghissimo consenso nelle capitali europee per essere pubblicato e soprattutto utilizzato come documento di lavoro a Bruxelles e a Strasburgo.
La Germania, che sistematicamente si rifiuta, per ragioni storiche evidenti, a formulare critiche troppo severe nei confronti d’Israele, ma anche, l’Italia e i Paesi Bassi in particolare, rifiutarono di farsi carico delle considerazioni e delle conclusioni del rapporto. Anche il ministro degli Esteri britannico, Jack Straw, nel corso di una riunione del Consiglio europeo, di cui stava assumendo la presidenza, ritenne opportuno non far proprio il documento e quindi di non pubblicarlo, per non interferire, questa la motivazione ufficiale, con il processo elettorale israeliano, Erano infatti previste elezioni legislative anticipate per la fine del mese di marzo 2006 in Israele. Si trattava di individuare il successore di Ariel Sharon, in coma dopo un ictus cerebrale, a gennaio. Le elezioni furono vinte, di pochissimo, dal partito Kadima il cui leader, Ehoud Olmert, che aveva assunto l’interim di Sharon, diventò Primo ministro.
Ma il documento non rimase a lungo “confidenziale”. Un quotidiano britannico l’aveva nel frattempo pubblicato sul suo sito Internet. E questa rivelazione aveva suscitato, oltre che una certa irritazione da parte israeliana e una visibile soddisfazione da parte dei palestinesi, diverse domande in Europa, e oltre, tra gli osservatori avvertiti della situazione in Medio Oriente. Per gli esperti del problema, giornalisti, diplomatici, membri delle ONG, il rapporto conteneva poche novità, se si eccettua un particolare importante: il documento dimostrava con chiarezza che le cancellerie europee disponevano di buone informazioni sulla realtà della vita quotidiana a Gerusalemme-Est e in Cisgiordania, sulla colonizzazione, sulle discriminazioni, sulla costruzione del muro di separazione, sulle demolizioni di case palestinesi e sul logorio burocratico dei palestinesi. E non era poca cosa!
Di fatto, questo rapporto dovuto alle osservazioni di testimoni tenuti, per le loro funzioni, ad un uso misurato delle parole, confermava buona parte delle critiche fatte ad Israele dall’Autorità palestinese. Dimostrava, ad esempio, e nel modo più chiaro possibile, che la parte palestinese non era la sola, e non ci voleva molto a capirlo, a non rispettare gli impegni contenuti nella Road map pubblicata nell’aprile 2003, sotto il patrocinio del “Quartetto” (Nazioni unite, Stati Uniti, Unione europea, Russia). Nelle disposizioni previste nella “Fase 1” della Road map, la parte palestinese doveva impegnarsi a porre termine alle violenze e al terrorismo. Alla parte israeliana veniva chiesto di mettere fine alle espulsioni, agli attacchi contro i civili, alle confische e/o demolizioni di case e di proprietà palestinesi, sia che si trattasse di misure punitive sia che fossero decisioni destinate favorire costruzioni israeliane. Il governo israeliano doveva anche “congelare” lo sviluppo delle colonie nei territori occupati e smantellare tutte le colonie “selvagge” create dopo marzo 2001.
Certamente l’Autorità palestinese, i cui servizi di sicurezza erano stati in gran parte distrutti dall’esercito israeliano durante l’“Operazione Baluardo” del marzo 2002, non era stata capace di porre termine alla violenza e al terrorismo. Ma il governo israeliano, che era perfettamente padrone delle sue scelte e dei suoi atti, non aveva rispettato nessuno dei suoi impegni della Road map. Quando il rapporto dei diplomatici era stato redatto, il muro di separazione costruito in assoluta illegalità all’interno della Cisgiordania, superava già i 220 chilometri di lunghezza. Quanto alla colonizzazione, non soltanto non era stata congelata ma, al contrario, il suo ritmo di crescita superava di gran lunga il tasso di crescita naturale della popolazione israeliana
Il rapporto 2008, che era destinato in principio al Dipartimento delle relazioni esterne dell’Unione europea, e cioè ai servizi di Javier Solana, resta ancora, un “documento di lavoro confidenziale” dallo statuto incerto. All’inizio, alcuni Stati-membri, fra i quali la Francia, il Regno Unito e la Spagna, non erano contrari a dare a questo documento maggiore visibilità, soprattutto all’indomani del viaggio di Hillary Clinton a Gerusalemme, dove aveva usato con i dirigenti israeliani un linguaggio almeno altrettanto critico rispetto a quello del documento. Ma una volta ancora, in mancanza di consenso, questo documento non ha potuto essere attribuito ai Ventisette e la sua pubblicazione “ufficiale” è stata respinta. Al Quai d’Orsay, il ministero degli Esteri francese, coloro che conoscono il dossier considerano il rapporto come una “banca dati” seria, destinata a valutare l’impegno delle due parti rispetto alla Road map, e eventualmente a nutrire la discussione a Bruxelles per la definizione della politica dell’Unione europea.
Ufficialmente, questa politica si fonda sui principi enunciati dalla risoluzione 242 dell’ONU che chiede il “ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati”. Perché non ricordare con fermezza questa esigenza al governo israeliano? Perché non ricordargli anche che l’Europa ha sottoscritto le raccomandazioni contenute nel giudizio della Corte Internazionale di giustizia che dichiarava illegale la costruzione del muro? In base a quali precauzioni, a quali reticenze, l’Europa deve continuare a essere meno lucida e meno coraggiosa del giornalista israeliano Akiva Eldar che nel luglio 2006 scriveva su Haaretz: “Nelle nostre relazioni con i nostri vicini, la forza è il problema, non la soluzione …”?
- Conclusioni
Nelle mie intenzioni, esisteva ancora un paragrafo, dal titolo assai esplicito: “Le tappe del terrorismo di Stato israeliano” ma ho ritenuto di fermarmi qui, per non allontanare il lettore da quello che ho ritenuto essere l’obiettivo essenziale di questo scritto e cioè il processo di espropriazione del popolo palestinese nel punto nevralgico della Palestina, Gerusalemme. Ci sarà modo di riprendere l’argomento e concentrare l’attenzione sul terrorismo di Stato israeliano.
Dedicherò quindi quest’ultimo paragrafo, quello conclusivo, alla ricostruzione, soltanto per l’anno in corso il 2010, del balletto israelo-statunitense, con accompagnamento palestinese, sul “processo di pace”. Mi servirò della collezione di la Repubblica, dal 16 marzo al 9 novembre, giorno in cui spero di porre fine anche al mio lavoro su Gerusalemme-Est. Balletto che si ripete ormai da più di sedici anni!
Partiamo dalla fine. Dal 9 novembre.
“Nuovi insediamenti a Gerusalemme ‘Così Israele distrugge i negoziati’. Sì a 1.300 alloggi mentre Netanyahu è negli USA. Protestano i palestinesi”.
Questo il lungo titolo a pagina 19. Di seguito riportiamo l’articolo di Fabio Sciuto, inviato di la Repubblica a Gerusalemme.
“Con un tempismo destinato a mettere ancora più in chiaro qual è lo stato delle relazioni fra Stati Uniti e Israele, ieri la commissione per l’edilizia del ministero dell’Interno ha pubblicato il bando per la costruzione di mille e trecento nuove abitazioni a Gerusalemme-Est, contravvenendo alla esplicita richiesta di Washington di congelare i nuovi insediamenti per favorire il riavvio dei negoziati di pace con l’ANP. L’annuncio è venuto proprio mentre il premier israeliano Netanyahu è in visita in America ed è stato subito bollato come ‘molto deludente’ dal dipartimento di Stato USA. Immediata anche la reazione dei palestinesi che, per bocca del negoziatore Saeb Erekat, hanno accusato Netanyahu di voler ‘distruggere’ i colloqui.
La politica coloniale israeliana rappresenta, al momento, la principale ragione dello stop forzato ai negoziati di pace tra israeliani e palestinesi che non riprenderanno la trattativa se prima non ci sarà il blocco delle nuove costruzioni. E lo stallo del negoziato – dopo tante energie spese – è frustrante per l’Amministrazione Obama. Il programma approvato ieri dal comitato per l’edilizia della municipalità di Gerusalemme prevede la costruzione di 978 appartamenti a Har Homa e di altre 320 unità a Ramot, quartiere ebraico sempre nel settore est della città.
Nei primi mesi dell’anno, la pubblicazione di un altro piano per la costruzione di 1.600 alloggi a Gerusalemme-Est, avvenne durante una visita del vice presidente Usa Joe Biden che aveva l’intento di ricucire i tesi rapporti fra Israele e Stati Uniti per il rifiuto israeliano di attuare una moratoria degli insediamenti. Il fatto fu giudicato uno sgarbo diplomatico e causò una seria crisi fra i due paesi. Anche questa volta la pubblicazione del piano ha di fatto coinciso con l’incontro che Netanyahu ha avuto domenica sera con Biden a New Orleans. Incontro nel quale il premier è tornato a incalzare l’Amministrazione Usa per una opposizione più dura sull’Iran e il suo programma nucleare. Per Netanyahu ‘l’unico modo per assicurarsi che l’Iran non ottenga armi nucleari è una credibile minaccia militare’, affermazione sulla quale Biden ha glissato limitandosi a sottolineare che le attuali sanzioni contro Teheran hanno un ‘impatto misurabile’, diversamente da un’azione militare che potrebbe avere esiti devastanti in tutto il Medio Oriente”.
Dall’articolo di Fabio Sciuto emerge un dialogo fra sordi, con un premier israeliano all’attacco di un Obama in forte crisi di credibilità e battuto alle elezioni di medio termine. Torniamo ora al 15 marzo e vediamo i titoli relativi all’annuncio dei 1.600 alloggi cui accenna Sciuto, durante la visita di Biden.
15 marzo. “Colonie, contro Israele la rabbia Usa. Obama furioso, la Clinton attacca Netanyahu: ci hai offeso. Il premier si scusa”.
E il giorno dopo?
“Netanyahu: ‘Continuiamo a costruire’ Nuova sfida a Obama. L’ambasciatore in Usa: ‘Crisi di proporzioni storiche’”.
L’articolo comincia con la dichiarazione fatta da Netanyahu alla Knesset: “Le costruzioni a Gerusalemme-Est continueranno nella stessa maniera in cui sono andate avanti negli ultimi 42 anni”. Più chiaro di così!
17 marzo. Paginone centrale e due titoli.
“Colonie, l’ira palestinese, barricate contro la polizia. A Gerusalemme scontri con gli israeliani: arresti e feriti”
“Il Pentagono: l’intransigenza di Netanyahu mina i rapporti tra l’America e il mondo arabo. L’irritazione della Casa Bianca. Clinton: ‘Israele dia un segnale’”
20 marzo. “‘Stato palestinese in due anni’. Usa e Russia avvertono Israele. Martedì alla Casa Bianca vertice Obama-Netanyahu”
Da Gerusalemme, Alberto Stabile, parla di pace fatta fra Obama e Netanyahu, almeno secondo Fox New. Netanyahu e la Clinton si sono telefonati e mercanteggiando un po’ l’Amministrazione Obama finisce con l’accettare un pacchetto di misure reciproche, questa la proposta di Netanyahu, per ristabilire la fiducia con i palestinesi. Senza nessun impegno specifico e, soprattutto, nessun cambiamento di programma sulle costruzioni!
24 marzo. “Netanyahu avverte la Casa Bianca: ‘Negoziato fermo per un anno’. Su Gerusalemme non trattiamo. E parte un nuovo insediamento”
L’articolo di Angelo Aquaro, inviato a New York, comincia così: “Se i palestinesi non rinunceranno alla richiesta di fermare gli insediamenti, i colloqui di pace potrebbero slittare di un anno. Non poteva cominciare in modo peggiore l’atteso incontro alla Casa Bianca, novanta minuti faccia a faccia, tra Barak Obama e Bibi Netanyahu. […] ‘Non dobbiamo farci intrappolare da una richiesta illogica e irragionevole’”. Dichiara Bibi! E l’articolo continua: “Uno schiaffo dopo l’altro. Anche perché quella ‘richiesta illogica e irragionevole’ viene pure dagli Usa, che con tutto il Quartetto (Ue, Onu, Russia e Stati Uniti) hanno chiesto il blocco degli insediamenti”. E mentre i due sono a cena, “da Israele è arrivato l’affronto; il via libera alla costruzione di complesso di 29 nuove abitazioni che sostituiranno un vecchio albergo palestinese sempre a Gerusalemme-Est. Già la sera prima, durante il discorso all’Aipac, la lobby ebraica americana, Bibi aveva rintuzzato la richiesta di stop fatta davanti alla stessa platea da Hillary Clinton, che aveva invitato Israele a fare ‘scelte difficili ma necessarie per la pace’. ‘Gerusalemme non è una colonia, è la capitale d’Israele’ aveva tuonato il leader. ‘Il popolo ebraico costruì Gerusalemme 3000 anni fa e continua a farlo ora’”. E mi pare che basti. Altro che disgelo!
Si arriva così al tragico 31 maggio, quando la flottiglia Freedom, che recava aiuti umanitari ai palestinesi, rinchiusi in quel carcere a cielo aperto che è Gaza, viene assaltata dalla flotta israeliana. Risultato: nove morti tra i passeggeri della Mavi Marmara, la nave turca che guidava il convoglio.
Un paginone! E una doppia serie di titoli.
“Il blitz. Israele assalta le navi della pace dirette a Gaza con gli aiuti nove morti, oltre trenta feriti. I settecento attivisti portati a terra e arrestati”
“Paura di una nuova Intifada. Netanyahu nella tempesta, salta il vertice alla Casa Bianca. La stampa: ‘Rischiamo l’isolamento’”.
Netanyahu è in viaggio per il Canada ed esita pure a tornare indietro. Diamo la parola a la Repubblica:
“Inversione di marcia più che giustificata, perché stavolta Israele rischia di pagare un prezzo molto alto. Le tragiche conseguenze dell’arrembaggio notturno hanno lasciato interdetti persino quei paesi europei che intrattengono rapporti amichevoli con Israele come l’Italia e la Germania i quali stavolta non hanno potuto sottacere la protesta.
Sarà difficile a questi paesi opporsi alla linea di condotta tracciata dall’alto Rappresentante dell’Ue per la Politica estera e la Difesa, Khateryne Ashton, che ha subito evocato l’esigenza di un’inchiesta internazionale(d’accordo in questo con il Segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon), e la necessità di garantire al milione e mezzo di palestinesi che vivono a Gaza condizioni di vita più umane, spezzando il cordone sanitario che da quasi tre anni soffoca la Striscia.
Persino al di là delle previsioni degli organizzatori della flottiglia anti-blocco, i fatti di ieri notte potrebbero segnare una svolta nell’atteggiamento internazionale che finora ha garantito appoggio all’embargo messo in atto da Israele contro la popolazione di Gaza. Soprattutto dopo aver constatato che nessuno dei due obiettivi del blocco (la rivolta della popolazione contro Hamas e la riduzione della minaccia terroristica portata dalle milizie islamiche) può dirsi realizzata.
Dunque, per poter continuare a mantenere sbarrati i valichi di Gaza Israele avrà più che mai bisogno degli Stati Uniti, ma basta leggere il cauto comunicato emesso dalla Casa Bianca per rendersi conto che il tempo delle cambiali in bianco è scaduto”.
Ma i giorni successivi stempereranno pian piano tutto, fino ad arrivare al 21 giugno, quando verrà fuori la notizia che gli Stati Uniti si ritengono soddisfatti. A luglio poi tornerà di nuovo l’entusiasmo, con Netanyahu che parla di Abu Mazen come suo partner, con Obama che si sbilancia addirittura sui tempi!
Il 22 agosto, a sorpresa,
Obama rilancia il processo di pace. Negoziati diretti Israele – palestinesi. A settembre gli incontri diretti dei due leader alla Casa Bianca. Il negoziatore palestinese Erekat: “Andremo ma non c’è lo stop alle colonie”. “Siamo disposti a trattare”. Netanyahu e Abu Mazen ‘costretti’ ad accettare l’invito.
L’articolo da New York di Federico Rampini si apre con notevole enfasi, se non con toni trionfalistici. “Barak Obama si mette in gioco sul terreno minatodel Medio Oriente. L’America rilancia il dialogo di pace tra Israele e Palestina, senza precondizioni, con scadenze ravvicinate: il 2 settembre a Washington il primo giro di contatti diretti e l’obiettivo di raggiungere l’accordo ‘entro un anno’. Cioè un risultato da incassare entro il primo mandato di Obama, facendo così della pace israelo-palestinese un elemento di bilancio di questa presidenza.
E’ un rischio che altri presidenti hanno preferito non correre, viste le delusioni di precedenti tentativi di mediazione. Questa Amministrazione ci riprova, pur avendo scarse garanzie, ma con grandi ambizioni. Il segretario di Stato Hillary Clinton ha annunciato ieri che i negoziati avranno per scopo quello di ‘risolvere tutte le questioni relative allo status finale’ di Israele e Palestina.
2 settembre. Netanyahu: “Abu Mazen partner di pace”. Obama: “possiamo farcela in un anno. Ma il premier israeliano non s’impegna sullo stop alle colonie. “Cediamo Gerusalemme-Est all’Anp”. Intervista-shock di Barak: “Un regime speciale per la Città Vecchia.
L’articolo di Angelo Aquaro comincia così: “Possiamo farcela in un anno: già troppo sangue è stato versato. Israeliani e palestinesi non devono lasciarsi sfuggire questa opportunità”. Barak Obama vede la pace possibile e rilancia il sogno di un nuovo Medio Oriente”.
Dunque a settembre ci si prepara agli incontri diretti, viene fissato un nuovo incontro per il 16, ma poi …
A ottobre, sempre peggio. Di novembre abbiamo già parlato.
Di seguito i titoli significativi dal 2 giugno al 16 ottobre.
2 giugno. La crisi. Israele sfida l’Onu: “Ipocriti”. La Nato: “Liberate i militanti”.
3 giugno. Netanyahu difende il blitz: “Era una flottiglia di terroristi”. L’Onu: un’inchiesta sulla strage. L’Italia vota no con Usa e Olanda. Abu Mazen: “Israele ha commesso un crimine”.
4 giugno. Il Vaticano a Israele: “Via il blocco di Gaza”.
7 giugno. Il Papa: “Occupazione ingiusta. Israele destabilizza la regione.
18 giugno. Gaza. Israele allenta l’embargo ma il blocco navale resta attivo.
21 giugno. La svolta d’Israele su Gaza: “Via libera a tutti i beni civili. Resta solo il blocco delle armi (!?)”. Gli Usa: siamo soddisfatti.
Nello stesso giorno Netanyahu incontra Blair rappresentante del Quartetto. Sempre gli stessi personaggi! E si preannuncia un incontro con Obama per il 6 luglio.
6 luglio. L’Amministrazione spera in concessioni che facciano tornare i palestinesi al negoziato. Netanyahu da Obama per ricucire. Alla Casa Bianca un vertice per superare i contrasti. “O le scuse o la rottura dei rapporti”. Ultimatum della Turchia a Israele. La replica: “Non le avrete”. Cieli negati ai voli militari.
7 luglio. Obama preme su Netanyahu “Colloqui diretti con i palestinesi”. Il premier israeliano: “Pronti a prenderci rischi”.
3 settembre. “Ci sono distanze incolmabili, remote le possibilità d’intesa”. L’ex negoziatore Usa Miller: troppa sfiducia tra le parti.
16 settembre. La Clinton chiede una svolta: “Israele fermi gli insediamenti”.
25 settembre. Israele, salta il compromesso sulle colonie. Netanyahu pronto a rallentare i nuovi insediamenti. I palestinesi: “Stop o niente negoziati”.
27 settembre. Israele, i coloni lanciano la sfida: “Costruiremo ancora, è casa nostra”. Scade il blocco degli insediamenti. Netanyahu: “Il dialogo continui”.
28 settembre. Colonie, gli Usa criticano Netanyahu. “Delusi per la ripresa dei cantieri. Gaza, uccisi tre palestinesi:”Raid israeliano”.
16 ottobre. Gerusalemme-Est, via a nuovi insediamenti. Netanyahu sblocca 240 alloggi. I palestinesi: ucciso il negoziato. Condanna degli Usa.
Il resto è silenzio!
Ottobre 2010

![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore) al 10-05-2016
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore) al 10-05-2016