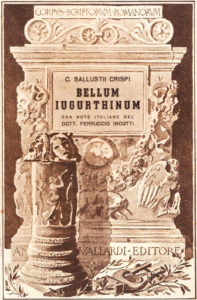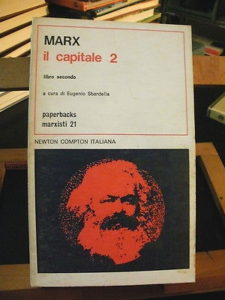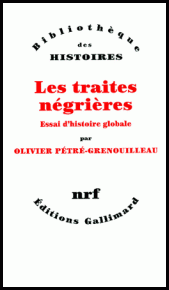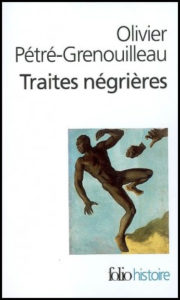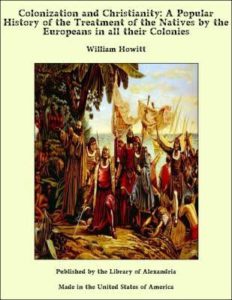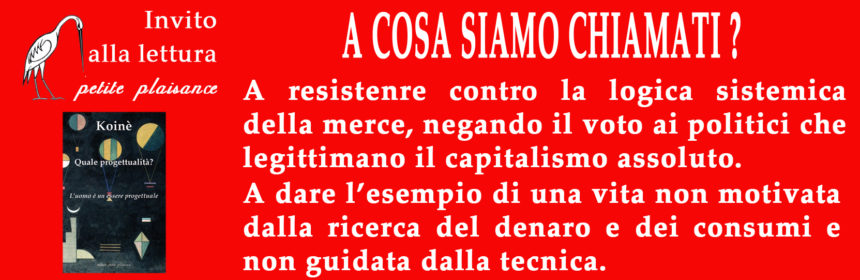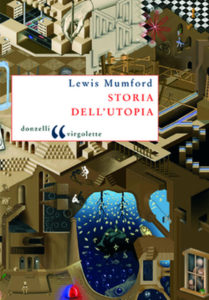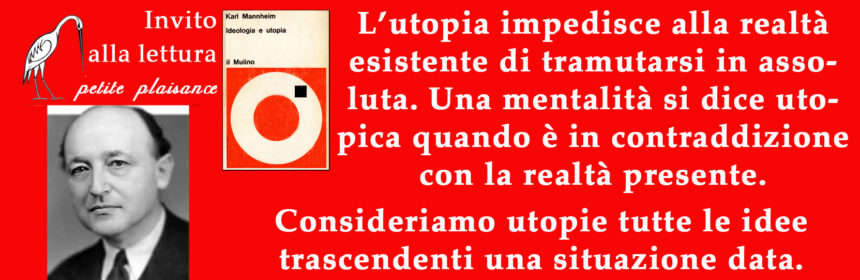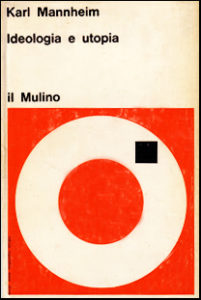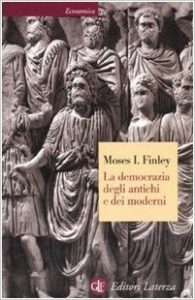[…] Non ci sono dubbi che la nozione di intellettuale organico debba essere superata. […] l’obbiettivo della rivoluzione è stato accantonato dagli eredi di Gramsci e la vita «provvisoria» entro le strutture pluralistiche pare diventata definitiva. Nonostante questo, la macchina e l’intellettuale di Gramsci sono sopravvissuti. È sopravvissuto un rigido apparato di persuasori senza più alcuno scopo, se non la sua stessa riproduzione su scala allargata, entro questa società. […]
[…] Non ci sono dubbi che la nozione di intellettuale organico debba essere superata. […] l’obbiettivo della rivoluzione è stato accantonato dagli eredi di Gramsci e la vita «provvisoria» entro le strutture pluralistiche pare diventata definitiva. Nonostante questo, la macchina e l’intellettuale di Gramsci sono sopravvissuti. È sopravvissuto un rigido apparato di persuasori senza più alcuno scopo, se non la sua stessa riproduzione su scala allargata, entro questa società. […]
Quel che mi preme è che esso venga riconosciuto come autentico problema con tutte le sue conseguenze:
1) che l’intellettuale non-conformista – per svolgere la sua funzione – deve militare fuori dei partiti burocratizzati, ed eventualmente contro di essi;
2) che questa sua funzione non può essere svolta per intero senza un rapporto organico con le masse;
3) che un rapporto organico con le masse non richiede la mediazione dei partiti.
Il ruolo dei partiti nella società contemporanea. Ho tentato di mettere in luce il loro crescente contrasto con la società civile, conseguente allo sviluppo di strutture burocratiche rigide ai loro vertici. Dato che i partiti costituiscono l’asse della così detta vita democratica, questo contrasto mi sembra dovrebbe essere sufficiente a raffreddare gli entusiasmi di tutta la sinistra verso l’attuale sistema democratico-parlamentare e indurli a riflettere seriamente sui modi del suo superamento. È qui che entra in gioco l’analogia – da un lato – tra teorie scientifiche e patrimonio scientifico-tecnico, e – dall’altro – tra ordinamenti giuridici e società civile. La pretesa di assolutizzare l’ordinamento odierno con le sue libertà formali e assumerlo come criterio per valutare tutte le altre società, è tanto regressiva quanto quella di assumere una particolare teoria scientifica, per quanto potente e riuscita, come punto di arrivo insuperabile. Così come è l’impatto del patrimonio scientifico-tecnico a vanificare le seconde, allo stesso modo è l’impatto della società civile a vanificare le prime. Nel caso in esame, è la crescente incapacità dei partiti di valorizzare e utilizzare l’iniziativa di individui e di gruppi che non accettano di inserirsi nelle loro burocrazie, e – quel che è peggio – la loro tendenza a soffocare questo tipo di iniziative.
Non c’è in questa tua posizione una polemica implicita contro la nozione di intellettuale organico di Gramsci?
Non ci sono dubbi che la nozione di intellettuale organico debba essere superata. Era una nozione perfettamente coerente con la visione del partito di Gramsci, di un partito che doveva bensì vivere provvisoriamente entro le strutture pluralistiche della «democrazia» borghese, ma la cui vera funzione era quella di rovesciarle per instaurare la dittatura del proletariato. La sua struttura doveva quindi riflettere questa funzione senza lasciarsi «corrompere» dall’ambiente in cui provvisoriamente doveva operare. Dato che – in una società complessa come quella italiana – questa macchina per la rivoluzione non avrebbe potuto dare tutti i suoi frutti senza il «consenso», a questo dovevano pensare gli intellettuali.
Ma l’obbiettivo della rivoluzione è stato accantonato dagli eredi di Gramsci e la vita «provvisoria» entro le strutture pluralistiche pare diventata definitiva. Nonostante questo, la macchina e l’intellettuale di Gramsci sono sopravvissuti. È sopravvissuto un rigido apparato di persuasori senza più alcuno scopo, se non la sua stessa riproduzione su scala allargata, entro questa società. E gli altri partiti, quelli a così detta «struttura interna democratica», hanno più o meno seguito questo esempio. Una delle conseguenze di siffatto processo di subordinazione di tutte le istanze della vita civile, sia culturale che economica, è stata da un lato l’eclisse di ogni creatività intellettuale – con l’eccezione forse del campo della ricerca scientifica in senso stretto, proprio perché questa è finora riuscita a conservare una organizzazione autonoma rispetto ai partiti – e dall’altro l’avvio di un’economia assistita e clientelare in cui i parametri decisionali sono costituiti quasi esclusivamente dagli interessi delle strutture burocratiche dei partiti.
Dunque – al livello delle strutture profonde – un’evoluzione per certi versi analoga a quella dell’Unione Sovietica.
Non credo infatti che dobbiamo farci ingannare dalla schiuma di superficie. Certo, in Italia gli intellettuali discutono, polemizzano, dissentono liberamente, ma entro ben determinati limiti e per lo più in forme puramente retoriche. Mancano, a ben guardare, sia un’autentica creatività intellettuale sia una seria possibilità di interventi efficaci – sulle strutture della società – al di fuori di quelli voluti dai vertici dei partiti. Con una sola differenza rispetto all’URSS: i sovietici hanno bisogno della polizia per ottenere il conformismo; noi siamo più maturi, ne abbiamo meno bisogno. Inoltre, anche per quanto riguarda l’URSS, le ragioni di questa degenerazione vanno cercate nella transizione dal partito di lotta di Lenin al partito di governo di Stalin senza che la struttura interna del partito venisse mutata in vista del cambiamento di funzioni.
In questo spazio interamente coperto dai partiti – che tendono a fungere quali partiti di governo – come dovrebbe muoversi l’intellettuale non-conformista?
Può ben darsi che questa specie – dopo la sua stagione d’oro nel ‘700 – sia ormai in via di estinzione … Alcuni esemplari sopravvivono ancora in quello spazio che fino ad oggi meno ha subito la pressione dei partiti, e cioè l’Università. Certo in Italia la situazione è peggiore che in Francia o in Inghilterra. Non è affatto escluso che la degradazione in cui l’Università è stata spinta dalla complicità di tutti i partiti sia stata un modo indiretto per piegare queste resistenze, per far scomparire queste zone di relativa libertà di ricerca. Ma anche se riuscissimo a salvare queste «zone franche», difficilmente la funzione dell’intellettuale non conformista potrebbe esaurirsi entro di esse. Senza un rapporto organico con le masse, si regredisce alla figura dell’intellettuale di tipo illuminista che è del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di società come le nostre in cui il ruolo delle masse è decisivo.
Ma le masse sono nei partiti. Dunque un rapporto con le prime deve passare attraverso i secondi. Fuori dai partiti, fuori dalle masse?
Non lo credo affatto. Quel che la Chiesa prima, e poi quei suoi moderni sostituti che sono i partiti (nel senso sopra accennato del termine), hanno tentato di fare sistematicamente, è stato di liquidare i movimenti di massa, o reprimendoli o riassorbendoli. Ciò mostra l’esistenza di una profonda frattura tra partiti e masse.
Ma non è affatto chiaro come l’intellettuale non-conformista possa occupare questo spazio vuoto.
Per questo problema non ho soluzioni. Quel che mi preme è che esso venga riconosciuto come autentico problema con tutte le sue conseguenze:
1) che l’intellettuale non-conformista – per svolgere la sua funzione – deve militare fuori dei partiti burocratizzati, ed eventualmente contro di essi;
2) che questa sua funzione non può essere svolta per intero senza un rapporto organico con le masse;
3) che un rapporto organico con le masse non richiede la mediazione dei partiti.
Sotto quale forma possa organizzarsi questo rapporto e in che modo debba svolgersi questa militanza fuori dai partiti burocratizzati, questo è un problema aperto. Ma – ripeto – non riusciremo mai a risolverlo senza rico noscerlo come tale, chiaramente, spregiudicatamente.
Ludovico Geymonat, Paradossi e rivoluzioni. Intervista su scienza e politica, a cura di Giulio Giorello e Marco Mondadori, il Saggiatore, 1979, pp. 126-129.
«Ludovico Geymonat, un intellettuale “indisciplinato” rispetto all’ortodossia dei partiti che per varie ragioni respingevano – spesso in modo sbigativo – atteggiamenti autonomi, proposte innovative e di critiche alla cultura […]». Mario Quaranta
Ludovico Geymonat
Nato a Torino l’11 maggio 1908, deceduto a Rho (Milano) il 29 novembre 1991, filosofo e matematico. È considerato uno dei più importanti filosofi italiani del Novecento. Di famiglia valdese, si era laureato in filosofia all’Università di Torino nel 1930 e, due anni dopo, aveva conseguito la laurea in matematica. Durante il ventennio, avendo rifiutato di iscriversi al PNF, gli fu preclusa la carriera accademica; si mantenne insegnando in scuole private.

Nel 1942, Geymonat aderì al Partito comunista clandestino e, dopo l’armistizio, fece della sua casa di Barge il centro organizzativo delle Brigate Garibaldi della zona.
I fascisti lo arrestarono nel novembre del 1943, ma il professore, incarcerato a Saluzzo, fu rilasciato per mancanza di prove. Prese così la strada dei monti e, con il nome di copertura di “Luca Ghersi”, divenne commissario politico della 55° Brigata “Carlo Pisacane”, operante nella valle del Po.
Dopo la Liberazione, Geymonat (che fu capo redattore dell’edizione piemontese de l’Unità e assessore al Comune di Torino), intraprese l’insegnamento universitario.
Dal 1956 al 1978, tenne all’Università di Milano la prima cattedra di Filosofia della scienza istituita in Italia. Partecipò anche alla fondazione del Centro di Studi metodologici di Torino e, nel 1963, cominciò a dirigere la collana di classici della Scienza, della Casa editrice UTET.
Negli ultimi anni della sua vita, Geymonat lasciò il PCI, si avvicinò a Democrazia Proletaria e aderì, infine, al Partito della Rifondazione Comunista. Grande divulgatore della storia della filosofia (molto diffuso nei Licei il suo manuale Storia del pensiero filosofico e scientifico), Geymonat ha lasciato molte importanti opere. Ricordiamo: Il problema della conoscenza nel positivismo (1931), La nuova filosofia della natura in Germania (1934), Studi per un nuovo razionalismo (1945), Saggi di filosofia neorazionalistica (1953), Galileo Galilei (1957), Filosofia e filosofia della scienza (1960), Scienza e realismo (1977). Di Geymonat sono anche i sette volumi della Storia del pensiero filosofico e scientifico, scritti tra il 1970 e il 1976. Del 1974 è Attualità del materialismo dialettico, in collaborazione con Bellone, Giorello e Tagliagambe e, del 1986 (con Giorello e Minazzi) Le ragioni della scienza.

Geymonat e Dal Pra. Foto Vito Panico – Copyright Vito Panico.
Si può accedere ad ogni singola pagina pubblicata aprendo il file word
 Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 10-02-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 10-02-2018)
N.B. Le immagini e i video sono stati reperiti nel web e quindi considerati di pubblico dominio. Qualora si ritenesse che possano violare diritti di terzi, si prega di scrivere al seguente indirizzo: info@petiteplaisance.it, e saranno immediatamente rimossi.
Seguici sul sito web
 ***********************************************
***********************************************

«Namque pauci libertatem, pars magna iustos dominos volunt». «Soltanto pochi desiderano la libertà. I più non cercano che buoni padroni».
![]() Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 25-02-2018)
Indice completo delle pagine pubblicate (ordine alfabetico per autore al 25-02-2018)